
Insegnante dice parolacce a lezione (Dall-E)
Funzionano le parolacce a scuola? Nei mesi scorsi, mentre tenevo il workshop “Parolacce e comunicazione” all’università Iulm di Milano, alcuni lettori di questo blog (insegnanti compresi) mi hanno rivolto questa domanda. Avevo già affrontato l’argomento in un articolo di qualche anno fa. Ne parlo di nuovo oggi, alla luce delle ricerche uscite nel frattempo.
Parto da una considerazione di fondo: non c’è, e non può esserci, una risposta univoca alla domanda se sia efficace usare il turpiloquio a lezione, perché è troppo generica. Le “parolacce”, infatti, includono un ventaglio di espressioni che vanno dagli insulti alle espressioni colloquiali, dalle oscenità alle imprecazioni: in questa categoria, insomma, rientrano espressioni bonarie e spiritose ma anche offese molto pesanti. Come dico sempre, le parolacce sono come coltelli: si possono usare per ferire ma anche per sbucciare una mela.
Ed è troppo vago anche il pubblico dei destinatari: gli studenti possono andare dai 6 ai 24 anni d’età, dalla prima elementare all’università: persone con sensibilità e maturità emotiva molto diverse fra loro. Sarebbe inaccettabile usare espressioni oscene con bambini di prima elementare, così come sarebbe fuori luogo utilizzare l’umorismo infantile “da gabinetto” con un pubblico di 20enni.
Resta il fatto che il turpiloquio è un linguaggio molto potente, e sarebbe troppo sbrigativo limitarsi a censurarlo in un’epoca come la nostra, in cui le parolacce sono onnipresenti e destano meno scandalo d’un tempo. A maggior ragione se ci si rivolge a un pubblico di adolescenti, che sono – da sempre – i più scurrili: il linguaggio sboccato potrebbe essere una via diretta per entrare in confidenza con loro.
Una scelta a due facce
In generale, secondo le ricerche, usare un linguaggio volgare è una scelta a due facce: non è mai completamente vantaggiosa, ma neppure totalmente svantaggiosa. A seconda di come viene attuata, infatti, può avere effetti positivi o negativi. Ecco quali:
| effetti positivi | effetti negativi |
|---|---|
| il turpiloquio è un linguaggio sincero, diretto e spontaneo (se usato abitualmente e non come atteggiamento costruito “a tavolino” per strizzare l’occhio al pubblico) | fa perdere autorevolezza |
| accorcia le distanze, creando un clima confidenziale e informale | fa apparire meno competenti / professionali |
| attira l’attenzione | fa apparire incapaci di controllarsi |
Gli insegnanti, ma anche i comunicatori, i formatori, chi tiene una conferenza, dovrebbero sempre tener presente questa tabella quando valutano se usare o meno il linguaggio scurrile. Ci sono “pro e contro” in ogni caso: la differenza la fa il “perché” e il “come” sono usate. Ovvero, gli scopi comunicativi. Come ricorda Emily Mullins della Wichita State University «le parolacce non sono in sè un problema: tutto dipende dall’intenzione con cui sono utilizzate». O, come diceva Italo Calvino, le parolacce possono dare un particolare effetto musicale nella “partitura” del discorso: quindi, sono efficaci se al servizio di una narrazione, di un preciso scopo comunicativo.
Ma oltre all’efficacia, c’è anche un altro aspetto di cui tenere conto quando si parla di parolacce a scuola: l’opportunità. L’insegnante è un educatore, e come tale deve dare il buon esempio: dire parolacce rischia di minare gli intenti educativi e la propria autorevolezza. Dunque deve essere un’eccezione e non la regola: una scelta che va commisurata all’età e alla maturità degli studenti, per non rischiare sgradevoli equivoci o che degeneri il clima in classe. Possiamo affermare, in termini generali, che la scelta di dire parolacce a scuola sia diseducativa in modo inversamente proporzionale all’età degli studenti: ovvero, è tanto più diseducativa quanto più è giovane l’età degli studenti.
Cosa dicono le ricerche

Parolacce in una conferenza (Dall-E)
Che cosa hanno scoperto gli studi sull’uso delle volgarità a lezione? Gli insulti («asino») e le maledizioni («vaffa») hanno effetti negativi perché sono aggressivi e umiliano il destinatario, abbassandone l’autostima. Dirli in modo bonariamente ironico ne attenuerebbe l’offensività, ma sono sempre un azzardo da evitare.
Le imprecazioni (“porca vacca”), rivolte a se stessi o agli strumenti di lavoro, danno un’immagine di aggressività e di “incontinenza emotiva” e sono percepite in modo negativo se sono reiterate. Un conto è imprecare perché un libro voluminoso ti cade sul piede, un altro è imprecare come un marinaio ogni volta che la lavagna luminosa non funziona.
«Gli insegnanti non dovrebbero imprecare davanti gli studenti per mostrare la loro frustrazione, poiché questo comportamento può essere visto come aggressivo. E l’aggressività degli insegnanti è negativamente associata all’apprendimento e alla soddisfazione degli studenti», sottolinea Mark Generous, docente di comunicazione alla California State Polytechnic University.
Il discorso cambia se lo scopo delle parolacce è quello di fare una battuta umoristica, enfatizzare un concetto, o attirare l’attenzione: in questo caso, le volgarità possono essere percepite in modo positivo. «Le parolacce inserite nel contenuto del corso, per enfatizzare, attirare l’attenzione o rendere più chiaro un concetto sono percepite come più appropriate rispetto ad altre categorie», sottolinea ancora Generous. Con una precisazione importante: le battute di spirito “salaci” rischiano di far sembrare il docente «uno che si atteggia, che vuole cercare di fare il simpatico usando il linguaggio dei giovani»: dunque, meglio non avventurarsi su questo terreno se non si ha un senso dell’umorismo collaudato.
Escludendo insulti e maledizioni, insomma, gli studenti, in genere, «hanno sentito gli insegnanti più vicini dopo che hanno detto una parolaccia. Si sono sentiti più a loro agio nel parlare con l’insegnante sia dentro che fuori la classe», dice Mullins. Le parolacce, come abbiamo detto sopra, se usate con intelligenza accorciano le distanze e creano un clima più informale e spontaneo.
Le conclusioni
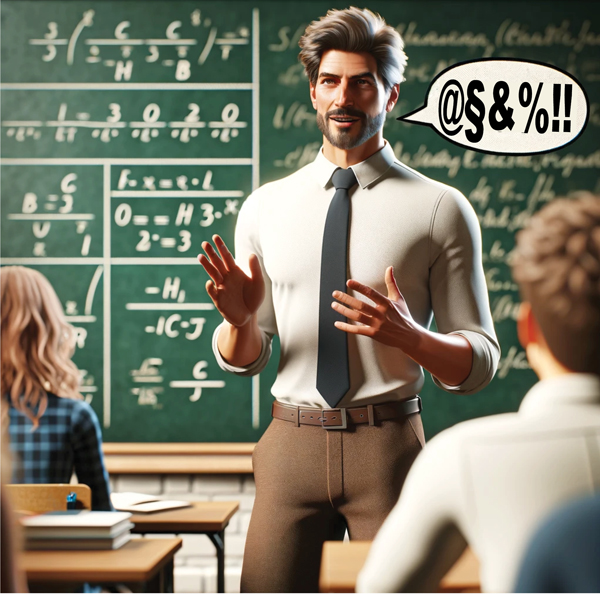
Ci sono parolacce e parolacce. Ma conta di più lo scopo per cui si dicono (Dall-E)
In sintesi, conclude Generous, «mentre l’uso del linguaggio volgare da parte degli insegnanti non è intrinsecamente negativo, la sua percezione da parte degli studenti e l’impatto sul loro apprendimento e benessere emotivo dipendono fortemente dal contesto, dalla funzione e dall’obiettivo delle volgarità. Gli insegnanti dovrebbero essere consapevoli delle possibili implicazioni del loro linguaggio e cercare di mantenere un ambiente di apprendimento rispettoso e incoraggiante».
«Gli insegnanti che scelgono di usare parolacce» aggiunge «dovrebbero farlo con giudizio e con uno scopo chiaro, collegandole al contenuto del corso per enfatizzare, chiarire concetti o attirare l’attenzione».
Non si potrebbe dirlo meglio: non esistono formule preconfezionate, parolacce consentite o proibite in quanto tali (escluse ovviamente quelle più offensive). Esistono invece scopi comunicativi e contesti (le personalità e le età degli studenti) che vanno valutati di volta in volta.
I contesti, come sempre, fanno la differenza. Come gestire il turpiloquio in una scuola che sorge in un quartiere disagiato? Provate a immaginare una classe come quella del film “Io speriamo che me la cavo” (1992). Un’opera di fantasia, per quanto ispirata da alcuni temi raccolti dal maestro Marcello D’Orta fra gli alunni delle elementari di Arzano (Napoli), con un linguaggio insolitamente scurrile. Come comportarsi con una classe del genere? Scandalizzarsi sarebbe ridicolo, ma usare il turpiloquio significherebbe dare un pessimo esempio. E ancor più difficile se ci si trova a insegnare in un carcere minorile.
In tutti questi casi, il turpiloquio è legato a un lessico povero e limitato: la vera sfida, in questo caso, più che strizzare l’occhio alle volgarità, è allargare la prospettiva dei ragazzi, insegnando parole e pensieri alternativi.
Non è semplice studiare il turpiloquio. Le simulazioni (una lezione in cui un finto professore dice parolacce) non sono uno specchio fedele delle vere lezioni in aula, nelle quali l’interazione, il rapporto si costruisce giorno dopo giorno. Le ricerche che hanno trovato i risultati più interessanti sono stati dei “focus group” in cui le persone ricordavano episodi in cui un loro insegnante aveva detto espressioni scurrili. In ogni caso, è bene ricordarlo, i risultati degli studi offrono un quadro parziale su un tema così ampio e complesso.Inoltre, ogni cultura e ogni epoca possono avere sensibilità molto diverse sul turpiloquio. Quello che è inaccettabile per uno statunitense, potrebbe essere accettabile per un italiano e viceversa; ciò che era tabù ieri potrebbe non esserlo più oggi.
Fatte queste distinzioni, ecco i principali studi che ho consultato per scrivere questo post:
♦ Karyn Stapleton “Swearing and perceptions of the speaker: A discursive approach”, Journal of Pragmatics 170 (2020) 381e395
♦ Mark A. Generous, Seth S. Frei, & Marian L. Houser “When an Instructor Swears in Class: Functions and Targets of Instructor Swearing from College Students’ Retrospective Accounts”, Communication Reports Vol. 28, No. 2, July–December 2015, pp. 128–140
♦ Mark A. Generous & Marian L. Houser “Oh, S**t! Did I just swear in class?”: Using emotional response theory to understand the role of instructor swearing in the college classroom”, Communication Quarterly, 67(2), 178–198, 2019
♦ Emily Mullins, “Watch your mouth: swearing and credibility in the classroom”, Bachelor of Arts, Wichita State University, 2020