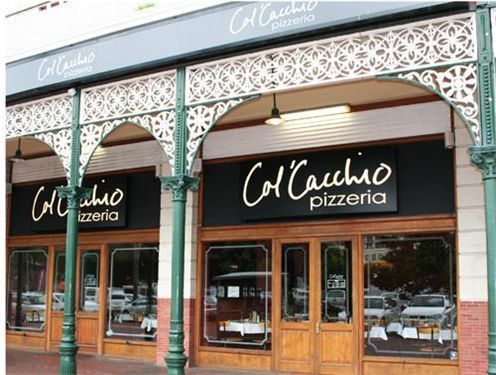
La pizzeria “Col cacchio” aperta da italiani in Sud Africa.
“Caspita, mi hai rotto i cosiddetti!! Ma vaffancuore!!”. Diciamo la verità: gli eufemismi – le versioni addolcite delle parolacce – sono ridicoli. Come le foglie di fico nei dipinti di nudo, tentano di nascondere le “vergogne”, ma così le fanno risaltare ancor di più. E, nel loro essere così artificiosi e innaturali risultano un po’ patetici. Con l’aggravante che spesso gli eufemismi sono usati dagli ipocriti per mascherare le loro cattive azioni o intenzioni.
Eppure, a ben guardare, questi surrogati verbali sono un’invenzione straordinaria: nella nostra lingua sono circa 200 e si possono usare in 6 modi diversi, non solo per censurare o mistificare la verità ma anche per varie forme di delicatezza. Studiarli, anzi, è affascinante perché sono come un trattato di sociologia: svelano le nostre fobie più nascoste.
In questo articolo solleveremo queste foglie di fico linguistiche per vedere che cosa nascondono. Racconteremo la lunga, insospettabile storia degli eufemismi; sveleremo come si costruiscono, quanti sono nel dizionario e quali concetti cercano di camuffare. E ascolteremo i divertenti eufemismi consigliati da Elio e le storie tese.
Infine, potrete leggere la lista dei 79 eufemismi più spassosi della nostra lingua, con un gioco: dovrete indovinare quale parolaccia sostituiscono. Insomma, un test per mettere alla prova la vostra cultura: sapete il significato originario di alcune espressioni come cacchio? E perché ci sono così tanti vegetali (cavolo, capperi, corbezzoli…) in questo elenco?
La storia

L’osteria “Maremma maiala“: non è in Toscana ma in provincia di Cremona.
Partiamo dalla loro storia: quando sono stati inventati gli eufemismi, e perché? Sono nati ben prima del galateo e delle buone maniere. Gli eufemismi (dal greco “parlar bene”) infatti erano già presenti nelle società primitive, che credevano nel potere magico delle parole. Nelle civiltà più antiche i nomi non erano soltanto simboli, ma erano “l’anima” delle cose: chi conosceva il nome d’un essere l’aveva in suo potere. Per questo, i nomi delle divinità e quelli dei defunti erano tabù: non si potevano pronunciare, perché dicendoli si sarebbero evocati quegli spiriti. Così furono inventati termini allusivi ma neutri, da usare nelle conversazioni al posto di quelli “pericolosi”. Dunque, gli eufemismi sono nati in campo religioso.
Con l’umanesimo e il cristianesimo, a questi nomi se ne sono aggiunti altri: quelli del sesso e delle parti del corpo, per motivi di pudore e di etica. Infine, nell’ultimo secolo, sull’onda del “politicamente corretto”, ne sono nati altri per difendere alcune categorie sociali svantaggiate (come “non udente” al posto di “sordo”) ma anche per propaganda politica o economica: come l’espressione “adeguamento tariffario” invece di “aumento”, “riduzione di organico” invece di “licenziamento”.
I modi di usarli
Questa lunga e ricca stratificazione ha aumentato gli ambiti d’uso degli eufemismi. Si usano in 6 modi:
- con i bambini: sono parole depotenziate, disinfettate. Sono come armi giocattolo, pistole col tappino rosso: “Accipicchia, sei proprio un monello!”.
- per scrupoli religiosi: si utilizzano per non peccare, sono come preservativi linguistici per non contaminarsi con contenuti tabù. Sono una forma di autocensura: “Cribbio, mi avete stufato!”.
-
![shutterstock_18364909]()
Gli eufemismi sono come pistole giocattolo (foto Shutterstock).
per scrupoli sociali: si usano davanti ad estranei, o superiori, o anziani. Insomma, quando non si vuole rischiare di urtare la sensibilità di qualcuno. Si usano per decenza, convenienza, cortesia, tatto: sono una frenata in extremis, uno slalom morale, un modo di indorare la pillola, un lifting delle parole. “Penso che Franca faccia la escort” (invece di “puttana”). Gli eufemismi sono messaggi in codice, strizzate d’occhio: “io ti dico mezza verità, ma sappiamo entrambi che è una foglia di fico che nasconde ben altro”.
- per blocchi psicologici: gli eufemismi sono usati per timidezza o inibizioni morali. li usano le persone represse, sono l’espressione del “vorrei ma non posso”: “Ma vaffancuore!”.
- per educazione, autocontrollo: gli eufemismi sono come non mangiare con la bocca aperta o non ruttare. Svolgono una funzione importante: esprimono rabbia, ma lo fanno in una maniera socialmente accettabile, mostrando che chi li dice sa controllare i propri impulsi. Sono un compromesso fra espressione e censurta, un messaggio in codice fra gentiluomini (o donne). Insomma, gli eufemismi sono come la valvola di una pentola a pressione, fanno sfiatare il vapore in eccesso: “Fiiiischia che roba!”. L’opposto è dell’eufemismo è infatti il disfemismo, ovvero dire le cose nude e crude: per esempio “i miei vecchi” al posto di “i miei genitori”
- per ipocrisia e mistificazione: sono un forma di contrabbando, tentano di far passare di sottecchi qualcosa di inaccettabile. Invece di ammettere di aver rubato truccando i bilanci, si dice “Ci sono delle irregolarità contabili”.
Quei geniacci di “Elio e le storie tese” hanno fatto un intervento molto divertente proponendo dei nuovi eufemismi (parole di senso compiuto) che sembrano bestemmie, “da utilizzare nelle barzellette estreme per non urtare la sensibilità dell’elettore cattolico”: le potete ascoltare cliccando il video qui sotto.
Quanti sono e cosa nascondono
Quanti sono gli eufemismi in italiano? Il modo più scientifico di calcolarli è estrapolare le parole contrassegnate come “eufemismo” (alla voce “limite d’uso”) nel dizionario. Io ho usato lo Zingarelli su Cd-Rom. Nel mio libro ne ho censiti 172; nel 2011 erano saliti a 185, nel 2012 la linguista tedesca Ursula Reutner – direttrice del Centro linguistico all’Università di Passau, in Germania – ne ha trovati 240. Nell’ultimo, lo Zingarelli 2017 (pubblicato quest’anno) gli eufemismi sono 183: da “abile” (nella locuzione “diversamente abile“) a “zio” .
Perché queste variazioni? Innanzitutto perché la lingua è viva e sempre in evoluzione, e i dizionari lo registrano: la loro crescita altalenante può essere l’effetto del “politicamente corretto”, che ha aumentato la nostra sensibilità (e quindi le forme di censura) su molte parole.

Commedia erotica di Alfredo Rizzo (1976).
Ma, come ha notato la professoressa Reutner, non è facile censire gli eufemismi: “ad esempio, lo Zingarelli non marca come eufemistiche diverse espressioni che lo sono (come audioleso e fuoco amico). Nei dizionari la stessa espressione può essere marcata come eufemistica in un punto e non in un altro”. Anche perché molti eufemismi diventano tali in espressioni composte: “casa” e “chiusa” non sono termini eufemistici presi singolarmente; ma l’espressione che li unisce, “casa chiusa“, è un eufemismo di bordello. Per questo, i censimenti di queste parole sono approssimativi.
E di cosa parlano gli eufemismi? Degli aspetti più delicati della nostra vita, come si può vedere da questa interessante statistica stilata dalla professoressa Reutner:
- il 23,3% delle espressioni eufemistiche riguardano la vita e gli atti sessuali (escort/puttana, rapporti intimi/ trombare);
- il 20,4% riguardano la morte (passare a miglior vita/crepare, mancare/schiattare);
- un altro 19,2% le parti del corpo (fondoschiena/culo, scatole/coglioni);
- l’11,3% riguarda Dio e diavolo (vivaddio/bestemmia);
- il 7,5% i bisogni fisiologici (andare di corpo/cagare);
- il 5,4% soldi e lavori (ritocco tariffario/aumento, lavoretto/lavoro umile);
- 5,4% qualità fisiche e mentali, comportamenti (robusto/grasso, maturo/vecchio);
- 5%, malattia (male incurabile/cancro, non udente/sordo);
- 2,5% biologia femminile (stato interessante, avere le cose).

Borsa di “Mani in pasta“, associazione culinaria.
Come nascono gli eufemismi? La nostra lingua usa 4 stratagemmi: l’omissione (non dire il termine scottante), la modificazione, la sostituzione con altri termini o l’abbreviazione.
Nella maggior parte dei casi (il 78%) gli eufemismi nascono per sostituzione: si mette una parola accettabile al posto di una inaccettabile (andare a letto con qualcuno invece di scopare con qualcuno). Solo nell’1% dei casi sono abbreviazioni (poffare sta per “può fare Dio”). Per chi vuole approfondire questi 3 stratagemmi – che hanno molte e ingegnose varianti – rimando al mio libro, dove ne ho parlato più diffusamente.
In questo articolo, invece, mi concentro sulle deformazioni: ovvero gli eufemismi che nascono per alterazione fonetica (“sostituti parafonici”), salvando la prima sillaba e mutando le successive, oppure cambiando o sopprimendo l’iniziale. Gli eufemismi di questo tipo sono il 21%: ho scelto di approfondirli non solo perché sono i più usati nella lingua parlata al posto delle parolacce, ma anche perché sono i più divertenti.
La lista degli eufemismi
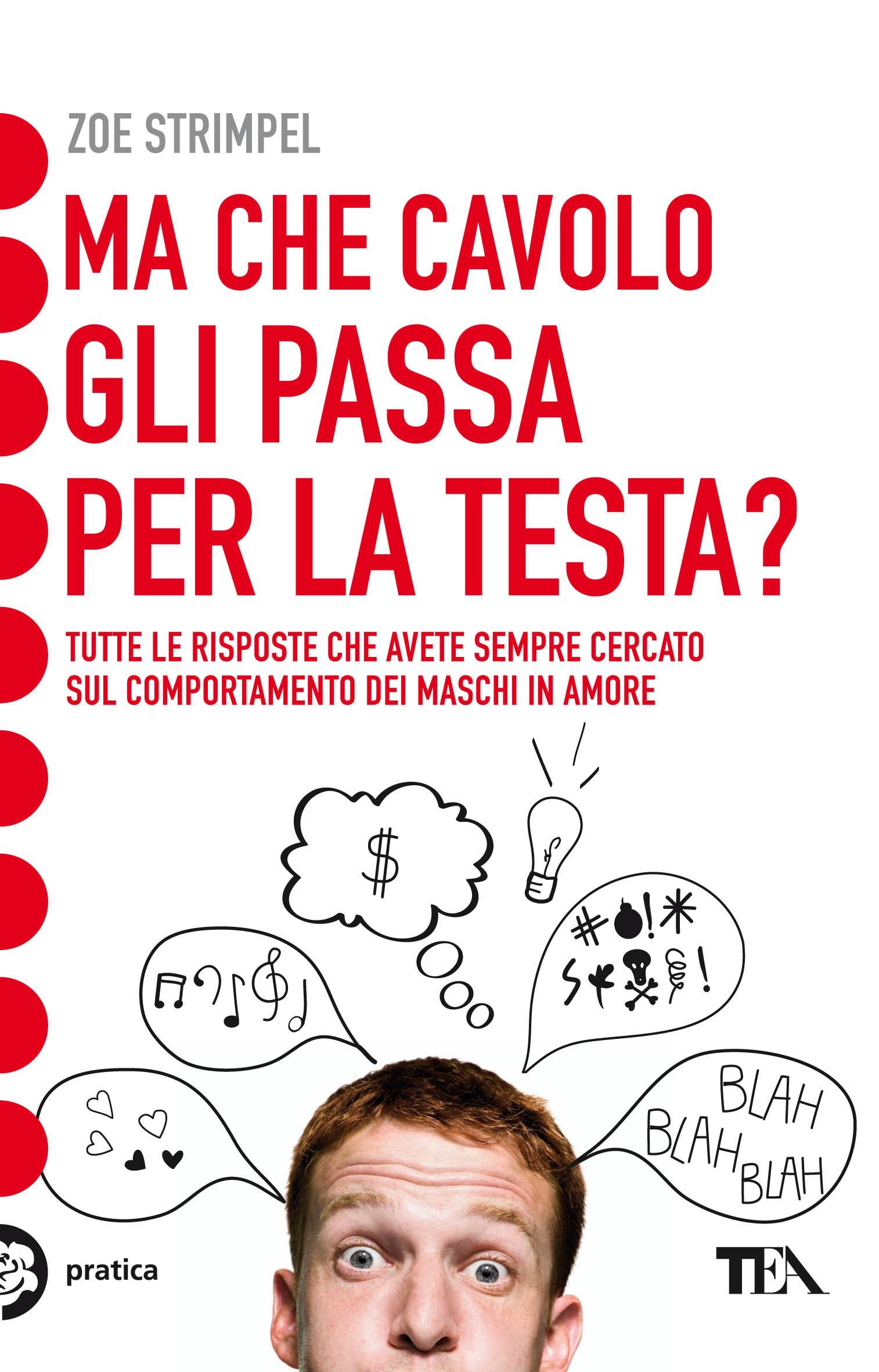
Un libro ammiccante ma “educato”.
Come leggerete nella lista qui sotto, molti degli eufemismi sono parole che rimandano a ortaggi e frutta: cavolo, capperi, cacchio, corbezzoli, sorbole. Ma perché? Secondo la Suda, un’antica enciclopedia greca, nell’antichità “molti, per dare forza ai propri giuramenti”, giurano sugli ortaggi: non tanto per evitare di nominare invano i nomi delle divinità, quanto per sdrammatizzare.
Come ricorda Paolo Martino, docente di linguistica alla Lumsa di Roma, in un divertente saggio sull’esclamazione “capperi!”, Radamanto, il giudice dell’Averno, ordinò che si giurasse non sugli dèi, ma su piante e animali domestici. Tanto che nell’antichità si giurava “per il cane” (da cui l’esclamazione “porco cane”, di cui ho parlato in questo articolo), “per l’oca” (da cui il “porca l’oca” usato ancora oggi), ma anche “per il cavolo”, “per il cappero”. Dunque, questi sostituti sono stati scelti non solo per assonanza con “cazzo” ma anche perché avevano già una lunga storia linguistica. D’altronde, avevo già parlato in un altro articolo dell’importanza simbolica dei vegetali come sostituti sessuali, sia nelle immagini che nel linguaggio.
Dunque, ecco la lista dei più frequenti eufemismi parafonici: sono 79, e non tutti li trovate sullo Zingarelli, perché a volte i dizionari non riescono a registrare tutti i termini colloquiali. Qui sotto potete mettere alla prova la vostra cultura: sapete davvero che cosa si nasconde dietro queste “foglie di fico”? Basta fare caso alle lettere iniziali… Se non riuscite a indovinarli, niente paura: cliccate sulla striscia blu col segno “+” per espandere il box e scoprire che cosa c’è sotto, avrete qualche sorpresa, cazzarola! Per i casi più curiosi (segnalati dagli asterischi *) ho inserito anche una breve spiegazione sull’origine del termine.
A
accidempoli, acciderba, accipicchia*, acc
alimortè
ammappelo/ammappalo, ammappete, ammazza
azzolina, azzo
B
boia d’un diavolo, bòia d’un dìèvel
C
cacchio*, canchero, capperi/o, caspita, caspiterina, cavolo, cazzarola, cazzica, corno
caramba, carramba
che pizza
corbelli*, corbezzoli**, cordoni, cosiddetti
cribbio, Cristoforo Colombo, cristallo
D
della malora
diacine, diamine*,
dio cantante, dio caro, dio campanaro
dioniso, Diogene, Diomede
F
fischia
I
incavolarsi, incacchiarsi
K
kaiser
M
madosca, malora
Maremma*, Maremma maiala
mizzega, mizzica, mizzeca
O
osteria, ostrega, ostrica
P
paravento
parbleu
per dinci, per dindirindina, per Diana
porco zio, porco diesel, porco Diaz*, porco dinci, porco diavolo, porco due
porca paletta, porca puzzola, porca putrella
porca madosca, porca malora
porca trota, porca trottola
S
sorbole*
U
urca
V
vaffa, vaffancuore, vaffanbagno
và a farti frate
Z
zio cane, zio cantante, zio canterino, zio canarino
Dedico questo post all’amico Davide Viganò, che pochi giorni fa mi ha detto: “Vito! Ma perché non fai un post sugli eufemismi?!?”, ricordandomi il loro fascino.
The post Caspita! Gli eufemismi, parolacce col “lifting” first appeared on Parolacce.]]>