
Pubblicità dell’Aquafan di Riccione (2019).
Pochi se ne sono accorti, ma nel campo delle parolacce sta avvenendo una piccola rivoluzione: lo sdoganamento della parola “fico” (o “figo”). Un tempo considerata una parola volgare, usata solo nel gergo giovanile, oggi sta diventando una parola colorita e colloquiale, senza grandi connotazioni scandalose.
Nulla di insolito, per carità: tutte le parole sono vive, e come tali possono morire, risorgere, assumere nuove sfumature, perderle, o rinascere sotto nuove forme. Il che vale ancor più per le parolacce, che possono assumere o perdere connotazioni, ovvero sfumature emotive.
Ma nel caso di “figo” tutto ciò è avvenuto in un modo particolare: per esigenze di traduzione. Il cambio di significato (semantic shift) non è infatti colpa o merito dei politici, una volta tanto. E’ vero che l’ex premier Enrico Letta ha usato l’espressione in più occasioni (“Ero da 48 ore ministro, mi sentivo un gran figo”; oppure, rivolto al Pd: basta fare i fighetti”), ma in realtà lo sdoganamento è stato deciso da altri, in un campo insospettabile: l’intrattenimento per bambini.
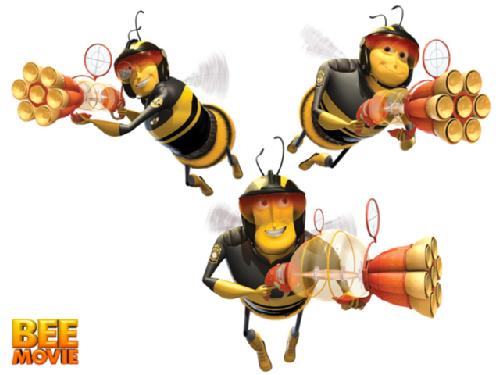
I “fuchi fichi” di “Bee movie” (2007).
Me ne sono accorto guardando con mio figlio i cartoni animati degli ultimi 10 anni: in diversi film d’animazione i personaggi esclamano “fiiico!” per manifestare entusiasmo verso qualcosa di sorprendente, di eccezionale. Pur non essendo un bacchettone, la scelta mi ha colpito: i vecchi cartoni della Walt Disney o della Warner Bros non si sarebbero mai spinti a tanto, almeno fino agli anni ’80 e ’90. Che cosa è accaduto?
E’ accaduto che i traduttori italiani hanno scelto la parola “figo” per rendere in italiano l’aggettivo inglese “cool”. Il significato originario di questa parola è “fresco”: rivolto a una persona significa quindi “distaccato”. Dagli anni ’50, l’aggettivo è stato usato anche per indicare le persone disinvolte, di tendenza, in gamba, anticonformiste, interessanti, eccitanti, alla moda, belle: “fighe”, per l’appunto.
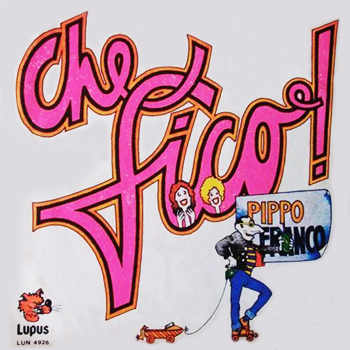
La copertina del brano “Che fico!” di Pippo Franco (1982).
E così, per doppiare i film senza aumentare la quantità di sillabe, i traduttori hanno usato la parola “fico”. Portando a compimento un processo di de-volgarizzazione che in realtà ha radici lontane: ricordate il brano “Che fico” di Pippo Franco? Fu usato persino come sigla del Festival di Sanremo nel 1982, ma il tentativo rimase isolato. Oggi siamo arrivati al punto che “fico” è usato persino come nome di alcuni personaggi in un cartoon: in “Bee movie”, i “pollen jock” (atleti del polline) sono stati tradotti nella versione italiana come “fuchi-fichi”.
Il problema, però, è l’evidente origine sessuale del termine: nato per indicare l’organo genitale femminile, che somiglia a un frutto aperto, è poi passato a indicare (per sineddoche) l’intera persona femminile, diventando anche sinonimo di bellezza e attrattività, usato indistintamente per uomini e donne. Non è certo un caso unico: l’aggettivo “fesso” (scemo, tonto) deriva da “fessa” (fessura), anch’essa una metafora – stavolta con connotazione negativa – per riferirsi ai genitali femminili, proprio come avviene per la parola “con” in francese.
Dunque, i traduttori dei cartoon si sono presi una responsabilità linguistica: sdoganando il termine “fico”, considerandolo adatto alle delicate orecchie dei bambini, l’hanno di fatto inflazionato e depotenziato. Sarebbe stato meglio che lo traducessero con la parola “ganzo” o “forte”?
Forse sì: già ci sono tante parolacce che si stanno inflazionando, e in un’epoca di scarsa attenzione al peso delle parole un po’ più di oculatezza sarebbe raccomandabile, se non vogliamo impoverirci anche nel linguaggio. Non sarebbe molto fico.
 Duemila seicento quindici. 2.615. Tanti sono stati i navigatori che hanno risposto al sondaggio sulle parolacce che avevo lanciato lo scorso 6 aprile. Un risultato che è andato ben oltre le mie più rosee aspettative: quindi, grazie di cuore a tutti quelli che hanno partecipato!!!
Duemila seicento quindici. 2.615. Tanti sono stati i navigatori che hanno risposto al sondaggio sulle parolacce che avevo lanciato lo scorso 6 aprile. Un risultato che è andato ben oltre le mie più rosee aspettative: quindi, grazie di cuore a tutti quelli che hanno partecipato!!!Al sondaggio hanno risposto navigatori da 0 a oltre 60 anni, di tutte le regioni italiane (e anche dall’estero) e livelli culturali: un campione senz’altro ricco e vario, anche se non pretende di essere rappresentativo della popolazione italiana.
Grazie a questi numeri, abbiamo ottenuto una delle indagini linguistiche più corpose mai svolte in Italia, e l’unica a fotografare in modo significativo la percezione delle parolacce, al di là delle impressioni dei singoli.
Quali sono le parolacce più volgari e offensive? E quelle più bonarie?
Ora abbiamo finalmente uno strumento per valutarlo.
Ecco qui sotto il volgarometro (cliccare sull’immagine per ingrandirla), ovvero la classifica delle parolacce a seconda del loro grado di offensività e volgarità percepiti.
Nel 2020 un ricercatore di Manchester, Rob Drummond, ha fatto un’indagine simile sulle parolacce inglesi: la trovate qui.
Dal sondaggio, poi, sono emerse 7 tendenze significative:
1) Se l’insulto è un “giudizio abbreviato”, le accuse sentite come più offensive (quindi più gravi) sono la violazione delle leggi (mafioso, ladro, infame) e i presunti eccessi sessuali (zoccola per le donne, culattone per gli uomini). In quest’ultimo campo, nonostante l’apparente libertà di costumi, prevale ancora una visione maschilista e omofobica. Su questo punto, leggete le precisazioni che ho scritto qui.
2) Scottante anche il rapporto con malattie, morte, bruttezza, disabilità: le maledizioni (augurare malattie, morte o dolore a qualcuno) e gli insulti fisici sono tra le categorie col più alto voto medio. Questi valori sono giudicati più importanti rispetto alla lucidità mentale (rincoglionito) e alla cultura (ignorante).
3) Le singole espressioni che hanno ricevuto in assoluto i punteggi più alti sono le bestemmie, nonostante 1/3 del campione si dichiari ateo. Da notare che, anche se per valori infinitesimali, l’offesa alla Madonna è considerata più grave rispetto a quella verso Dio.
![]()
![]()
 4) I fattori che influenzano maggiormente la percezione delle parolacce sono (in ordine decrescente) l’istruzione, l’età e l’abitudine a dirle; non incidono molto, invece, il sesso, il luogo di residenza e l’orientamento religioso.
4) I fattori che influenzano maggiormente la percezione delle parolacce sono (in ordine decrescente) l’istruzione, l’età e l’abitudine a dirle; non incidono molto, invece, il sesso, il luogo di residenza e l’orientamento religioso.
5) Donne, over 50, meridionali e religiosi sono comunque le categorie più sensibili al turpiloquio: hanno attribuito a molte voci punteggi superiori alla media generale, giudicando con più severità le espressioni legate al sesso, alla morale, alla religione e alla devianza dalle norme.
6) Il 50,4% delle espressioni proposte è stata giudicata dai navigatori “poco volgare o offensiva” (punteggi da 0 a 1,4). Queste parole, di conseguenza, hanno perso buona parte della loro forza espressiva, degradandosi a espressioni colorite e graffianti ma non molto offensive o scandalose: fra queste, terrone, cazzo, merda, va’ a cagare, sfigato, crumiro, buffone, incazzoso, rifatta/siliconata, sbirro, ostia, che palle, ballista. È aumentata l’abitudine alle parolacce, sia per un loro uso più frequente (dal 1999 le parolacce sono state depenalizzate con una legge-delega) sia per effetto del mutare dei valori sociali: tangentaro è oggi considerato molto più offensivo di eretico.
7) Le categorie di insulti giudicate meno pesanti sono, in ordine decrescente, quelli classisti (pezzente, barbone, proletario), quelli etnici (negro, terrone) e quelli religiosi (talebano, bigotto). Il motivo? Oggi le differenze di classe sono diventate più sfumate, e c’è più tolleranza verso le diverse fedi religiose; per quanto riguarda le discriminazioni etniche, sono giudicate meno severamente, probabilmente perché non toccano direttamente gli italiani: i navigatori – con alcuni distinguo – hanno espresso scarsa immedesimazione verso il dramma degli stranieri di non sentirsi accettati e integrati.
Ma a che serve il volgarometro?
Può dare indicazioni utili, oltre che ai linguisti (per valutare se classificare una parola come spregiativa, descrittiva, offensiva…) e ai sociologi (per identificare e spiegare i valori morali e i tabù), anche ai giudici e agli educatori chiamati a esprimersi sulla carica di offensività di vari insulti (che però è determinata anche da altri fattori come il contesto, l’intenzione, il tipo di rapporto).
In mancanza di dati quantitativi, infatti, finora queste valutazioni si sono affidate alla percezione dei singoli, che non necessariamente riescono a fotografare la sensibilità di un’epoca.
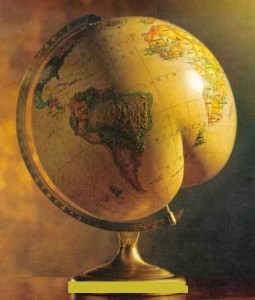 Il volgarometro, inoltre, può essere utile anche ai traduttori. Non sempre, infatti, da una lingua all’altra esistono parolacce di significato equivalente: per esempio, nei Paesi del nord Europa ci sono molte meno espressioni volgari sui temi religiosi e sessuali. Con il volgarometro, i traduttori hanno uno strumento per scegliere parolacce dal significato diverso ma con una carica offensiva equivalente. A patto che siano fatti sondaggi analoghi in altre lingue.
Il volgarometro, inoltre, può essere utile anche ai traduttori. Non sempre, infatti, da una lingua all’altra esistono parolacce di significato equivalente: per esempio, nei Paesi del nord Europa ci sono molte meno espressioni volgari sui temi religiosi e sessuali. Con il volgarometro, i traduttori hanno uno strumento per scegliere parolacce dal significato diverso ma con una carica offensiva equivalente. A patto che siano fatti sondaggi analoghi in altre lingue.
Proposta che lancerò al 3° Convegno internazionale sulle parolacce previsto a fine maggio all’università della Savoia a Chambéry (Francia), dove sarò l’unico relatore italiano.
In conclusione, ringrazio – oltre ai navigatori di Focus – quanti hanno collaborato al progetto: il direttore Sandro Boeri, la redazione di Focus.it, Francesca Tartamella per l’insostituibile apporto nell’elaborazione dei dati.
The post Abbiamo il “volgarometro”!!! first appeared on Parolacce.]]>