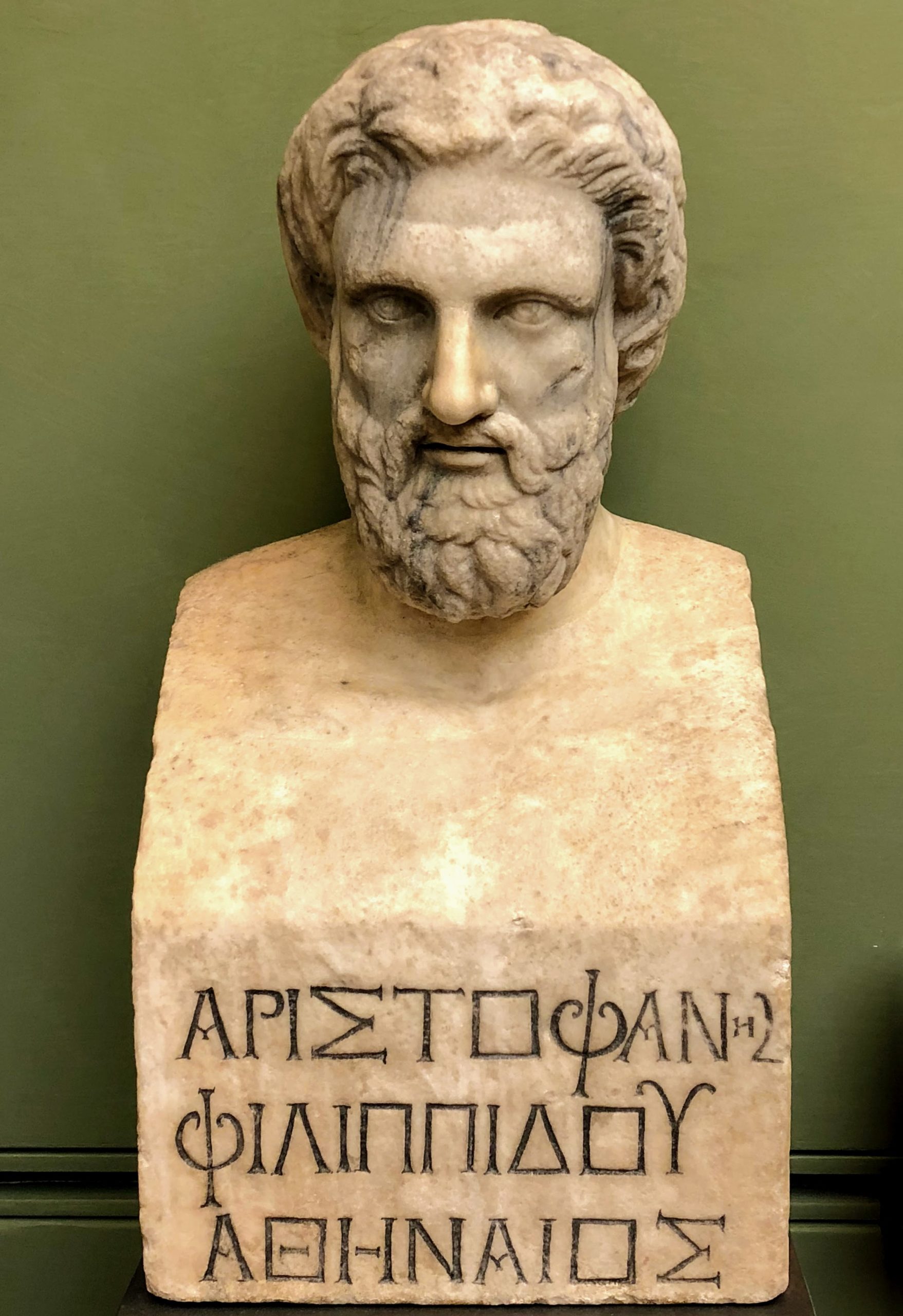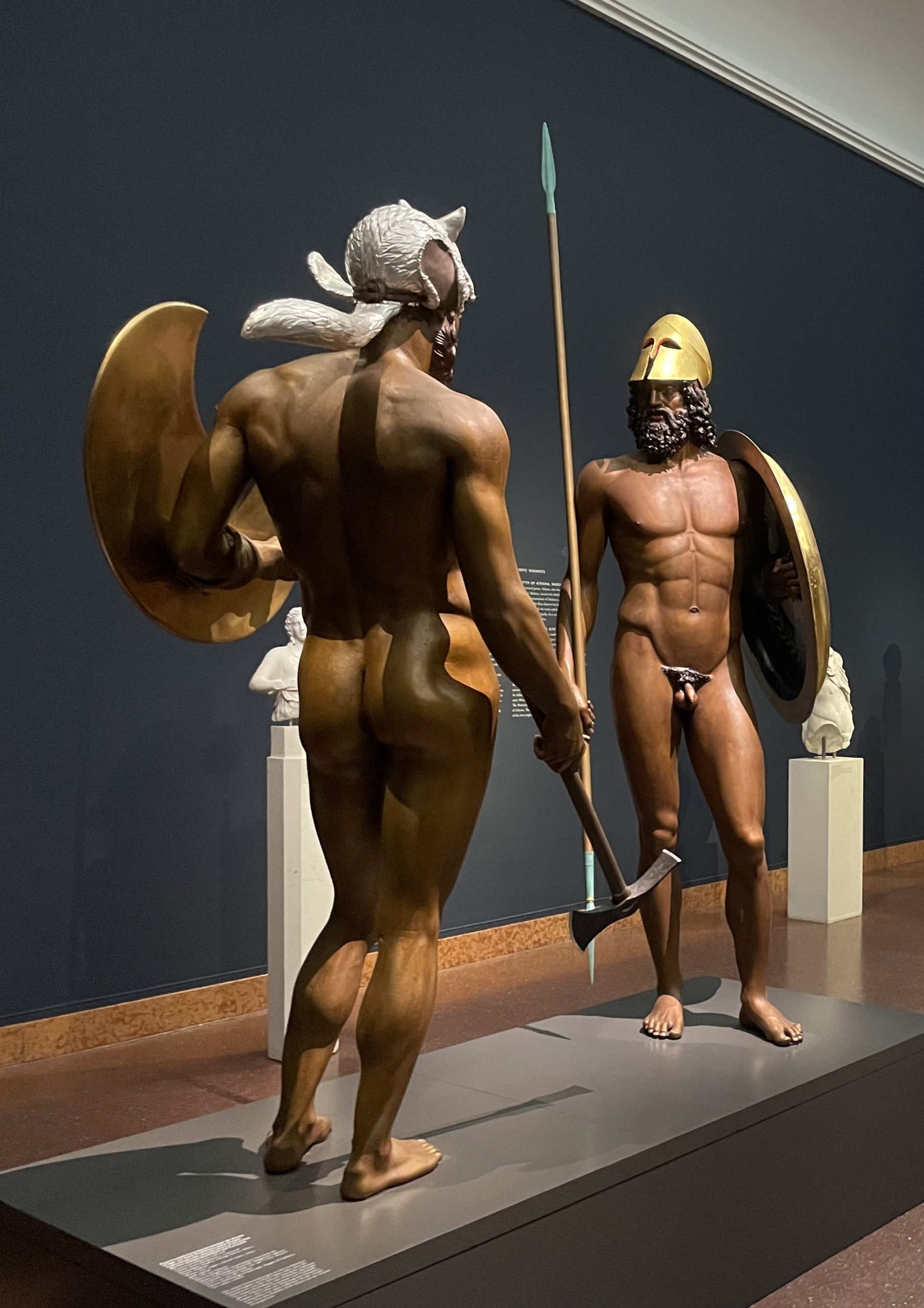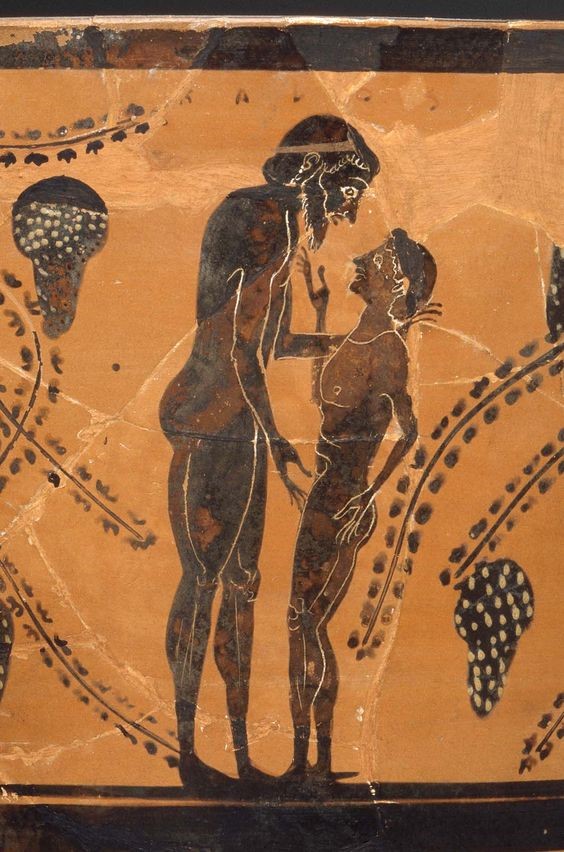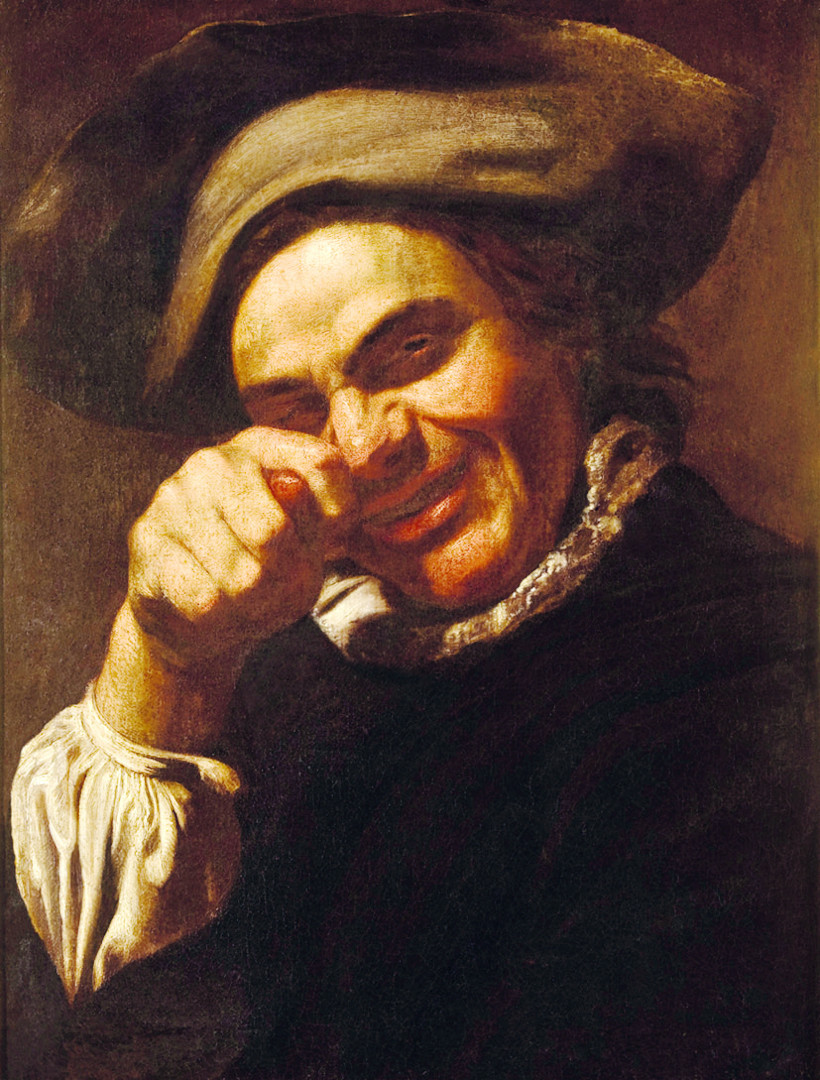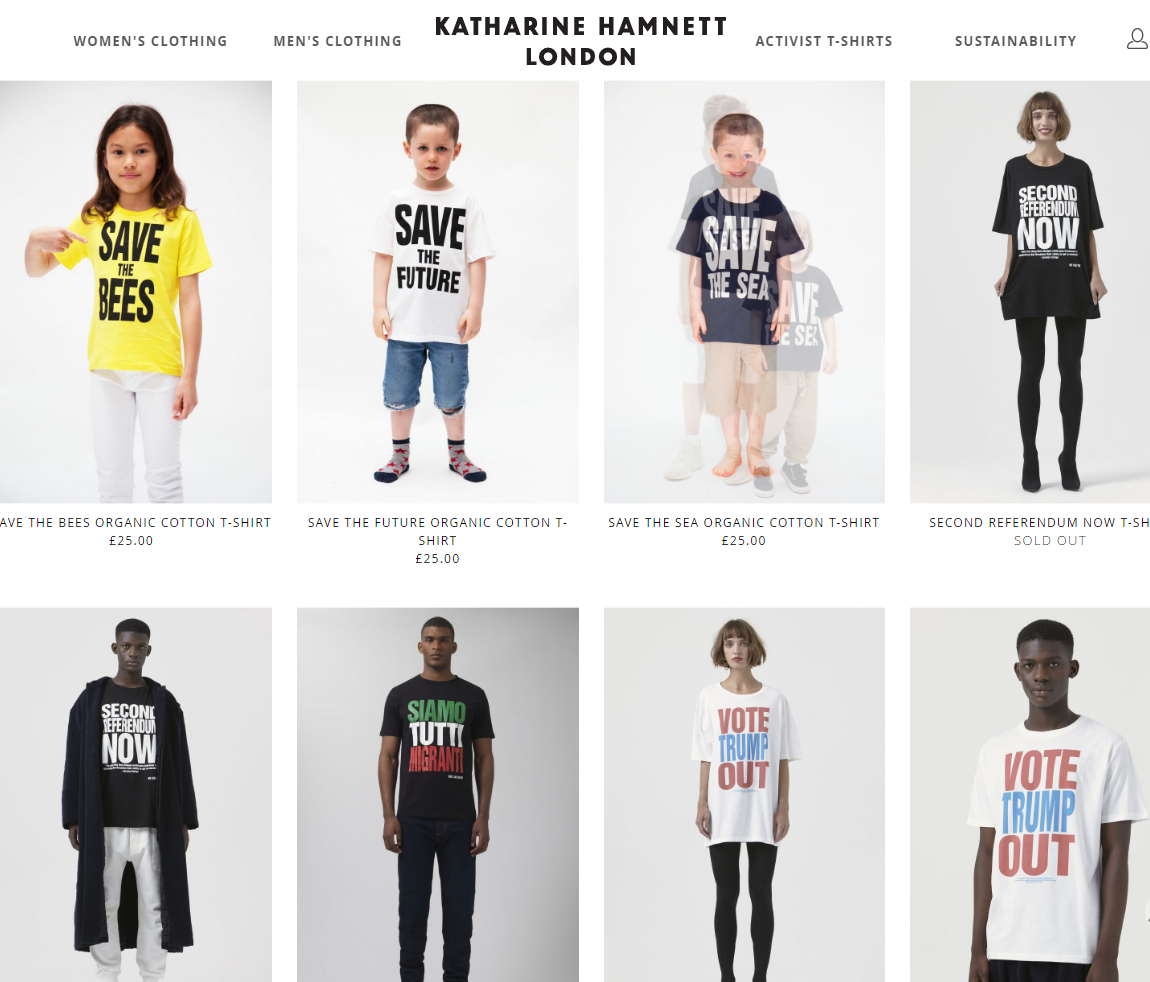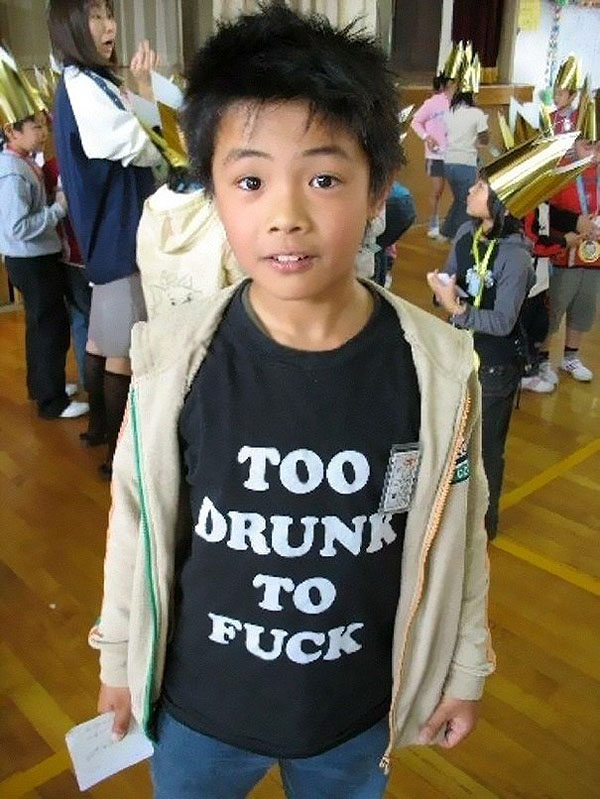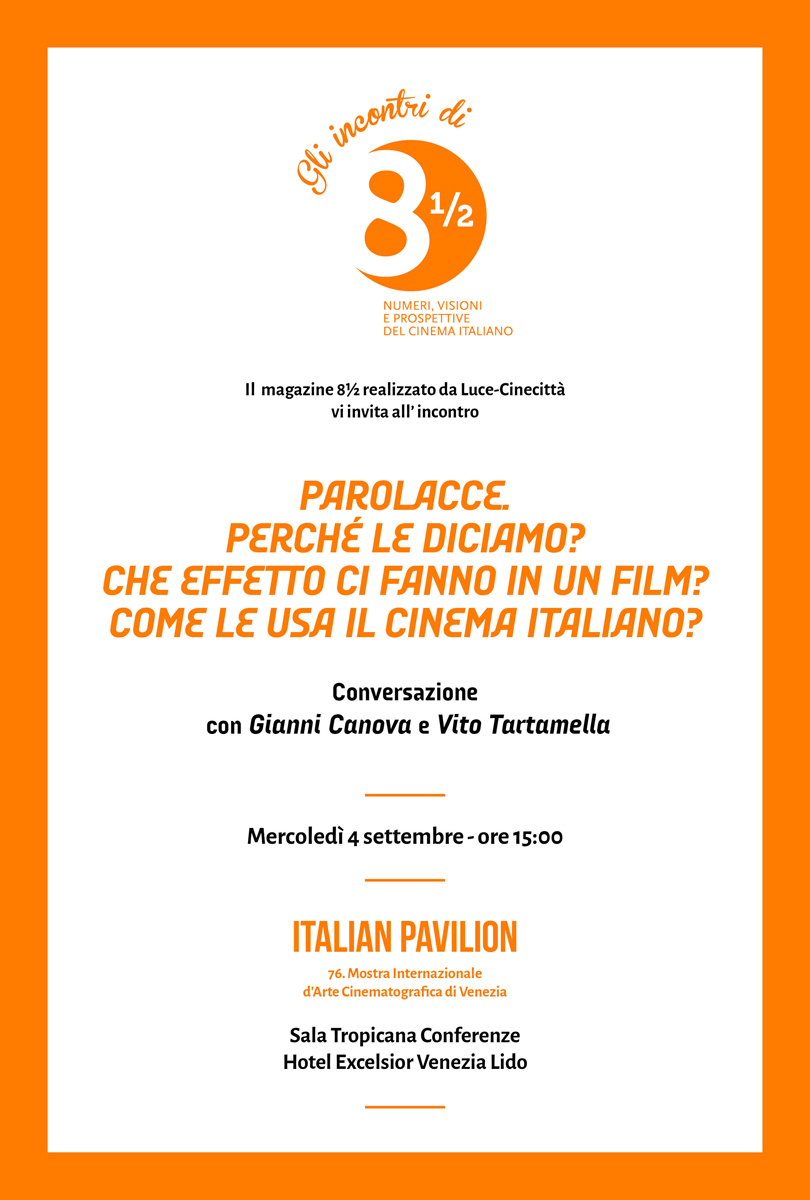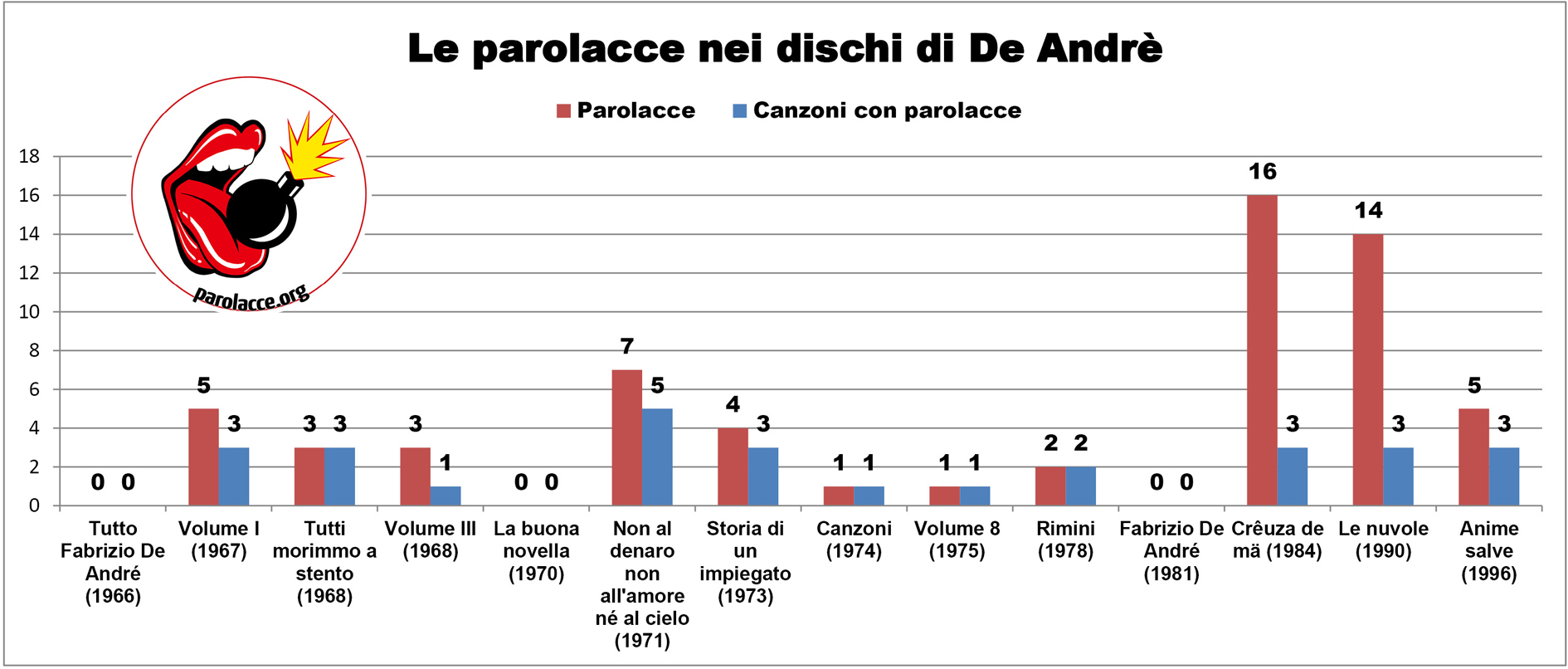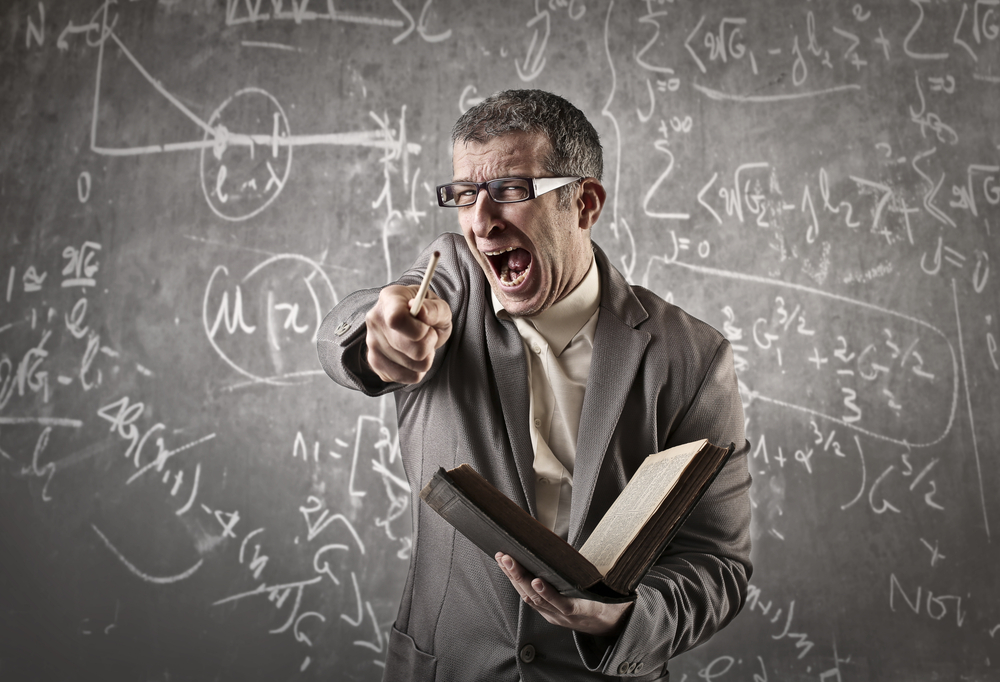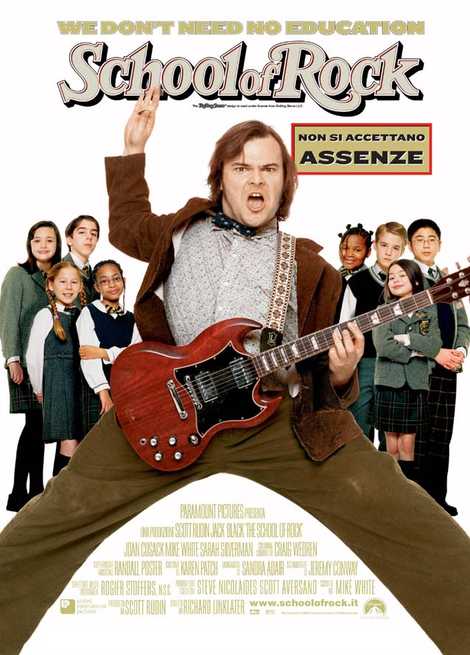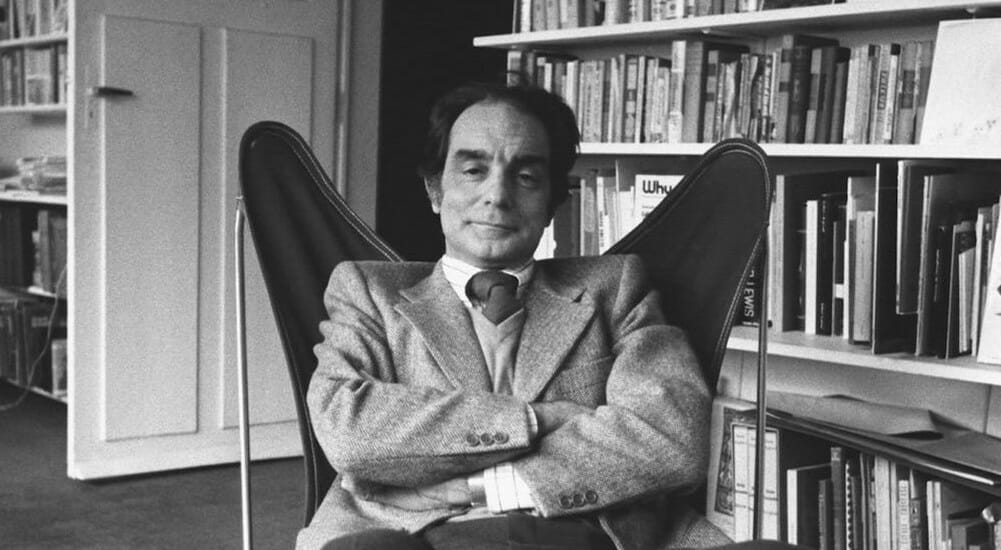
Italo Calvino ( 1923-1985).
Ha raccontato mondi immaginari fatti di cavalieri inesistenti, città invisibili e visconti dimezzati. Ma Italo Calvino è stato anche uno scrittore realista e un attento osservatore del mondo. Parolacce comprese. Non solo le ha inserite in diversi romanzi, ma ha dedicato loro un’acuta analisi che è attuale ancora oggi, anche se sono passati più di 40 anni. Forse può sorprendere che un autore così raffinato si sia dedicato al turpiloquio, ma in realtà è in ottima compagnia, come ho avuto modo di raccontare a proposito di Umberto Eco e molti altri che trovate nel mio libro. Perché le parolacce, come diceva Calvino, possono servire a dare un “effetto speciale” nella partitura del discorso.
Le 117 volgarità ne “Il sentiero dei nidi di ragno”
Per entrare nel mondo di Calvino, parto con l’analisi del suo primo romanzo, “Il sentiero dei nidi di ragno”: pur essendo stato pubblicato nel 1947, epoca di censure e perbenismo, presenta numerosi termini volgari o offensivi. Non è un caso: la storia, infatti, è ambientata in Liguria all’epoca della seconda guerra mondiale e della Resistenza partigiana sotto dominio nazifascista. In guerra è più rude anche il linguaggio, e un romanzo realista ne deve tener conto.
Calvino utilizza in tutto 31 espressioni triviali per un totale di 117 volte, includendo anche termini forti come puttana, fottuto, bastardo, cornuto e terrone: mica male! E lo fa inglobando anche alcune espressioni colloquiali e dialettali, tranne il celebre “belin”: scelta insolita per un romanzo ambientato in Liguria.
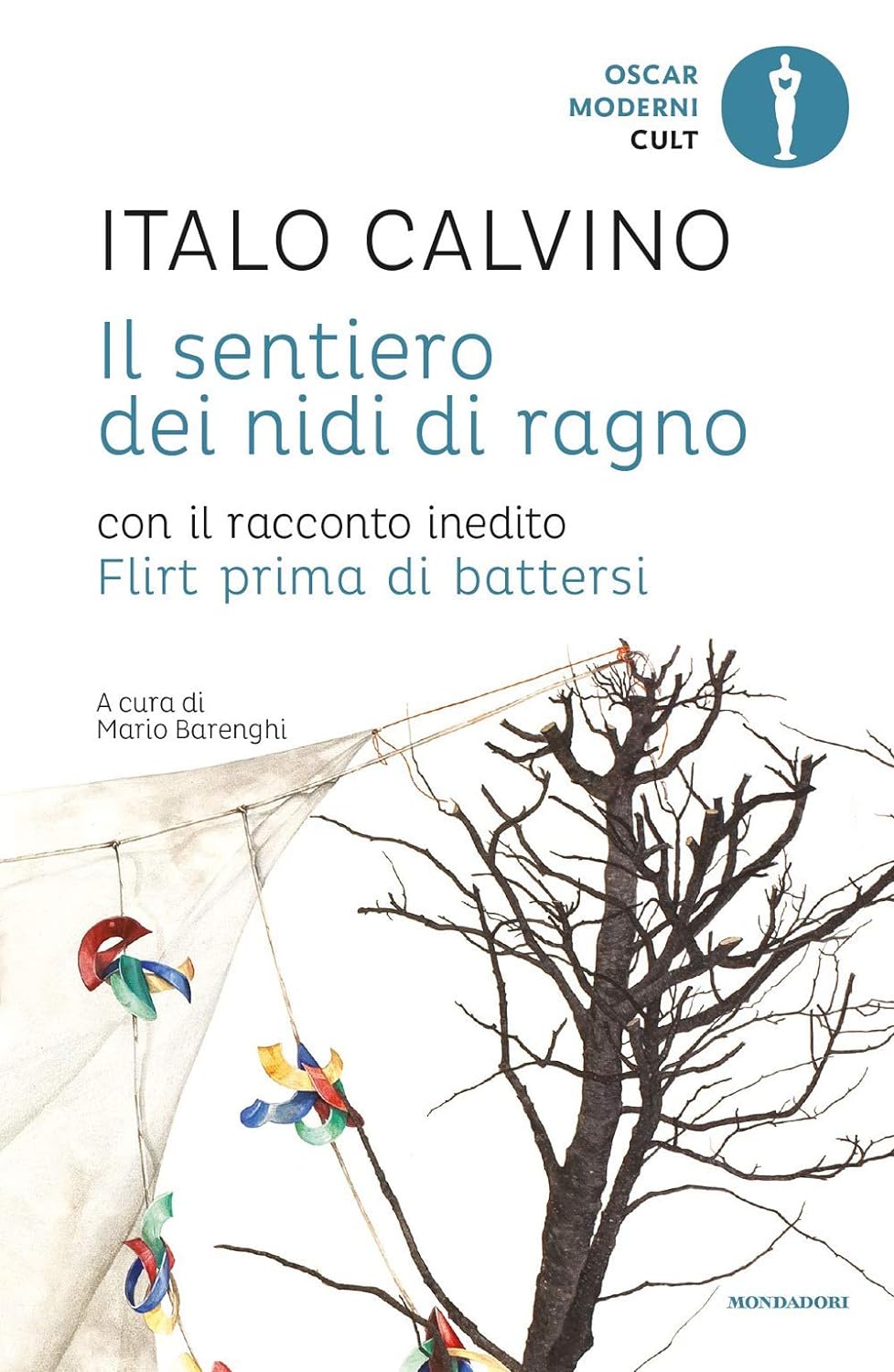
La scelta stilistica di Calvino è ancor più interessante perché il protagonista del libro è un ragazzo ribelle di 10 anni, Pin, bambino orfano di madre e abbandonato dal padre. Privo di punti di riferimento, il bambino vive con la sorella, la Nera di Carrugio Lungo, una prostituta che s’intrattiene con i militari tedeschi. Dietro lo sguardo spaesato di Pin c’è la vicenda biografica di Italo Calvino che, da giovane, aveva lasciato gli studi universitari ed era entrato nella Resistenza, in clandestinità, a contatto con persone di umili origini.
Il romanzo conduce il lettore fin dalle prime righe nei vicoli di un paese ligure, proprio grazie alla spontaneità delle parolacce:
Per arrivare fino in fondo al vicolo, i raggi del sole devono scendere diritti rasente le pareti fredde, tenute discoste a forza d’arcate che traversano la striscia di cielo azzurro carico. Scendono diritti, i raggi del sole, giù per le finestre messe qua e là in disordine sui muri, e cespi di basilico e di origano piantati dentro pentole ai davanzali, e sottovesti stese appese a corde; fin giù al selciato, fatto a gradini e a ciottoli, con una cunetta in mezzo per l’orina dei muli. Basta un grido di Pin, un grido per incominciare una canzone, a naso all’aria sulla soglia della bottega, o un grido cacciato prima che la mano di Pietromagro il ciabattino gli sia scesa tra capo e collo per picchiarlo, perché dai davanzali nasca un’eco di richiami e d’insulti. – Pin! Già a quest’ora cominci ad angosciarci! Cantacene un po’ una, Pin! Pin, meschinetto, cosa ti fanno? Pin, muso di macacco! Ti si seccasse la voce in gola, una volta! Tu e quel rubagalline del tuo padrone! Tu e quel materasso di tua sorella!
Già nell’incipit troviamo 3 insulti (muso di macaco, rubagalline, materasso, inteso come “grassona”) e una maledizione (ti si seccasse la voce in gola). Ma è Pin l’autore dell’espressione più pesante del romanzo, una sequenza di insulti che avrebbe voluto urlare in faccia ad alcuni clienti dell’osteria a cui stava nascondendo di avere in tasca una pistola: Vorrebbe piangere, invece scoppia in uno strillo in i che schioda i timpani e finisce in uno scatenio d’improperi: – Bastardi, figli di quella cagna impestata di vostra madre vacca sporca lurida puttana!
Una sequenza di alto impatto, costruita con una escalation di insulti in decasillabi quasi perfetti.
Nel ventaglio di espressioni scelte da Calvino per questo romanzo, prevalgono i termini colloquiali e gli insulti: Calvino si tiene alla larga dal lessico osceno, nonostante la sorella di Pin faccia la prostituta. Da segnalare l’assenza di espressioni molto diffuse come “cazzo”, “stronzo”, “coglioni” e “vaffanculo”. Ecco la lista completa delle parolacce presenti nel romanzo:
[ per approfondire, apri la finestra cliccando sul + qui sotto ]
Le parolacce come musica
 Avendo utilizzato a piene mani il turpiloquio nella sua prima opera, Calvino non ha mai avuto un atteggiamento snob o moralista verso le parolacce. Anzi, ne ha fatto oggetto anche di una riflessione molto acuta in un articolo del 1978 (uscito in origine sul “Corriere della sera”, poi raccolto nel saggio “Una pietra sopra. Discorsi di letteratura e società”). Nonostante siano passati 46 anni, è un’analisi ancora attuale. Calvino afferma che le espressioni triviali hanno un “insostituibile valore” per tre motivi.
Avendo utilizzato a piene mani il turpiloquio nella sua prima opera, Calvino non ha mai avuto un atteggiamento snob o moralista verso le parolacce. Anzi, ne ha fatto oggetto anche di una riflessione molto acuta in un articolo del 1978 (uscito in origine sul “Corriere della sera”, poi raccolto nel saggio “Una pietra sopra. Discorsi di letteratura e società”). Nonostante siano passati 46 anni, è un’analisi ancora attuale. Calvino afferma che le espressioni triviali hanno un “insostituibile valore” per tre motivi.
Primo: hanno una forza espressiva ineguagliabile, dovuta alle loro connotazioni negative. Le parolacce sono «una nota musicale per creare un determinato effetto nella partitura del discorso, parlato o scritto», e la loro espressività è data proprio dal fatto che sono «regressive, fallocentriche o misogine». Inutile tentare di addolcirle, come ricordo spesso: le parolacce nascono come colpi sotto la cintura ed è ingenuo pensare di attenuarle.
Il disprezzo per il sesso che molte espressioni sottendono «ha un senso marcatamente conservatore d’affermazione di superiorità su un mondo inferiore. Prova ne è che il turpiloquio non ha mai liberato nessuno. Direi che, spesso, è vero il contrario».
Ma, per avere questi effetti espressivi, le parole oscene «vanno usate al momento giusto» perché «sono esposte più delle altre a un’usura espressiva e semantica, e in questo senso credo ci si debba preoccupare di difenderle: difenderle dall’uso pigro, svogliato, indifferente. Naturalmente, senza tenerle sotto una campana di vetro, o in un “Parco Nazionale”, come preziosi stambecchi verbali: bisogna che vivano e circolino in un “habitat” congeniale. La nostra lingua ha vocaboli di espressività impareggiabile: la stessa voce “cazzo” merita tutta la fortuna che dalle parlate dell’Italia centrale le ha permesso di imporsi sui sinonimi dei vari dialetti. Anche nelle altre lingue europee mi pare che le voci equivalenti siano tutte più pallide. Va dunque rispettata, facendone un uso appropriato e non automatico; se no, è un bene nazionale che si deteriora, e dovrebbe intervenire Italia Nostra».
 Insomma, il turpiloquio è un ventaglio di espressioni a cui dobbiamo ricorrere in quanto «riserva di creatività, non in quanto repertorio di voci infiacchite. La grande civiltà dell’ingiuria, dell’aggressione verbale oggi si è ridotta a ripetizione di stereotipi mediocri. Giustamente ha osservato un linguista che dire “inintelligente” è molto più offensivo che dire “stronzo”». L’osservazione vale a maggior ragione oggi, epoca di grande inflazione delle parolacce in diversi contesti: non solo cinema, radio, giornali e tv, ma anche (e soprattutto) Internet. Anche quando si vuole attaccare una persona o un’idea, si utilizzano le solite espressioni logore, senza fantasia.
Insomma, il turpiloquio è un ventaglio di espressioni a cui dobbiamo ricorrere in quanto «riserva di creatività, non in quanto repertorio di voci infiacchite. La grande civiltà dell’ingiuria, dell’aggressione verbale oggi si è ridotta a ripetizione di stereotipi mediocri. Giustamente ha osservato un linguista che dire “inintelligente” è molto più offensivo che dire “stronzo”». L’osservazione vale a maggior ragione oggi, epoca di grande inflazione delle parolacce in diversi contesti: non solo cinema, radio, giornali e tv, ma anche (e soprattutto) Internet. Anche quando si vuole attaccare una persona o un’idea, si utilizzano le solite espressioni logore, senza fantasia.
Secondo: i termini osceni sono le migliori espressioni se si vuole avere un effetto “denotativo diretto”. Per designare quell’organo o quell’atto meglio usare la parola più semplice, quando si intende parlare davvero di quell’organo o di quell’atto. Le parolacce, insomma, servono a chiamare le cose con il loro nome, sono il linguaggio più diretto. Ma con un’avvertenza, purtroppo non approfondita da Calvino: «la trasparenza semantica di una parola è inversamente proporzionale alla sua connotazione espressiva». Tradotto, significa: se una parola è molto ricca di sfumature emotive di significato, diventa una parola oscura. Un esempio? La parola “cazzo” che, quando non designa l’organo sessuale maschile è usata come sinonimo di nulla (cazzata), la stupidità (cazzone), la sorpresa (cazzo!), la noia (scazzo), la rabbia (incazzato), la forza (cazzuto), le vicende private (cazzi miei), l’approssimazione (a cazzo), la parte più sensibile (rompere il cazzo)… Finisce così per significare tutto e il contrario di tutto.
Terzo valore delle parolacce: sono una forma di posizionamento sociale. «L’uso di parole oscene in un discorso pubblico (per esempio politico) sta a indicare che non si accetta una divisione di linguaggio privato e linguaggio pubblico. Per quanto comprenda e anche condivida queste intenzioni, mi sembra che il risultato di solito sia un adeguamento allo sbracamento generale, e non un approfondimento e uno svelamento di verità. Credo poco alle virtù del “parlare francamente”: molto spesso ciò vuol dire affidarsi alle abitudini più facili, alla pigrizia mentale, alla fiacchezza delle espressioni banali. È solo nella parola che indica uno sforzo di ripensare le cose diffidando dalle espressioni correnti che si può riconoscere l’avvio di un processo liberatorio».
Il che è ancor più valido nella nostra epoca in cui i politici di ogni schieramento, da Bossi in poi, hanno fatto del turpiloquio uno degli aspetti costanti della comunicazione: tutti fanno a gara per apparire informali nel linguaggio e nell’abbigliamento, mentre i contenuti politici passano in ombra.
Le guerre e i traduttori di insulti
Calvino torna sulle parolacce anche in una sua opera matura, uno dei suoi capolavori: “Il cavaliere inesistente” (1959). Il romanzo è ambientato all’epoca di Carlo Magno, immaginato a scontrarsi con i Mori, ossia gli islamici. Nel primo scontro fra i due eserciti, Calvino scrive che, nelle prime fasi, quando i nemici entrano in contatto fra loro per la prima volta, vi sia un’armata di interpreti che traducono gli insulti pronunciati in arabo, spagnolo e francese.
 Cominciavano i duelli, ma già il suolo essendo ingombro di carcasse e cadaveri, ci si muoveva a fatica, e dove non potevano arrivarsi, si sfogavano a insulti. Lì era decisivo il grado e l’intensità dell’insulto, perché a seconda se era offesa mortale, sanguinosa, insostenibile, media o leggera, si esigevano diverse riparazioni o anche odî implacabili che venivano tramandati ai discendenti. Quindi, l’importante era capirsi, cosa non facile tra mori e cristiani e con le varie lingue more e cristiane in mezzo a loro; se ti arrivava un insulto indecifrabile, che potevi farci? Ti toccava tenertelo e magari ci restavi disonorato per la vita. Quindi a questa fase del combattimento partecipavano gli interpreti, truppa rapida, d’armamento leggero, montata su certi cavallucci, che giravano intorno, coglievano a volo gli insulti e li traducevano di botto nella lingua del destinatario.
Cominciavano i duelli, ma già il suolo essendo ingombro di carcasse e cadaveri, ci si muoveva a fatica, e dove non potevano arrivarsi, si sfogavano a insulti. Lì era decisivo il grado e l’intensità dell’insulto, perché a seconda se era offesa mortale, sanguinosa, insostenibile, media o leggera, si esigevano diverse riparazioni o anche odî implacabili che venivano tramandati ai discendenti. Quindi, l’importante era capirsi, cosa non facile tra mori e cristiani e con le varie lingue more e cristiane in mezzo a loro; se ti arrivava un insulto indecifrabile, che potevi farci? Ti toccava tenertelo e magari ci restavi disonorato per la vita. Quindi a questa fase del combattimento partecipavano gli interpreti, truppa rapida, d’armamento leggero, montata su certi cavallucci, che giravano intorno, coglievano a volo gli insulti e li traducevano di botto nella lingua del destinatario.
– Khar as-Sus! – Escremento di verme!
– Mushrik! Sozo! Mozo! Escalvao! Marrano! Hijo de puta! Zabalkan! Merde!
Questi interpreti, da una parte e dall’altra s’era tacitamente convenuto che non bisognava ammazzarli. Del resto filavano via veloci e in quella confusione se non era facile ammazzare un pesante guerriero montato su di un grosso cavallo che a mala pena poteva spostar le zampe tanto le aveva imbracate di corazze, figuriamoci questi saltapicchi. Ma si sa: la guerra è guerra, e ogni tanto qualcuno ci restava. E loro del resto, con la scusa che sapevano dire «figlio di puttana» in un paio di lingue, il loro tornaconto a rischiare ce lo dovevano avere.
Una gustosa trovata narrativa, che ci ricorda un aspetto a cui di solito non pensiamo: gli insulti hanno effetto solo nella misura in cui c’è qualcuno che li riceve, li comprende e dà loro un peso. Altrimenti, sono solo fiato sprecato.
 Le parolacce di Dante spiegate bene
Le parolacce di Dante spiegate bene
 Camilleri e le 3.109 parolacce di Montalbano
Camilleri e le 3.109 parolacce di Montalbano
 Leonardo da Vinci: le parolacce di un genio
Leonardo da Vinci: le parolacce di un genio
 Mozart e le parolacce musicali
Mozart e le parolacce musicali
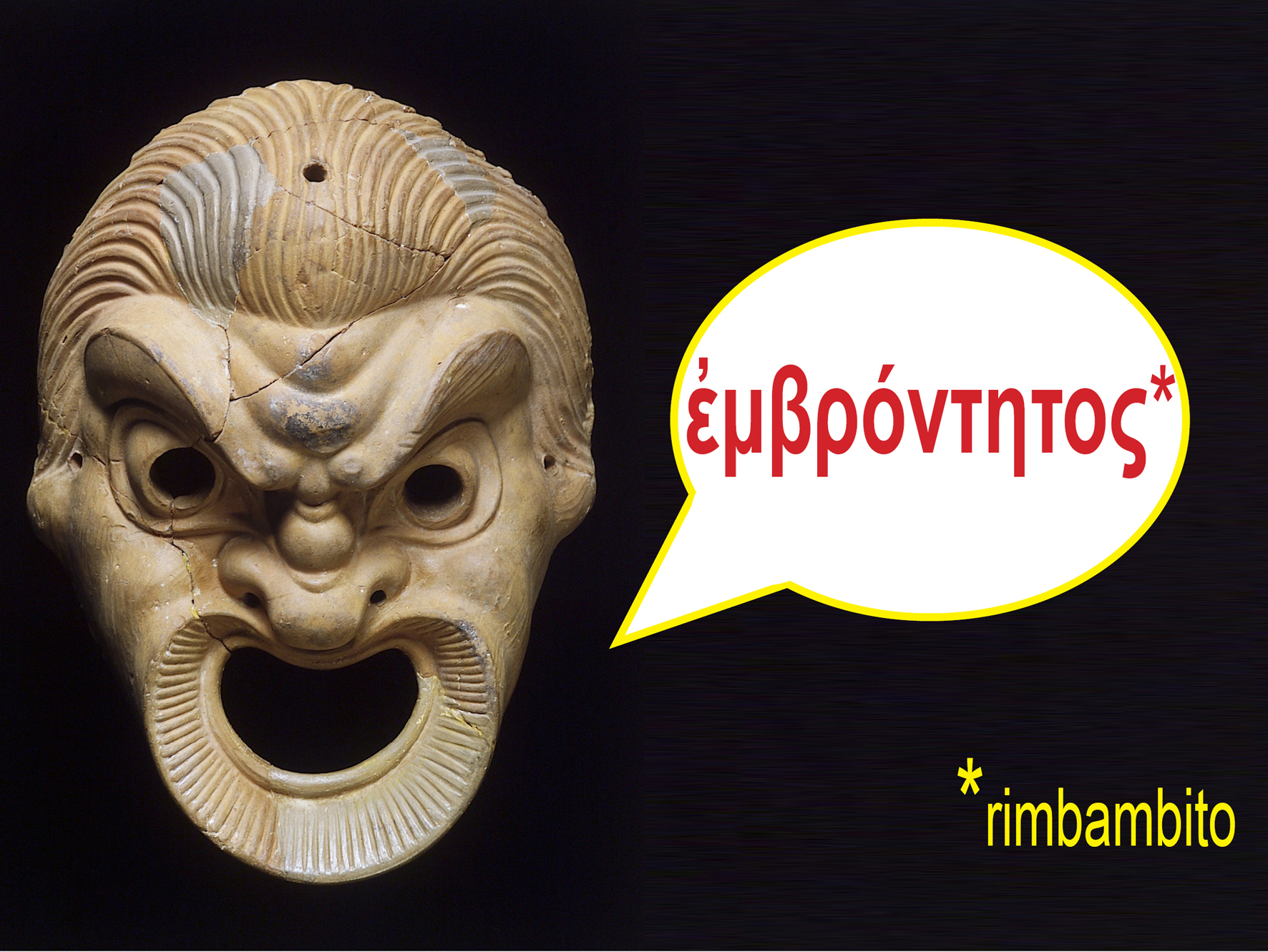
Maschera teatrale in terracotta (200-250 d.C.): fotomontaggio da ASCSA Digital Collections
Gli antichi Greci dicevano parolacce? Eccome: oltre a molte parole colte (metro, atomo, terapia, democrazia…) abbiamo ereditato da loro anche termini volgari, da cacca a culo. E arrivano dall’antica Grecia diversi modi di dire odierni come “fuori di testa”, “schiatta”, “culo rotto” fino al gesto del dito medio. Quando dovevano insultare qualcuno, infatti, gli elleni non erano secondi a nessuno, quanto a fantasia e disprezzo: “locusta”, “montone”, “zotico”, “mangia merda” e “vecchia mummia” sono solo un assaggio del loro ventaglio di insulti, che – ho scoperto – contiene 1.300 espressioni: una stima per eccesso, ma rende l’idea del loro arsenale di espressioni triviali.
E per mandare qualcuno a quel paese utilizzavano espressioni macabre, da “buttati nel baratro” a “che il tuo cadavere sia mangiato dai corvi”. Senza contare gli insulti riservati alle classi basse, agli incolti, agli stranieri, alle prostitute e agli omosessuali passivi. C’è poi un verbo, rhaphanidóo, che significa “ravanellizzare“: era la pena riservata gli adulteri, puniti infilando un ravanello nel sedere depilato con la cenere calda.

Coppa da vino in ceramica: raffigura il partecipante a un banchetto con un’etera, un’escort (480 a.C.).
Dai Greci, insomma, abbiamo ricevuto non solo parte del nostro lessico, ma anche una prospettiva sul mondo, un modo di guardare la realtà, sia nelle vette del pensiero filosofico che nelle bassezze del turpiloquio. Anche se, come vedremo, accanto a suggestive somiglianze ci sono anche rilevanti differenze, soprattutto nel modo di intendere il sesso: i Greci non erano così libertini come potrebbe apparire a prima vista.
Eppure, il turpiloquio antico non è stato ancora esplorato a fondo: gli studi sono pochi e limitati ad alcuni aspetti, e molti dizionari censurano le espressioni oscene. Nel celebre dizionario Rocci, ad esempio, πέος, cazzo, è indicato come “membro virile”: corretto, ma non fedele. Lorenzo Rocci, del resto, era un gesuita e l’impianto del dizionario – pur aggiornato – risale al 1939, epoca in cui era sconveniente utilizzare termini scurrili. Con questo articolo conoscerete quindi un aspetto della cultura ellenica che nessun professore vi aveva mai insegnato.
Perciò, con buona pace di chi ancora crede che siano un fenomeno moderno, le parolacce risalgono a più di 2mila anni fa: anzi, come ricordavo nel mio libro, quelle greche sono precedute da quelle egizie e babilonesi. Le scurrilità, insomma, sono antiche quanto l’uomo. Questo articolo non vuole essere una rassegna completa sul turpiloquio ellenico (occorrerebbe un libro intero), ma offrirne un’idea concreta e ordinata.
[ per leggere, apri la finestra cliccando sulla striscia blu qui sotto ]
Ho suddiviso le scurrilità elleniche in 4 grandi categorie, seguendo l’impostazione teorica del mio libro: imprecazioni, maledizioni, insulti (comportamentali, etnici, mentali, escrementizi) e oscenità.
1. Imprecazioni
Anche gli antichi greci imprecavano usando i nomi di varie divinità. Le imprecazioni si costruivano prendendo la parola μά (per) e aggiungendo il nome della divinità al caso accusativo, insieme all’articolo: l’equivalente del nostro “per dio!”:
- μά τòν Δία (mà tòn Día): “Per Zeus!”
- μά τήν Ἥραν (mà ten Heran): “Per Hera!”
- μά τήν Ἀθηνᾶν (mà ten Athenân): “Per Atena!”
- γιγγρί (ghingrì): interiezione ingiuriosa traducibile con cazzo!, fanculo!, etc. (dal verbo γίγγρας, gridare)
Interessante notare che anche i Greci cercavano di non pronunciare invano il nome degli dèi, scegliendo eufemismi che usiamo ancora oggi: capperi (να τήν κάππαριν, per il cappero), porco cane (μέν τα κύνα, per il cane), porca l’oca (νά τòν χήνα), per l’oca) e cavolo (μά τήν κράμβην, per il cavolo).
2. Maledizioni
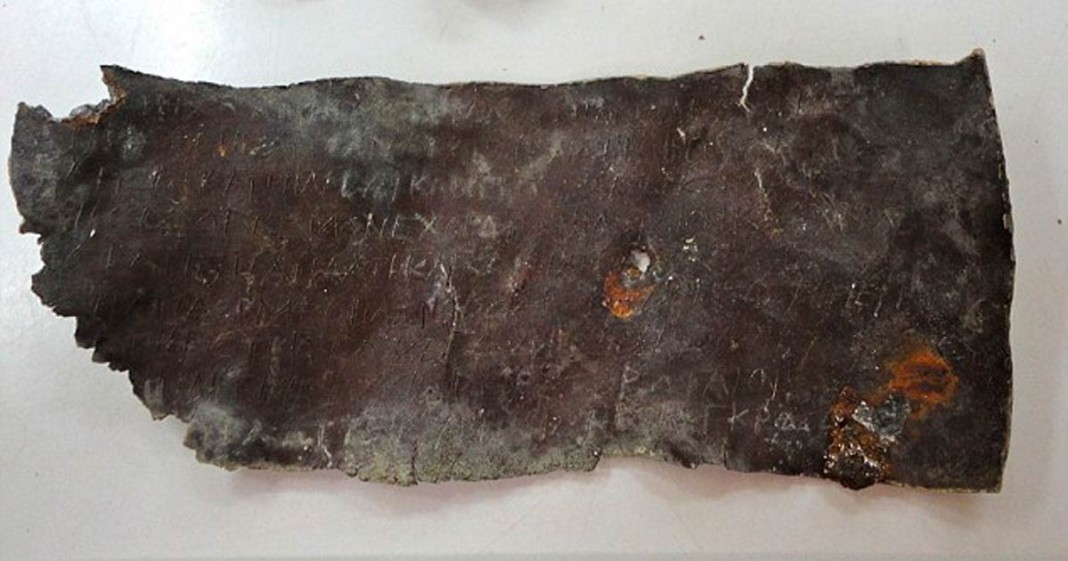
Tavoletta di piombo con incise le maledizioni. I fori sono stati lasciati dai chiodi (4° sec. a.C.)
In questo campo i Greci erano maestri indiscussi. Per augurare il male a qualcuno, facevano ricorso a vere pratiche magiche, come racconto più diffusamente nel mio libro. Prendevano un’unghia o un capello del nemico, pronunciavano su di esso la formula di maledizione e poi lo bruciavano o lo gettavano in un pozzo o in un fiume, con una tavoletta su cui era incisa la maledizione. A volte la tavoletta veniva fissata a una parete con i chiodi, come per trafiggere e inchiodare il destinatario. Nella formula erano citati, con un crescendo meticoloso, tutti gli organi del nemico fino alla sua anima. Gli archeologi hanno trovato numerose tavolette di questo genere.
Per quanto riguarda le espressioni più comuni, la più forte era βάλλ’ εἰς κόρακας (báll eis kórakas): “Vai dai corvi!“. La frase significa: che tu possa morire e restare senza sepoltura, in modo che i corvi mangino il tuo cadavere. Al di là dell’immagine truce, era la peggior maledizione per i greci: pensavano infatti che chi non fosse stato sepolto con un funerale rituale, non sarebbe mai entrato negli Inferi, vagando senza metà per l’eternità: la peggior disgrazia immaginabile. Da questa espressione deriva il verbo ἀποσκορακίζω (aposkorakìzo), mandare ai corvi: l’equivalente del nostro “mandare a quel paese”, dato che in questa espressione “paese” sta per “cimitero”, o mandare all’inferno. L’espressione ha avuto così fortuna da essere sopravvissuta nel greco moderno: “άει στον κόρακα” (aei ston kòraka). Con oltre 2mila anni di vita, è sicuramente il “vaffa” più longevo e antico della Storia.
A proposito di morte, l’equivalente del nostro “Va a morì ammazzato” è ἄπαγ᾽ εἰς τὸ βάραθρον (Àpag’eis tò bàrathron), letteralmente “vai nel baratro, nel precipizio”. Da segnalare anche le espressioni ἀποφθείρομαι (apoftheiromai) e ἀπòλοιο (apòloio) che tu sia distrutto, ἔρρε (èrre!) va in malora! e il notevole διαρραγείης (diarraghèies) scoppia!, crepa! equivalente del napoletano “puozze schiattà” (se volete approfondire le maledizioni in italiano e nei dialetti, ne ho parlato qui).
L’espressione ἐκκορηθείς συ γε (ekkorethèis sý ghè) significa “che tu sia spazzato via”: è l’equivalente del nostro “fuori dai coglioni”. Ma i Greci sapevano anche essere leggeri: l’espressione “datti all’ippica” (Iππευε, Ìppeue) è farina del loro sacco.
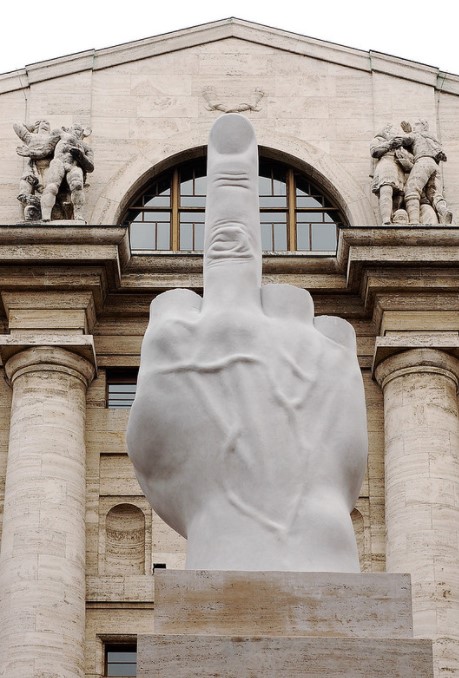
La scultura L.O.V.E. di Maurizio Cattelan di fronte alla Borsa di Milano.
E’ il gesto insultante più noto al mondo, ed è un segno fallico: agitato di fronte a un interlocutore diventa un gesto di sfida, di scherno, di minaccia, dato che fra gli animali esibire il fallo è simbolo di preminenza ed autoaffermazione. Ebbene, questo gesto molto diffuso nella cultura angloamericana, è nato in area mediterranea nel 423 a.C., anno in cui Aristofane scrisse la commedia “Le nuvole”. O, quantomeno, questa è la testimonianza scritta più antica che abbiamo di questo gesto, che sicuramente era già molto diffuso ben prima di Aristofane.
Ai versi 650-654 della commedia c’è uno scambio di battute fra Socrate e Strepsiade, un vecchio e rozzo contadino. Il brano gioca il suo effetto comico sull’ambiguità del termine dàktulos, che significa dito ma è anche il dattilo, unità di misura della poesia (una sillaba lunga seguita da due brevi). Ecco lo scambio di battute:
SOCRATE: Ma va’ all’inferno, razza di cafone imbecille! Figurarsi coi ritmi come sei bravo
STREPSIADE: Roba che si mangia? A che mai potrà tornare utile?
SOCRATE: In primo luogo a figurare in società, distinguendo i ritmi di battaglia da quelli che si scandiscono col dito
STREPSIADE: Col dito?
SOCRATE: Sì
STREPSIADE: Ma quelli li conosco!
SOCRATE: E cioè?
STREPSIADE: Ecco qua il dito. Ce n’è un altro? A dir la verità, quand’ero ragazzetto, c’era questo [ e mostra il medio ]
SOCRATE: Sei uno stupido cafone.
3. Insulti
Il vocabolario dei Greci era molto ricco di insulti, che riflettono la loro mentalità snob, che disprezzava ignoranti, poveri e stranieri. I Greci insultavano in particolar modo chi svolgeva lavori umili: «sebbene gli ateniesi della classe operaia fossero cittadini a pieno titolo sia legalmente che ideologicamente, erano tuttavia ritenuti (da alcuni) inadatti a esercitare tutti i diritti di cittadinanza» spiega la professoressa Kamen. Dunque, termini come πονηρός (poneròs), plebeo, diventa sinonimo di miserabile, cattivo, mentre il termine αγοραίος (agoràios, letteralmente “piazzista”), mercante, aveva una sfumatura di disprezzo perché i mercanti erano visti come elementi estranei all’economia delle città-Stato. Di tutte le occupazioni umili, i pellettieri (σκυτοδέψης, skutodèpses) e i calzolai (σκυτοτόμος , skutotòmos) erano i più disprezzati perché all’umiliazione di un’attività manuale abbinavano una carnagione pallida, poiché restavano tutto il giorno chiusi in casa: «il pallore, infatti, era associato alla femminilità» ricorda la Kamen. Per una società guerriera quale era quella greca, il concetto di onore – ossia di reputazione pubblica – era centrale: «dire che qualcuno si sottraeva alla leva o mostrava codardia sul campo di battaglia, anche per scherzo, significava metterne in discussione le qualifiche e la capacità di prestare servizio cittadino in una polis democratica» aggiunge la Kamen.
Se qualcuno diceva insulti pesanti contro un defunto, era passibile di giudizio per κακηγορία (kakēgoría, insulto verbale); i vivi potevano intentare una causa solo se erano stati insultati davanti ad altri testimoni (come nella moderna diffamazione): ma doveva condividere la multa del risarcimento con lo Stato. Gli insulti puniti più duramente erano quelli che implicitamente accusavano qualcuno di aver commesso un reato: assassino, disertore, e simili. In termini moderni, i casi di calunnia.
Fra gli insulti generici si ricordano κατάῥατος (kataràtos) maledetto (da araomai, pregare, nel senso di imprecare, maledire) e παγκατάρατος (pankatàratos) stramaledettissimo.
[ per leggere, apri la finestra cliccando sulla striscia blu qui sotto ]
4.Le parole del sesso

Scena erotica su ceramica apula (4 sec. a.C.)
Il lessico osceno è ricchissimo, ed è normale: anche le lingue moderne sfruttano la forza dei tabù sessuali per creare espressioni volgari, utilizzate non solo per designare genitali e atti sessuali, ma anche per stigmatizzare comportamenti considerati aberranti o esecrabili (come l’adulterio, la prostituzione, il sesso anale e orale, come vedremo). I termini erotici, infatti, esprimono anche una visione morale e sociale. Ma prima di illustrare quest’ultima, parto dai termini osceni, che designano genitali, zone erotiche e atti sessuali. Da notare che già le antiche greche usavano i dildo in pietra, cuoio, o legno: forse perché i loro partner erano spesso impegnati in guerre, politica o esercitazioni militari.
Termini osceni
[ per leggere, apri la finestra cliccando sulla striscia blu qui sotto ]
Etica sessuale

La gioventù di Bacco: dipinto di William-Adolphe Bouguereau (1884).
Se immaginate la civiltà greca come libertina e dissoluta, beh: sbagliate. In realtà, i Greci (e anche i Romani) ponevano un forte accento sull’idea di moderazione e autocontrollo: la σωφροσύνη (sophrosýne, per i Romani temperantia). Quindi bandivano tutti gli eccessi, compresi quelli sessuali. Pare che anche le orge, in realtà, fossero ben poco diffuse: secondo il professor Alastair Blanshard, della Scuola di ricerche filosofiche e storiche dell’università di Sydney, le orge dei Greci e dei Romani furono per lo più un’invenzione propagandistica dei cristiani, per dipingere come dissoluta la civiltà pagana. Lo stesso termine, “orgia”, significa di per sé culto segreto, cerimonia iniziatica, sacrificio: non ha alcuna implicazione sessuale. Ciò non toglie, tuttavia, che alcuni di questi riti potessero comprendere atti sessuali propiziatori della fertilità, ma a fini sacri, di congiungimento col divino.
I Greci, comunque, vivevano la sessualità in modo peculiare. Innanzitutto disprezzavano chiunque corteggiasse i ragazzi (della cosiddetta “pederastia” parlerò più avanti), non si sposasse o si masturbasse. Era considerato vergognoso e poco virile: nelle sue commedie Aristofane prende in giro incessantemente gli uomini di questo genere. Sicuramente era una società guerriera e maschilista: a Sparta, dove gli uomini passavano gran parte del tempo fra loro, se un uomo non riusciva ad avere un figlio dalla moglie aveva il diritto legale di “prestarla” ad altri affinché la mettessero incinta, senza bisogno – pare – del consenso della donna.
 E certamente i Greci non erano paladini dell’amore libertino: basti pensare non solo agli spregiativi riservati agli adulteri (μοιχαλίς moichalis, cornificatrice, adultera), ma anche a un verbo ῥαφανιδόω (rhaphanidóo): “ficcare un ravanello nel culo di qualcuno“. Era la punizione riservata a chi faceva sesso con la moglie di un altro, preceduta dalla depilazione del sedere con cenere calda o pece. Potrebbe sembrare poca cosa viste le piccole dimensioni, ma voglio ricordare che la sua radice è piccante grazie alla presenza di glucosinolati. Era dunque una umiliazione pubblica, una punizione popolare praticata dal marito tradito e dai suoi parenti o amici, che si prendevano la soddisfazione di ridicolizzare l’amante facendolo correre dolorante con il ciuffo di foglie che usciva dal sedere. A questo si aggiungeva la possibilità, per il marito, di ristabilire il proprio onore uccidendo la moglie fedifraga.
E certamente i Greci non erano paladini dell’amore libertino: basti pensare non solo agli spregiativi riservati agli adulteri (μοιχαλίς moichalis, cornificatrice, adultera), ma anche a un verbo ῥαφανιδόω (rhaphanidóo): “ficcare un ravanello nel culo di qualcuno“. Era la punizione riservata a chi faceva sesso con la moglie di un altro, preceduta dalla depilazione del sedere con cenere calda o pece. Potrebbe sembrare poca cosa viste le piccole dimensioni, ma voglio ricordare che la sua radice è piccante grazie alla presenza di glucosinolati. Era dunque una umiliazione pubblica, una punizione popolare praticata dal marito tradito e dai suoi parenti o amici, che si prendevano la soddisfazione di ridicolizzare l’amante facendolo correre dolorante con il ciuffo di foglie che usciva dal sedere. A questo si aggiungeva la possibilità, per il marito, di ristabilire il proprio onore uccidendo la moglie fedifraga.
Della punizione del ravanello parla, ancora una volta, Aristofane, sempre nelle “Nuvole”. C’è un dialogo fra due personaggi, “Discorso giusto” (la personificazione dei valori tradizionali) e “Discorso ingiusto” (i nuovi filosofi, capaci solo di ammaliare con le parole), in cui quest’ultimo esalta le capacità retoriche dicendo che possono salvare da situazioni difficili:
DISCORSO INGIUSTO: Se anche ti beccano in flagrante adulterio, basta dire che non hai fatto nulla di male e rovesciare tutto su Zeus: anche lui cede all’amore delle donne. Tu, che sei mortale, come puoi essere più forte di un dio?
DISCORSO GIUSTO: E se per averti dato retta gli infilano un ravanello nel culo e lo depilano con la cenere calda, potrà negare di essere un rottinculo?
Scandalo e spregio – basti ricordare la vicenda teatrale di Edipo – erano riservati anche a chi commetteva incesto: μητροκοίτης (metrokoítès: lett: chi va a letto con la madre). In qualche modo è progenitore dell’inglese “motherfucker” (chi si fotte la madre), anche se quest’ultimo ha un significato metaforico più che letterale: significa “persona senza scrupoli, figlio di puttana, bastardo”.
[ per leggere, apri la finestra cliccando sulla striscia blu qui sotto ]
In sintesi, i Greci (e anche i Romani) percepivano come innaturale, immorale e vergognoso qualsiasi atto sessuale in cui un uomo adulto nato libero mostrasse sottomissione. Per capire quanto fosse complessa la loro etica, ricorda McDaniel, questi atti sessuali stigmatizzati includono:
- una donna (o un uomo) con un ruolo passivo nel sesso, ovvero penetrato
- una donna che succhia il pene di un uomo (perché controlla l’atto e non è una semplice ricevente passiva)
- un uomo che esegue il cunnilingus su una donna (perché l’uomo si sottomette alla donna)
- una donna che penetra un uomo o un ragazzo con un dildo (perché questo rappresenta un’inversione di ciò che percepivano come l’ordine naturale)
- un maschio adulto che si masturba (perché questo dimostra che non è abbastanza dominante e mascolino da trovare una donna, un adolescente o una persona schiava da penetrare)
- una donna che ha qualsiasi tipo di relazione sessuale con un’altra donna (perché rappresenta una donna che tenta di assumere il ruolo che credevano dovesse essere ricoperto da un uomo).
Altro che libertini…
Questo articolo è dedicato al prof. Vittorio Praga, che mi ha aperto le porte del Greco antico, questa meravigliosa lingua, per i 5 anni del liceo classico.
E ha pure rivisto questo articolo.
Grazie prof!
Di questo studio hanno parlato AdnKronos, Rtl 102.5, La Sicilia, Cremona Oggi, Tiscali cultura, La Svolta, Meteoweb, Day Italia news, Crema oggi, Tv7, La cronaca 24
E ne ho parlato anche a Radio Rai 1 nel programma Il Mondo nuovo
The post Le parolacce degli antichi Greci first appeared on Parolacce.]]>
L’uso di parolacce come password è abbastanza diffuso.
Dite la verità: almeno una volta avete usato una parolaccia come password. Beh, siete in ottima compagnia: secondo una ricerca su 50 Paesi, fra le 200 password più usate nel mondo figurano anche 2 parolacce: fuckyou (fottiti, 56° posto, scelta da oltre un milione e mezzo di persone) e fuckyou1 (fottiti1, 131° posto, 853mila persone). Cosa succede in Italia? E qual è il Paese che ne usa di più?
La ricerca, fatta da NordPass, un servizio di gestione delle password, ha esaminato oltre 275 milioni di parole d’ordine (275.699.516, per la precisione). Ed è interessante: la password è una chiave nascosta per accedere a diversi servizi su Internet. Ed è strettamente legata alla nostra identità: solo noi la conosciamo.
Guardare le password più usate è un viaggio nella fantasia (spesso scarsa: la parola d’ordine più diffusa, e la meno sicura, è 123456) e soprattutto nelle passioni nascoste delle persone: amici, familiari, amori (i nomi propri spopolano in tutte le lingue), squadre sportive (inter, juve), film (starwars, pokemon), cibi (chocolate), cantanti (eminem, onedirection), frasi fatte (ciaociao, Iloveyou) e così via.
Chi ne usa di più, chi ne usa di meno

“Dick” (cazzo) non è abbastanza duro (come parola d’ordine): campagna svedese per scoraggiare l’uso di parolacce come password.
Ma che cosa spinge a scegliere una parolaccia come password? La ricerca non lo dice, ma è facile intuirlo: è un invisibile sfogo verso l’ennesima richiesta di creare una password, un modo per ribellarsi senza troppi sforzi di fantasia. Gran parte delle espressioni usate, infatti, sono maledizioni (vaffanculo) o insulti (stronzo). Altre, invece, sembrano scelte più per una forma di trasgressione privata, usando termini escrementizi (cacca) o osceni (cazzo).
Ma qual è la nazione che sceglie più parolacce come password? Ho fatto una ricerca, limitandomi alle 14 nazioni dove si parlano lingue che conosco: inglese (Usa, Regno Unito, Canada, Irlanda, Australia), portoghese (Portogallo, Brasile), spagnolo (Spagna, Cile, Colombia, Messico), francese (Francia, Svizzera), tedesco (Germania). Più l’Italia, ovviamente. Non è uno scenario completo (segnalazioni su altri Paesi saranno benvenute), ma tutto sommato abbastanza rilevante: e dunque, quali Paesi hanno usato più volgarità?
Iniziamo da quelli che non ne hanno utilizzata neppure una: sono Irlanda, Portogallo, Regno Unito e Francia.
Ma non è l’unica sorpresa. Il Paese dove se ne usano di più sono gli Stati Uniti, seguiti da Italia e Germania (che però ci supera per numero totale di utilizzatori). Il Canada è la nazione dove una parolaccia risulta fra le prime 25 password più scelte (fuckyou, al 23° posto assoluto).
Per quanto riguarda l’Italia, il primo dato è impressionante: oltre 213mila persone, nel campione esaminato, hanno scelto una parolaccia come password. La parolaccia più scelta è vaffanculo, seguita da una bestemmia (unico caso al mondo, per quanto ho verificato); seguono cazzo, cazzone e cacca: uno scenario diverso rispetto alla classifica delle parolacce più usate nel linguaggio parlato, dove cazzo è al primo posto e vaffanculo al 10°.
Qui sotto l’elenco completo. Con una curiosità: la parolaccia più difficile da craccare per un hacker, stando a quanto afferma NordPass, è la spagnola tuputamadre (quella troia di tua madre), il tempo stimato necessario per decifrarla è di 4 mesi. E’ seguita da vaffanculo, craccabile in 12 giorni di lavoro. Probabilmente il tempo per scoprirla è direttamente proporzionale alla lunghezza, oltre che alla complessità della parola: ci vogliono solo 10 secondi per scoprire “cazzo” o “cacca”.
La classifica delle password volgari
| Paese (parolacce censite) | parolacce | posizione e utilizzatori |
| USA (6) 366.791 persone |
fuckyou (fottiti)
fuckyou1 (fottiti1) asshole (buco di culo, stronzo) fuckyou2 (fottiti2) asshole1 (buco di culo1) pussy (fica) |
30°, 178.545
81°, 118.720 152°, 66.133 196°, 51.522 |
| ITALIA (5) 213.112 persone |
vaffanculo
porcodio cazzo cazzone cacca |
39°, 76.981
98°, 42.098 121°, 36.737 138°, 34.744 198°, 22.552 |
| GERMANIA (4) 314.729 persone |
fuckyou (fottiti)
ficken (scopare) fuckme1 (fottimi1) |
31°, 155.125
57°, 78.106 70°, 53.566 179°, 27.932 |
| CANADA (3) 73.673 persone |
fuckyou (fottiti)
asshole (stronzo, buco di culo) |
23°, 39.626
67°, 20.593 133°, 13.454 |
| MESSICO (3) 13.158 persone |
caca (cacca)
popo (pupù) pendejo (stupido, vigliacco) |
151°, 4.575
152°, 4.509 166°, 4.074 |
| CILE (3) 5.729 persone |
chupalo (succhialo)
mierda (merda) caca (cacca) |
112°, 2.205
130°, 1.932 154°, 1.592 |
| SPAGNA (2) 31.469 persone |
mierda (merda)
tuputamadre (la puttana di tua madre) |
37°, 20.402
112°, 11.067 |
| AUSTRALIA (2) 15.169 persone |
fuckyou (fottiti)
boobies (tette) |
81°, 10.903
199°, 4.266 |
| COLOMBIA (2) 3.076 persone |
poop (cacca)
fuckyou (fottiti) |
146°, 1.750
190°, 1.326 |
| SVIZZERA (2) 4.111 persone |
fuckyou (fottiti)
arschloch (buco di culo, stronzo) |
53°, 2.266
90°, 1.845 |
| BRASILE (1) 9.657 persone |
buceta (fica) | 127°, 9.657 |
Se vi è piaciuto questo articolo, potrebbero interessarvi anche questi:
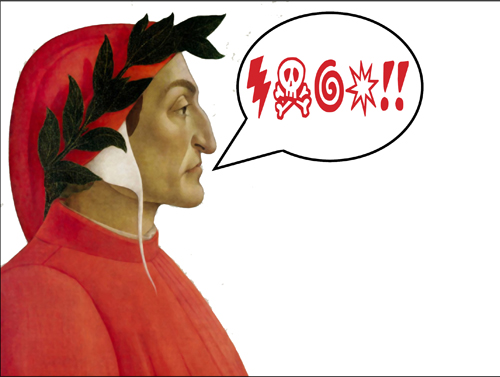
Dante ha inserito espressioni scurrili nella “Divina commedia” (montaggio su ritratto di Botticelli, 1495).
Si può fare poesia di altissimo livello usando le parolacce? Sì, e c’è un esempio clamoroso: la “Divina commedia”. Nel suo capolavoro, infatti, Dante Alighieri ha inserito 11 espressioni volgari, compresa una bestemmia e un ritratto squalificante di Maometto. Tanto che nel corso dei secoli – e persino quest’anno – la sua opera è stata pesantemente criticata, da Petrarca in poi, e più volte censurata. Reazioni spropositate, da parte di chi non ha capito la sua arte: la “Divina commedia” è un poema universale, che ritrae tutte le sfumature dell’animo umano. Perciò ha mescolato volutamente diversi registri linguistici – aulici e grotteschi, intellettuali e popolareschi, celestiali e terreni. Ha saputo, insomma, mescolare “alto” e “basso” come solo i grandi poeti sanno fare. Un altro esempio di questo livello è William Shakespeare.
Le parolacce, in particolare, sono servite a Dante per descrivere le peggiori bassezze dell’animo umano, a creare effetti comici e anche a dar voce alle sue passioni religiose, politiche e morali esprimendo la sua profonda indignazione. Dante modellava la lingua a seconda dei personaggi e delle situazioni che voleva descrivere.
Nel 700° anniversario della sua morte, ho deciso quindi di approfondire il turpiloquio di Dante, che probabilmente a scuola non vi hanno raccontato. In questo articolo troverete tutte le strofe (e relative spiegazioni) che contengono parole volgari, così potrete capire le precise ragioni artistiche che lo hanno indotto a usarle: Alighieri infatti ha sempre scelto con grande cura il lessico nel suo poema.
[ Cliccare sulla striscia blu per visualizzare il contenuto ]
[ Cliccare sulla striscia blu per visualizzare il contenuto ]
[ Cliccare sulla striscia blu per visualizzare il contenuto ]
[ Cliccare sulla striscia blu per visualizzare il contenuto ]
[ Cliccare sulla striscia blu per visualizzare il contenuto ]
Le radici del turpiloquio: realismo e Bibbia
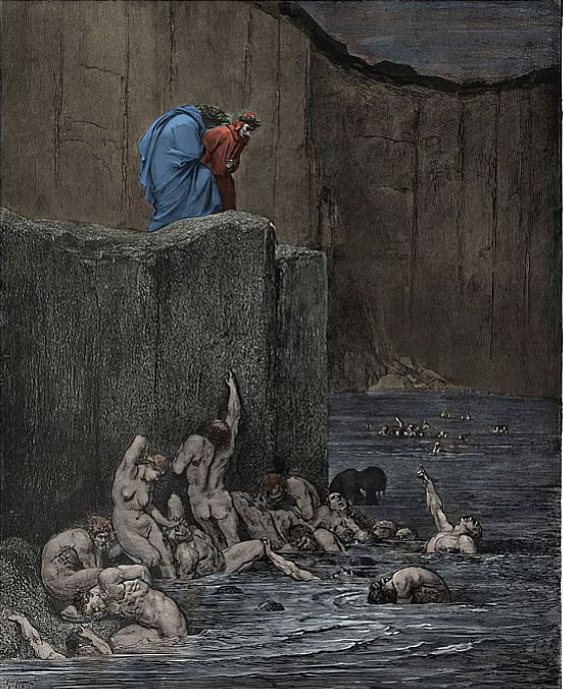
Dante e Virgilio guardano gli adulatori (Gustave Dore, 1885).
Dante usò la lingua del popolo, il “volgare”, ponendo le radici del lessico italiano. La sua lingua è una tavolozza espressiva multiforme, che va dai termini più bassamente popolari a quelli aulici. Dante, insomma, non si fa problemi a introdurre anche i registri bassi se sono funzionali alle sue esigenze narrative.
Ma c’è un’altra radice, giustamente sottolineata dal filologo Federico Sanguineti: la Bibbia. In molti passi dell’Antico Testamento, ma anche nell’Apocalisse, infatti, i profeti non esitano a citare gli escrementi e le prostitute per esprimere la loro riprovazione nei confronti degli empi, siano essi singole persone o interi popoli. Trovate esempi in abbondanza nel mio libro, che potrà farvi compagnia quest’estate.
Non è un caso che le parolacce più usate da Dante siano proprio “puttana” e “merda”: esprimono entrambe il disprezzo verso la dissolutezza morale, il disgusto per chi ha una condotta empia, la condanna verso persone che hanno piegato la propria anima al male.
Com’era prevedibile, nessuna delle espressioni scurrili trova posto nel Paradiso, dove avrebbero contaminato i temi e gli ambienti più elevati. La maggior parte (7) sono nell’Inferno, le altre 4 nel Purgatorio. Il canto con la maggior presenza di parolacce è il 18° dell’Inferno dedicato a ruffiani e seduttori: persone che, evidentemente, suscitavano la maggiore ira in Dante. Per uno abituato a cantarle chiare – come si vede nella “Divina commedia” – è più che comprensibile.
Statistiche e censure, antiche e moderne

Andrea di Buonaiuto, discesa al Limbo nel cappellone degli Spagnoli in Santa Maria Novella a Firenze (1365).
In tutto il poema Dante usa 11 volte 6 diverse espressioni scurrili: puttana, bordello, merda, culo, fiche, poppe. Pochissime: dato che la Divina Commedia ha in tutto 101.698 parole, il turpiloquio rappresenta lo 0,01%: un’esigua minoranza, circa un ventesimo di quante ne diciamo oggi nel parlato quotidiano (vedi le statistiche che ho ricavato qui). Eppure sono significative: hanno attirato l’attenzione degli intellettuali dell’epoca e per molti secoli a venire.
Già Petrarca, intellettuale d’élite, precisava di non provare invidia per Dante che era apprezzato da “tintori, bettolai e lanaioli”, cioè la plebe. E un altro umanista dell’epoca, Niccolò Niccoli, sosteneva addirittura che Dante andrebbe allontanato dal circolo esclusivo degli umanisti “per esser consegnato a farsettai, panettieri e simili essendosi egli stesso espresso in modo tale da sembrare voler stare a proprio agio solo con un pubblico di bassa estrazione sociale e culturale”. Insomma, la scelta di inserire termini popolari e volgari è stata un atto di coraggio in un’epoca in cui la cultura era un fatto elitario, snob, aristocratico.
Non stupisce, quindi, che quelle 11 parolacce sono state spesso censurate dai copisti che trascrivevano l’opera. Il filologo Federico Sanguineti ricorda che già nel 1300 Francesco di ser Nardo da Barberino sostituì “merda” con «feccia» (Inferno, 18°); nel codice Barberiniano latino 3975 sono anneriti gli endecasillabi in cui è denunciato il «puttaneggiar» della Chiesa (Inferno 19°). Il codice Canoniciano 115 nella bestemmia di Vanni Fucci (Inferno 25°) la parola «Dio» è sostituita da puntini sospensivi. E la censura prosegue anche oggi: quest’anno una casa editrice, Blossom Books, ha pubblicato una versione olandese della “Divina commedia” per ragazzi in cui è stato cancellato Maometto, per evitare che l’episodio risultasse «inutilmente offensivo per un pubblico di lettori che è una parte così ampia della società olandese e fiamminga». Ricordiamo infatti che Maometto è trattato come uno scismatico che ha diviso al suo interno il cristianesimo, e soprattutto è raffigurato con orrende e grottesche mutilazioni.
The post Le parolacce di Dante, spiegate bene first appeared on Parolacce.]]>
La T-shirt che contesta Salvini.
L’ultima T-shirt ha fatto infuriare i leghisti: ritrae Matteo Salvini mentre si scatta un selfie su un piedistallo. Indossa lo stesso diadema a 7 raggi della Statua della Libertà. Ma il titolo è ben diverso: “The statue of idiocy“, la statua dell’idiozia. Beffa nella beffa, il ricavato delle sue vendite è devoluto alla nave della Ong “Sea Watch”. Chi di felpe ferisce…
Le T-shirt, infatti, hanno aperto la strada a un insolito matrimonio: quello fra la moda e le parolacce. E non da oggi: negli ultimi 50 anni, infatti, le magliette sono state usate non solo per promuovere marchi, celebrare rockstar o veicolare slogan ideologici. Sono diventate una lavagna espressiva con cui esprimere la propria identità, sfogare emozioni forti, polemizzare, dire battute: così hanno diffuso il turpiloquio nel prêt-à-porter, rendendolo spiritoso, provocatorio, perfino blasfemo. Un fenomeno isolato, tipico dell’abbigliamento goliardico da strada?
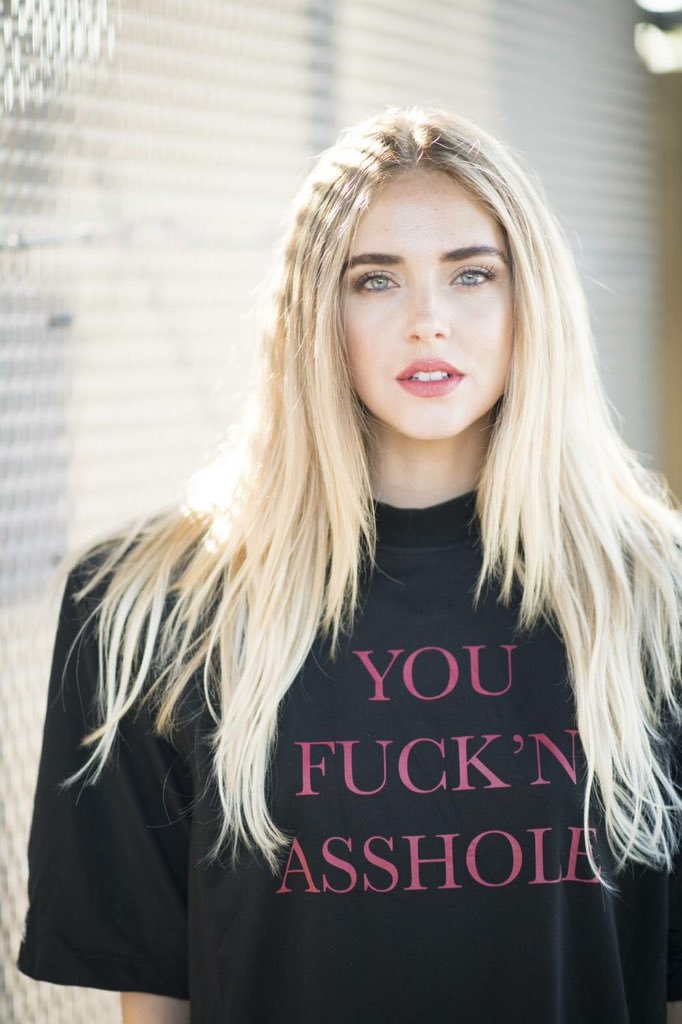
Chiara Ferragni e la T-shirt di Vetements.
Tutt’altro. Da qualche tempo, le T-shirt scandalose sono entrate anche nella moda ufficiale: diverse firme hanno lanciato singoli capi o intere linee con scritte volgari. La prima stilista che le ha lanciate è stata l’anarchica Vivienne Westwood già negli anni ’70, ma era ancora una cultura underground. Ma negli ultimi anni ha contagiato anche gli stilisti più noti: la T-shirt griffata “Vetements” con la scritta “You fuckin’ asshole” (tu, stronzo del cazzo) ha sfilato a Parigi ed è venduta a quasi mille dollari. L’ha indossata anche la trend setter Chiara Ferragni. Altri marchi famosi, come “Supreme“, hanno lanciato modelli volgari.
Le parolacce, infatti, “spaccano”: attirano l’attenzione, fanno scandalo, rompono gli schemi, esprimono schiettezza, humor o ribellione. Nel mondo della moda, sempre affamato di originalità e visibilità, sono una scorciatoia efficace per finire sotto i riflettori e accreditarsi come ribelli schietti e fuori dal coro. Col rischio, però, di perdere quell’aura di raffinatezza che dovrebbe circondare i capi di moda.
Il fenomeno è planetario. In Italia esistono diversi brand dai nomi scurrili: da “Figa power” a “F**K“, fino a “Vaffanculo“. Su 60 marchi volgari registrati all’Ufficio marchi italiano, infatti, il 35% è usato proprio per denotare capi d’abbigliamento. E’ vera creatività o solo espedienti effimeri per far parlare di sè?
Qui sotto potete ammirare le 21 magliette scurrili che hanno segnato la moda e il costume negli ultimi 50 anni. Compreso l’ultimo, che ha appena sfilato – facendo scandalo – sulle passerelle della Settimana della moda a Londra. Se ne avessi dimenticata qualcuna di meritevole, segnalatela nei commenti.
[ fai clic sul + per espandere la finestra qui sotto ]
1) Il dito medio
 Una mano in primo piano che brandisce un enorme dito medio: non occorrono scritte esplicative per questa T-shirt che è diventata un classico. Soprattutto la versione a lato, in cui lo stile vintage attenua in parte il significato volgare del gesto. Che è stato riprodotto in infinite varianti e brandito da vari personaggi: da Johnny Cash ai Simpson, fino alla mano fotografata ai raggi X.
Una mano in primo piano che brandisce un enorme dito medio: non occorrono scritte esplicative per questa T-shirt che è diventata un classico. Soprattutto la versione a lato, in cui lo stile vintage attenua in parte il significato volgare del gesto. Che è stato riprodotto in infinite varianti e brandito da vari personaggi: da Johnny Cash ai Simpson, fino alla mano fotografata ai raggi X.
2) Scopami e dimmi…
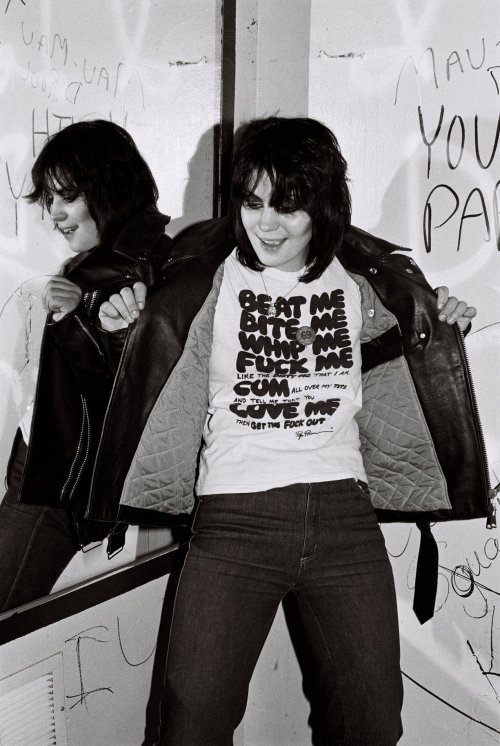 La scritta è lunghissima, quasi un romanzo: “Beat Me, Bite Me, Whip Me, Fuck Me Like The Dirty Pig That I Am, Cum All Over My Tits And Tell Me That You Love Me.Then Get The Fuck Out”. Significa: “Picchiami, mordimi, frusta, fottimi come lo sporco maiale che sono, sborrami sulle tette e dimmi che mi ami. Quindi vattene fuori dal cazzo”. La maglietta risale al 1977 ed è una creazione di Malcolm McLaren e della britannica Vivienne Westwood, la stilista del movimento punk sempre sopra le righe e provocatrice. In questa foto la T-shirt è indossata dalla cantante Joan Jett.
La scritta è lunghissima, quasi un romanzo: “Beat Me, Bite Me, Whip Me, Fuck Me Like The Dirty Pig That I Am, Cum All Over My Tits And Tell Me That You Love Me.Then Get The Fuck Out”. Significa: “Picchiami, mordimi, frusta, fottimi come lo sporco maiale che sono, sborrami sulle tette e dimmi che mi ami. Quindi vattene fuori dal cazzo”. La maglietta risale al 1977 ed è una creazione di Malcolm McLaren e della britannica Vivienne Westwood, la stilista del movimento punk sempre sopra le righe e provocatrice. In questa foto la T-shirt è indossata dalla cantante Joan Jett.
3) Sbattitene i coglioni
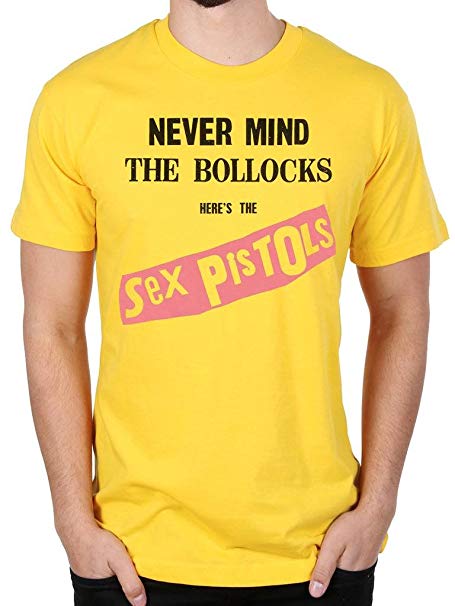 Questa maglietta riproduce la copertina dell’omonimo album pubblicato dai Sex Pistols nel 1977: “Never Mind The Bollocks, here’s the Sex Pistols”. Ovvero: sbattitene i coglioni, ecco i Sex Pistols. Un inno senza filtro alla ribellione anarchica incarnata dal celebre gruppo punk inglese.
Questa maglietta riproduce la copertina dell’omonimo album pubblicato dai Sex Pistols nel 1977: “Never Mind The Bollocks, here’s the Sex Pistols”. Ovvero: sbattitene i coglioni, ecco i Sex Pistols. Un inno senza filtro alla ribellione anarchica incarnata dal celebre gruppo punk inglese.
4) Il marchio “vaffanculo”
 Uno dei pionieri, in Italia, dell’abbigliamento scurrile è stato il marchio “vaffanculo”, lanciato nel 1997. L’idea è di uno psichiatra napoletano, Claudio Ciaravolo, che ha lanciato, sul sito vaffanculo.com, un’intera linea di vestiario (magliette, ma anche scarpe, cintura, borsa, cravatte, anelli, orecchini, ombrello, mutande, orologio e zaino) griffata “vaffa” in tutte le possibili varianti: dito medio, VFFNCL, vaffanculo, fuck off, VFK, da sole o abbinate al dito medio. «L’idea è nata per provocazione culturale» dice. «Le marche non sono altro che nomi vuoti che spesso coprono vestiti di scarso valore, ormai uno vale l’altro. E allora? Vaffanculo!».
Uno dei pionieri, in Italia, dell’abbigliamento scurrile è stato il marchio “vaffanculo”, lanciato nel 1997. L’idea è di uno psichiatra napoletano, Claudio Ciaravolo, che ha lanciato, sul sito vaffanculo.com, un’intera linea di vestiario (magliette, ma anche scarpe, cintura, borsa, cravatte, anelli, orecchini, ombrello, mutande, orologio e zaino) griffata “vaffa” in tutte le possibili varianti: dito medio, VFFNCL, vaffanculo, fuck off, VFK, da sole o abbinate al dito medio. «L’idea è nata per provocazione culturale» dice. «Le marche non sono altro che nomi vuoti che spesso coprono vestiti di scarso valore, ormai uno vale l’altro. E allora? Vaffanculo!».
5) Sono con uno stupido
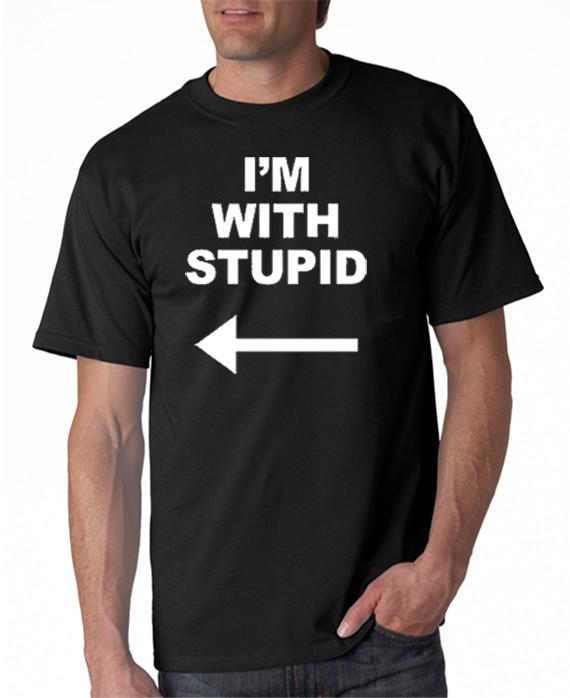 Questa è più di una T-shirt: è una performance. Se chi la indossa si avvicina a un’altra persona, riesce a insultarla senza aprire bocca. Un effetto davvero comico, che ha decretato il successo planetario di questo capo d’abbigliamento.
Questa è più di una T-shirt: è una performance. Se chi la indossa si avvicina a un’altra persona, riesce a insultarla senza aprire bocca. Un effetto davvero comico, che ha decretato il successo planetario di questo capo d’abbigliamento.
6) Keep calm un cazzo…
 Lo slogan “Keep Calm and Carry On” fu coniato dal governo britannico nel 1939 agli albori della seconda guerra mondiale: serviva a invogliare la popolazione a mantenere l’ottimismo e non farsi prendere dal panico in caso di invasione nemica. Ma rimase poco conosciuto fino a quando una copia del poster fu riscoperta nel 2000 da Barter Books , una libreria di Alnwick, nel Regno Unito. Da allora è stato utilizzato come tema decorativo per una gamma di prodotti, ma in Italia ha preso una piega decisamente goliardica, con decine di varianti.
Lo slogan “Keep Calm and Carry On” fu coniato dal governo britannico nel 1939 agli albori della seconda guerra mondiale: serviva a invogliare la popolazione a mantenere l’ottimismo e non farsi prendere dal panico in caso di invasione nemica. Ma rimase poco conosciuto fino a quando una copia del poster fu riscoperta nel 2000 da Barter Books , una libreria di Alnwick, nel Regno Unito. Da allora è stato utilizzato come tema decorativo per una gamma di prodotti, ma in Italia ha preso una piega decisamente goliardica, con decine di varianti.
7) Fanculo al cancro

Negli Stati Uniti è stata fondata un’associazione che affronta un tema delicatissimo senza andare per il sottile: “Fuck cancer”, ovvero: Fanculo al cancro (oppure: fotti il cancro). L’associazione è stata fondata nel 2005 da un malato che voleva aiutare altri malati di tumore ad affrontare la lotta contro questa durissima malattia con uno slogan diretto. Un approccio fuori dagli schemi e inaudito. Ma, come dice il sito, “Tu avrai pure un problema con la parola “fuck”, ma noi abbiamo un problema con la parola ‘cancro'”.
8) F**K, che costumi!
 Particolare la storia di un marchio di abbigliamento da spiaggia italiano: si chiama F**K (fuck). In origine, la ditta – con sede ad Andria – si chiamava Giorgio Srl, perché l’aveva fondata nel 1985 l’imprenditore Franco Giorgio. Quando nel 2011 l’azienda andò in crisi, invece di chiudere decise di resistere, lanciando un nuovo marchio. Come chiamarlo? Una collaboratrice aveva sulla scrivania un disegno con quella scritta, che fu adottata “per esprimere la forza e lo spirito combattivo dell’azienda: non arrendersi mai”.
Particolare la storia di un marchio di abbigliamento da spiaggia italiano: si chiama F**K (fuck). In origine, la ditta – con sede ad Andria – si chiamava Giorgio Srl, perché l’aveva fondata nel 1985 l’imprenditore Franco Giorgio. Quando nel 2011 l’azienda andò in crisi, invece di chiudere decise di resistere, lanciando un nuovo marchio. Come chiamarlo? Una collaboratrice aveva sulla scrivania un disegno con quella scritta, che fu adottata “per esprimere la forza e lo spirito combattivo dell’azienda: non arrendersi mai”.
9) Vada a bordo, cazzo!
 La frase (e la T-shirt) è ispirata al tragico naufragio della Costa Concordia avvenuto nel 2012. La frase era stata pronunciata dal comandante Gregorio De Falco della Capitaneria di porto, che al telefono aveva esortato il comandante Francesco Schettino a tornare sulla nave che aveva abbandonato. La frase, riportata dai giornali con tanto di audio, ha fatto il giro del mondo.
La frase (e la T-shirt) è ispirata al tragico naufragio della Costa Concordia avvenuto nel 2012. La frase era stata pronunciata dal comandante Gregorio De Falco della Capitaneria di porto, che al telefono aveva esortato il comandante Francesco Schettino a tornare sulla nave che aveva abbandonato. La frase, riportata dai giornali con tanto di audio, ha fatto il giro del mondo.
10) Turismo da figli di Troja
 Come promuovere il turismo nella città di Troia (provincia di Foggia)? L’associazione A.c.t.! Monti Dauni, impegnata nella tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale della città, nel 2013 lanciò una T-shirt che aveva il seguente slogan: “Figlio di Troja”, con l’ulteriore scritta “di patria ma non di madre”. Sul retro, invece, campeggiava il più pudico slogan “Figlio di Puglia”. Non si sa quanti abbiano avuto il coraggio di indossarla.
Come promuovere il turismo nella città di Troia (provincia di Foggia)? L’associazione A.c.t.! Monti Dauni, impegnata nella tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale della città, nel 2013 lanciò una T-shirt che aveva il seguente slogan: “Figlio di Troja”, con l’ulteriore scritta “di patria ma non di madre”. Sul retro, invece, campeggiava il più pudico slogan “Figlio di Puglia”. Non si sa quanti abbiano avuto il coraggio di indossarla.
11) Stronzo Bestiale for president
 Una delle T-shirt che ha fatto il giro del mondo è ispirata da questo sito: reca le scritte “Stronzo Bestiale for president” e “I’m friends with Stronzo Bestiale” (sono amico di Stronzo Bestiale). L’appellativo era stato scelto da un fisico come firma beffarda in una serissima ricerca pubblicata da una rivista scientifica. Ho raccontato la sua storia nel 2014, e ha fatto il giro del mondo (potete leggerla qui).
Una delle T-shirt che ha fatto il giro del mondo è ispirata da questo sito: reca le scritte “Stronzo Bestiale for president” e “I’m friends with Stronzo Bestiale” (sono amico di Stronzo Bestiale). L’appellativo era stato scelto da un fisico come firma beffarda in una serissima ricerca pubblicata da una rivista scientifica. Ho raccontato la sua storia nel 2014, e ha fatto il giro del mondo (potete leggerla qui).
12) Il brand “Figa power”

Nel 2015 la ditta d’abbigliamento Tes.Med. di Barletta ha lanciato un nuovo brand chiamandolo con un nome che non passa inosservato: “Figa power”. Come spiega il suo sito, “uno strumento ironico di autocelebrazione ed emancipazione femminili”. Ma quante donne avrebbero il coraggio di indossare una maglietta con “FIGA” a caratteri cubitali?
13) Fottitene di quello che ascolti
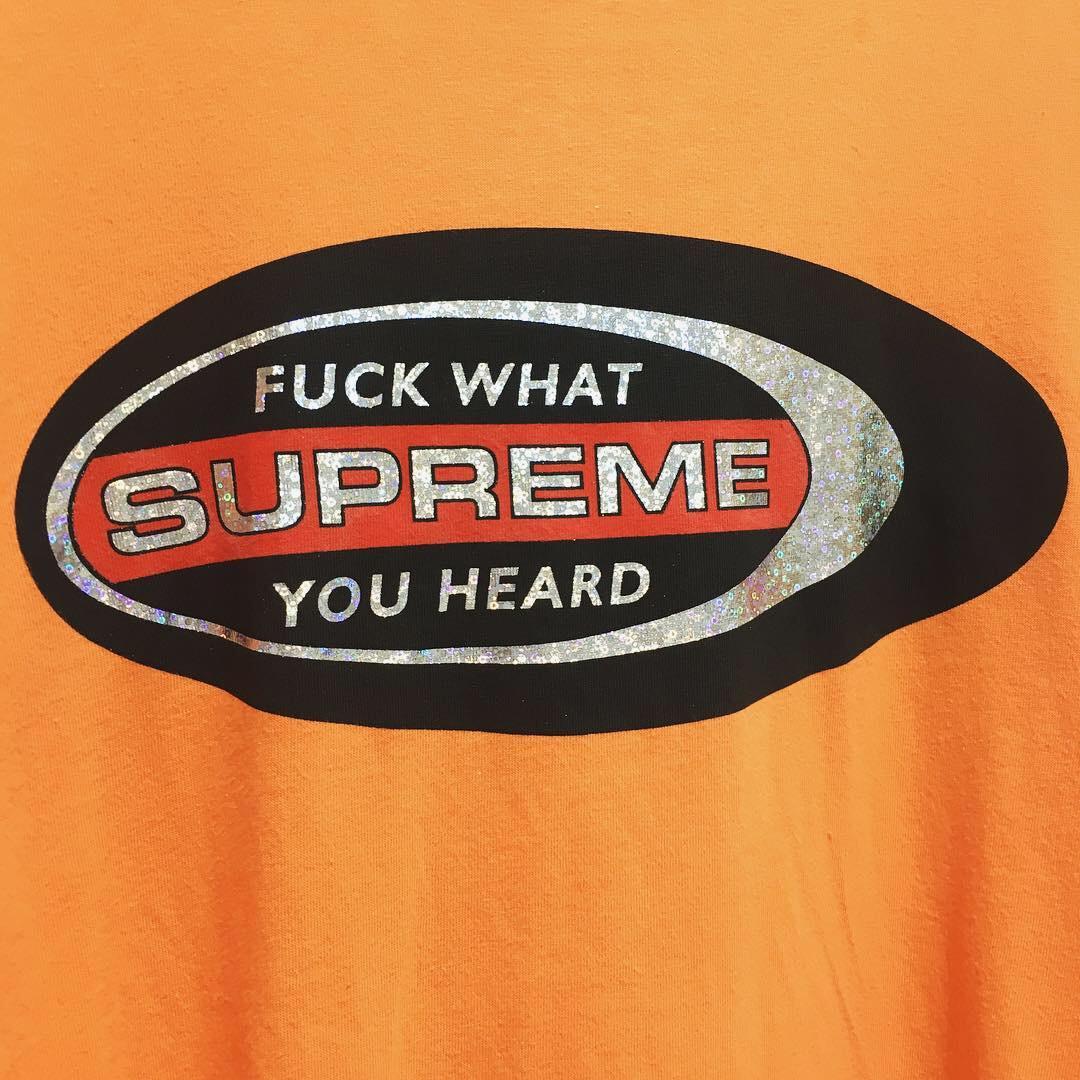 Nel 2016 la Supreme, marchio hip hop giovanile, lancia la T-shirt “Fuck what you heard” (Fottitene di quello che ascolti). Messa “a panino” sul logo del produttore, la scritta diventa “Fuck what Supreme you heard” (fottitene di quello che di supremo hai sentito).
Nel 2016 la Supreme, marchio hip hop giovanile, lancia la T-shirt “Fuck what you heard” (Fottitene di quello che ascolti). Messa “a panino” sul logo del produttore, la scritta diventa “Fuck what Supreme you heard” (fottitene di quello che di supremo hai sentito).
14) Un “vaffa” da scoprire
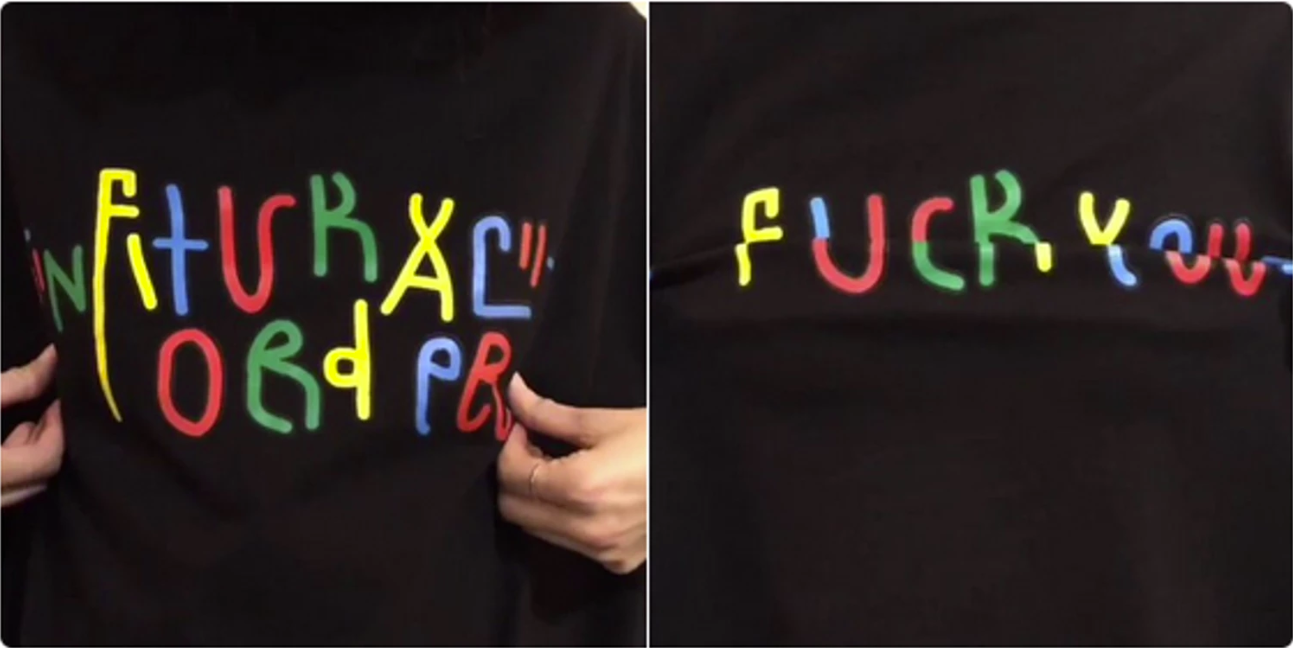 Nel 2016 il marchio Alyx (fondato dallo stilista americano Matthew Williams) lancia una T-shirt con una scritta incomprensibile. Che diventa intellegibile quando si piega in due la maglietta, rivelando la scritta “Fuck you” (vaffanculo). Un virtuosismo sartoriale all’insegna della goliardia.
Nel 2016 il marchio Alyx (fondato dallo stilista americano Matthew Williams) lancia una T-shirt con una scritta incomprensibile. Che diventa intellegibile quando si piega in due la maglietta, rivelando la scritta “Fuck you” (vaffanculo). Un virtuosismo sartoriale all’insegna della goliardia.
15) “Stronzo del cazzo” in passerella
 Questa T-shirt è stata creata nel 2016 dallo stilista georgiano Demna Gvasalia, fondatore del marchio “Vetements”. Gvasalia è uno degli stilisti che attinge alla moda da strada e la trasforma in abiti di lusso: la t-shirt becera è venduta a 980 dollari. La maglietta ha sfilato a Parigi ed ha avuto un ulteriore momento di gloria quando è stata indossata dalla trend-setter Chiara Ferragni. Che un paio d’anni dopo ha messo in vendita sul suo sito una maglietta con la scritta “Italian as fuck”, italiano come fottere.
Questa T-shirt è stata creata nel 2016 dallo stilista georgiano Demna Gvasalia, fondatore del marchio “Vetements”. Gvasalia è uno degli stilisti che attinge alla moda da strada e la trasforma in abiti di lusso: la t-shirt becera è venduta a 980 dollari. La maglietta ha sfilato a Parigi ed ha avuto un ulteriore momento di gloria quando è stata indossata dalla trend-setter Chiara Ferragni. Che un paio d’anni dopo ha messo in vendita sul suo sito una maglietta con la scritta “Italian as fuck”, italiano come fottere.
16) Fanculo, paparazzi
 Sempre nel 2016 Nick Knight, titolare del sito di moda Showstudio, ha escogitato una maglietta volgare anti-paparazzi. All’apparenza sembra una comune T-shirt nera; ma quando viene illuminata dalla luce di un flash, appare la scritta “Fuck you cunt” (vaffanculo testa di cazzo) scritta in caratteri riflettenti. “L’idea mi è venuta quando ho visto la mia amica Kate Moss (super modella, nella foto) assediata da 20 paparazzi all’aeroporto di Los Angeles. E’ arrivata al punto di doversi nascondere sotto la sua valigia. Ora, con questa maglietta potrà difendersi. Ed esprimersi”.
Sempre nel 2016 Nick Knight, titolare del sito di moda Showstudio, ha escogitato una maglietta volgare anti-paparazzi. All’apparenza sembra una comune T-shirt nera; ma quando viene illuminata dalla luce di un flash, appare la scritta “Fuck you cunt” (vaffanculo testa di cazzo) scritta in caratteri riflettenti. “L’idea mi è venuta quando ho visto la mia amica Kate Moss (super modella, nella foto) assediata da 20 paparazzi all’aeroporto di Los Angeles. E’ arrivata al punto di doversi nascondere sotto la sua valigia. Ora, con questa maglietta potrà difendersi. Ed esprimersi”.
17) Anche stasera si tromba domani
 E’ una delle numerose e creative T-shirt goliardiche che si possono trovare in vendita in varie località turistiche e non. La maglietta attenua il senso volgare della frase usando un rebus. Un escamotage usato anche da una maglietta che ritrae un’oca fra le lettere “ST” e “ZZO” per comporre la scritta “Sto cazzo”.
E’ una delle numerose e creative T-shirt goliardiche che si possono trovare in vendita in varie località turistiche e non. La maglietta attenua il senso volgare della frase usando un rebus. Un escamotage usato anche da una maglietta che ritrae un’oca fra le lettere “ST” e “ZZO” per comporre la scritta “Sto cazzo”.
18) Bastardo, anzi peggio

Vivienne Westwood colpisce ancora. Nel 2017, a 76 anni d’età, ha presentato alle sfilate della Settimana della moda di Londra un modello di T-shirt con la scritta “Mother fucker” (letteralmente: uno che si scopa la madre), ovvero “bastardo, figlio di puttana”. La stilista non si è limitata a disegnare la maglietta, ma l’ha indossata stando a cavalcioni su un modello che sfilava in passerella.
19) Fatti i cazzi tuoi
 Questa T-shirt è un messaggio per chi la vede. E anche un modo spiritoso di valorizzare un modo di dire italiano, tanto che – sotto la scritta – campeggia un altrettanto ironico “italian style”. Sono numerose le magliette dedicate ai modi volgari di dire, anche dialettali: da “sti cazzi” a “suca”.
Questa T-shirt è un messaggio per chi la vede. E anche un modo spiritoso di valorizzare un modo di dire italiano, tanto che – sotto la scritta – campeggia un altrettanto ironico “italian style”. Sono numerose le magliette dedicate ai modi volgari di dire, anche dialettali: da “sti cazzi” a “suca”.
20) Uno straccio di scandalo

La maglietta ha fatto scalpore alla settimana della moda di Londra pochi giorni fa (2019). Era una T-shirt da baseball bianca e rossa, e recava la scritta, vergata con un pennarello: “My Other T-Shirts A Cum Rag”, ovvero: “Le mie altre magliette sono stracci per la sborra”. A completare il quadro, era indossata da un modello con le occhiaie enfatizzate dal trucco. L’ha realizzata un giovane stilista, Gareth Wrighton, ed è diventata virale sul Web: che poi abbia successo anche nei negozi (ammesso che sarà messa in commercio) è tutto da vedere.
21) A Sanremo
 E’ l’anno 2005 e la cantante Marcella Bella porta al festival di Sanremo un brano intitolato “Uomo bastardo”: la canzone racconta la storia di un amore masochistico per un uomo che una donna divide con un’altra donna. La cantante si presenta sul palco con un abito sul quale è ricamato il titolo del brano, sia di fronte che dietro.
E’ l’anno 2005 e la cantante Marcella Bella porta al festival di Sanremo un brano intitolato “Uomo bastardo”: la canzone racconta la storia di un amore masochistico per un uomo che una donna divide con un’altra donna. La cantante si presenta sul palco con un abito sul quale è ricamato il titolo del brano, sia di fronte che dietro.
[ fai clic sul + per espandere la finestra qui sotto ]
Se vi è piaciuto questo post, potrebbero interessarvi:
Le parolacce nell’arte moderna
Quando il logo straniero diventa indecente in italiano

Mariangela Melato e Giancarlo Giannini: in questo film hanno fatto un’interpretazione straordinaria.
Quando uscì nelle sale gli fu imposto il divieto di visione ai minori di 14 anni: per le scene erotiche e “per il linguaggio triviale, alquanto persistente”. Eppure è diventato un campione d’incassi e un film cult, che ha segnato la storia del turpiloquio cinematografico. Perché senza tutte quelle volgarità (probabilmente un record) il film non avrebbe fatto epoca. E non sarebbe stato neppure credibile.
Sto parlando di “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto” di Lina Wertmüller. Quest’anno il film compie 45 anni: in occasione della Mostra internazionale del cinema di Venezia, ho deciso di dedicargli un articolo. Per mostrare come le parolacce possano essere al servizio di un film profondo, a dispetto delle apparenze scanzonate. E anche perché i suoi dialoghi scurrili sono un vero capolavoro di ritmo, mordacità e comicità. Molte battute folgoranti del film, infatti, sono entrate nella memoria storica e nei modi di dire: ecco perché ho trascritto interi spezzoni del film, che sono ancora oggi un raro esempio di maestria narrativa.

La regista Lina Wertmüller (Wikipedia).
Il film racconta la storia di un marinaio catanese, Gennarino Carunchio (Giancarlo Giannini), che naufraga su un’isola deserta e selvaggia insieme a una donna milanese Raffaella Pavone Lanzetti (Mariangela Melato). I due si innamorano, ma quando poi tornano nella civiltà le loro strade si dividono.
Detta così sembra una trama come tante. Ma in realtà è molto originale, perché la storia si gioca su forti contrasti sociali: quello fra poveri e ricchi, fra sud e nord, fra sinistra e destra, fra uomo e donna. Carunchio incarna infatti il povero, meridionale, comunista e maschilista, e la Lanzetti la ricca, milanese, radical-chic (o socialista) e femminista. Due personaggi interpretati magistralmente dalla coppia Giannini-Melato.
E a questi contrasti sociologici se ne aggiunge un quinto di tipo filosofico: quello fra natura (incarnata dal manesco e pratico Carunchio, oltre che dalle selvagge spiagge della Sardegna) e cultura (la snob ed erudita Lanzetti). “Tu sei l’uomo come doveva essere nella natura, prima che tutto si deformasse”, dice ammirata Raffaella a Gennarino. Aggiungendogli, quando lui le propone di provare a tornare alla civiltà, “Perché rientrare in quegli schemi? E’ un ingranaggio mostruoso”. E infatti quell’ingranaggio alla fine riuscirà a disintegrare il loro amore impetuoso.
Dunque, non un consueto incontro fra uomo e donna, ma un’impossibile sintesi degli opposti: il diavolo e l’acqua santa. Nitroglicerina allo stato puro. Ecco perché, soprattutto fra i due, scoccano scintille sotto forma di litigi, botte e soprattutto insulti. Che esprimono odio allo stato puro. Oltre, naturalmente, alle scintille dell’erotismo, che in questo gioco di contrasti arriva a punti bollenti: “Buttana, io ti odio ma mi piaci”; confesserà Carunchio. E lei perderà la testa.
Se consideriamo che il film fu girato nel 1974 e diretto da una donna, si apprezza ancor più la sua portata rivoluzionaria. Tra l’altro, a ottoobre la Wertmüller riceverà l’Oscar alla carriera.
Di cinema e parolacce parlerò alla 76a Mostra internazionale del Cinema di Venezia (Italian Pavilion, Hotel Excelsior Venezia Lido) mercoledì 4 settembre alle 15:00.
Con un interlocutore d’eccezione: Gianni Canova, critico cinematografico e professore di storia del cinema. Canova ha appena dedicato un numero della rivista 8 e 1/2 (dell’Istituto Luce Cinecittà) proprio al rapporto fra cinema e parolacce.
Dunque, se siete al Lido di Venezia, sarà un’occasione per riflettere – una volta tanto – su come il turpiloquio abbia contribuito a rendere viva la settima arte.
Buttana industriale. E socialdemocratica
Il film si gioca su dialoghi scoppiettanti, nei quali le parolacce sono una continua giostra emotiva, dalla prima (“Questo paradiso di spiaggia lo riempiranno di merda, rifiuti e buste di plastica”) all’ultima battuta (“Ma come cazzo si fa a campare?”).

“Lezione numero 1”: una delle espressioni di Giannini.
La Wertmüller non si è limitata a usare pochi termini scurrili (tre vincono su tutti: buttana, troia, fitusa) ma ha prodotto un vero florilegio di variazioni sul tema, attingendo a più di 30 modi di dire popolari e dialettali, non solo siciliani ma anche napoletani: vaffanculo, rincoglionito, spappolare le palle, palle, cazzo, stronzo, troia, fitusa (in siciliano, puzzolente, schifosa), rompere la minchia, coglione, negro, scemenza, vaffanculo, zoccola, puttana, maiala, cornuto, sticchio (fica in siciliano), vafammocca (in napoletano, vai a fare un bocchino), sgualdrina, cacà u cazz (cagare il cazzo), cazzi da cacare, brutto abissino, terrone, postaccio di merda, porcona, sciacquetta, meretrice, culo, zizze, cretino, fottere, cocò (cocotte, prostituta).
E a questo ricco repertorio ha aggiunto anche alcune invenzioni espressive che sono passate alla storia: buttana industriale (un rafforzativo grottesco di “puttana”), socialdemocratica (una forma di disprezzo per chi sta al centro ma strizza l’occhio alla sinistra), che diametro (= che culo), faccio quello che stracatacazzo (un rafforzativo di cazzo) mi pare, scarrafuciona (probabilmente un accrescitivo di scarrafona, scarafaggio), sottoschifo di cameriere.
Nel film, tutte queste scurrilità servono ad alimentare la dialettica fra i due protagonisti. E a mostrare il carattere dei due protagonisti così agli antipodi. Lui, Carunchio, usa un dizionario grezzo e di bassa leva anche se creativo; lei, la Pavone-Lanzetti, un lessico più erudito ma meno graffiante. E in questo contrasto le risate sono assicurate. Anche perché le battute sono condite dall’accento siciliano di lui, e da quello milanese (e con l’erre moscia) di lei.
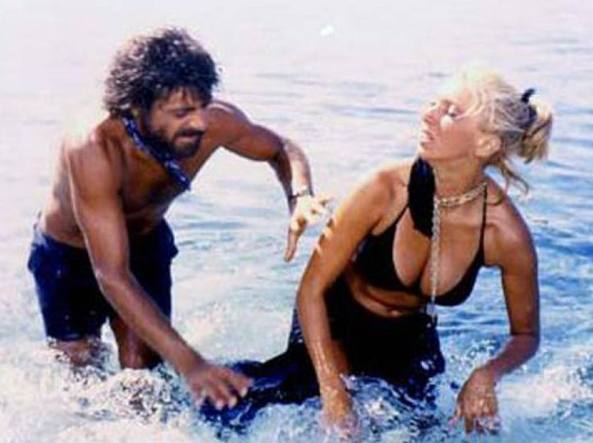
I primi scontri fisici durante lo sbarco sull’isola.
Quando Raffaella, appena sbarcata sulla spiaggia, pretende che Gennaro salga di nuovo in cima al monte dell’isola per guardare se è abitata, e lui si rifiuta, lei sbotta in un “E’ inutile cavare acqua dalle rape”.
Carunchio, che fino ad allora, era riuscito più o meno a controllarsi, sbotta senza freni. “Senti, donna Raffaella Pavone-Lanzetti. Ora mi hai rotto la minchia! Faccio quello che stracatacazzo mi pare, gioia. Ma chi ti credi di essere? Ma vaffanculo!”. E qui inizia uno dei tanti duelli verbali del film.
LEI: “Cafone!”
LUI: “Va-ffan-cu-lo!”.
LEI: “’Sto stronzo!”.
LUI: “Scarraafuciona!”.
LEI: “Butto porco!”.
LUI: “Puttana, troia, zoccola, puttana, maiala!”.
LEI: “Brutto mozzo trinariciuto del cavolo!”.
LUI: “La signora di questa minchia! Meretrice, troia, sgualdrina!”.
LEI: “Stronzonissimo!”.
LUI: “Fitusa, gran mignotta! Vaffammocca a zì Nicola. Nu povirazzo arriva il momento che si caca u cazzo, o no?!”.
LEI: “Vigliacco d’un immaturo! Che roba di sottoproletariato”.
LUI: “E’ finito Gennarino. Buttana, troia. Ora pì ttia sono cazzi da cacare. Ora ci divertiamo, signora. Sono minchie amare”.
LEI: “Eh, la rivolta dello schiavo. La presa della Bastiglia”.
LUI: “Bagascia, sgualdrina, prostituta e cocò (cocotte, prostituta)”.
LEI: “Spartacus! ‘Sto stronzo. ‘Sto cafone del cavolo!”.
LUI: “Sciacquetta! Porca! E socialdemocratica”.

I due protagonisti litigano sul canotto, prima del naufragio.
Un contrappunto perfetto. Gennarino – da buon maschilista – attacca soprattutto con insulti sessisti: il che appare una scelta povera, visto che Giannini interpreta un dirigente del Partito Comunista, che come tale avrebbe dovuto avere un vocabolario più ricco, anche negli insulti. Ma forse la Wertmüller ha voluto dipingerlo soprattutto come un maschilista siciliano vecchio stampo. Questo, comunque, non gli impedirà (come vedremo più sotto) di argomentare il suo disprezzo anche con analisi sociali ed economiche.
La Melato-Lanzetti, invece, usa insulti snob, perfettamente intonati alla sua personalità. L’elenco è così vario, creativo e divertente che merita di essere pubblicato integralmente: cretino, imbecille, stramicione (pigro, indolente) meridionale, mammalucco, brutto mozzo trinariciuto del cavolo, stronzo, Spartacus, carogna d’un vigliacco, comunista del cazzo, bestiaccia nera, peggio di Hitler, carogna, ridicolo e vile, bestia, esemplare di maschio mediterraneo, roba di sottoproletariato, porco, maleducato, cafone, brutto abissino, mi fai schifo, lei è un verme.

L’aragosta: cibo da ricchi, ma anche da naufraghi capaci di pescare.
Il cuore del film, come ho detto sopra, è il contrasto sociale fra ricchi e poveri. Visto da una prospettiva dichiaratamente marxista. Il film inizia evidenziando le differenze di classe, di vita e di trattamento reciproco dei due protagonisti. Ma la vita selvaggia sull’isola, il ritorno alla primordiale lotta per la sopravvivenza annulla le differenze. Anzi: se sullo yacht Gennarino deve chinare il capo e subìre qualunque angheria dalla riccona, sull’isola è lui ad avere il potere perché è l’unico in grado di procurare il cibo e l’acqua con cui sopravvivere.
Dopo il diverbio iniziale, infatti, i due si dividono. Ma mentre lei non ha la più pallida idea di come procurarsi da mangiare, lui riesce a pescare e cuocere una magnifica aragosta. E non la divide con lei che gliene chiedeva un pezzo per umana pietà.
“Sappia che lei è un miserabile, carogna di un vigliacco! Ci deve essere una legge…. Star lì a mangiare lasciando digiuni gli altri”, lo accusa lei.
“Eh già, ma bisogna riflettere!” risponde il comunista Carunchio. “Se ci stava una legge del genere, stavano in galera tutti i ricchi del mondo! Ma siccome questa legge non c’è, in galera ci stanno solo i poveri”.
“Comunista del cazzo! Naturaccia di merda, bestiaccia nera, che carogna! T’el chì come lo usano il potere, ricattando e affamando. E approfittando. Peggio di Hilter. Piuttosto mi lascio morire di fame…”.

Donna Raffaella provata dalla spartana vita da naufraga.
[ Ma i morsi della fame le fanno subito cambiare registro.]
LEI: “Mi venda quel pesce. Glielo pago quello che vuole. 100mila, 200mila? Che cavolo vuole per quel pesce? Ce lo pago mezzo milione carogna!”.
LUI: “E continua a insultare eh? Eh lo so, è brutto stare di sotto. Le dico una cosa. Questo pesce non lo vendo. Ho deciso di fare come voi quando bruciate le mele e le arance per tenere alti i prezzi”.
LEI: “Assassino!”.
LUI: “No, io sono ignorante e incompetente. Gli assassini organizzati siete voi! Comunque stammi a sentire femmina. Lezione numero 1: denaro per cumprare chistu pesce nun ce n’è. Se te lo vuoi comprare, questo pesce, te lo devi guadagnare. me spiego? Lavami i mutandi ah!? Eh, donna Raffaella non aveva lavato mai le mutande. Perché era stata sempre di sopra.E ora che si trova di sotto ci tocca imparare a lavare i mutandi… Ma il lavoro nobilita l’uomo, a maggior ragione la femmina”.
E così donna Raffaella gli lava le mutande, conquistando il diritto di una porzione di cibo. Ma non si dà per vinta:
“Perché fa pagare tutte a me le rivendicazioni sociali e le ingiustizie della vita? Cos’è che ci guadagna? Se lei sarà gentile con me le sarò grata” prova a blandirlo.
Ma lui non cede, anzi rilancia: “Se vuoi stare qui, devi lavorare! E’ finita la pacchia, perché la femmina è nata per fare la serva all’uomo. Bacia la mano al padrone!”.
“Mai!”.
“Brutta buttana industriale che mi facisti sputare sangue su quella maledetta barca!”.
“Lei è un verme!”.
“Lezione numero 2: hai capito femmina, che non ti posso permettere più di insultarmi?! Non rispondere, femmina, Stai zitta, obbedisci! In piedi voglio essere servito! Tu mi invitasti mai al tavolo a sedere sullo yacht? La signora di questa minchia: il vino è caldo, la pasta è scotta, il caffè è riscaldato….”.

Il celebre pestaggio sulle dune: una vendetta per i soprusi socio-economici.
Alla fine, le loro posizioni inconciliabili sfociano nella celebre scena del pestaggio sulle dune, in cui Gennarino punisce in Raffaella tutti i soprusi che le classi più umili hanno dovuto subìre da ricchi e potenti:
“Brutta carogna, finalmente posso darti la lezione che ti meriti!”
“Aiuto!”
“E chi ti può aiutare, cretina! Dove scappi brutta fitusa! A calci in culo ti prendo, brutta buttana industriale socialdemocratica!”.
“Vigliacco verme schifoso!”.
“Devi pagare tutto! Questo [le dà uno schiaffo] è per la crisi economica in cui ci precipitasti a non pagare le tasse e a portare i soldi alla Svizzera, te, e tutti gli altri come a tia!.
Questo [le dà un calcio] è per gli ospedali che un poveraccio non ci riesce a entrare mai, che magari è meglio perché se ci entra muore. E questo [spintone] è per l’aumento della carne, del parmigiano, delle tariffe filo-tramviarie del treno e l’aumento della benzina. Per l’aumento dell’olio e della cassa integrazione. Questo [pugno] è per l’Iva e per l’una tantum, E questo [altro pugno] è perché ci avete fatto venire paura anche di campare”.
Più espliciti di così non si poteva essere.

Giannini e Melato: un rapporto molto fisico, oltre che verbale.
Nella dialettica fra natura e cultura, non poteva mancare una riflessione sul sesso. Quanto c’è di naturale e quanto di “costruito” nel sesso?
Gennaro smonta subito gli atteggiamenti puritani di donna Raffaella, che si indispettisce quando lui le guarda il lato B.
“Ti guardo quanto mi pare e piace! Ti guardo le natiche… E quando stavate sdraiate sullo yacht a prendere il sole con le zizze di fuori, come se noialtri non ci fossimo? E invece credo che voi poccone (porcone) lo sapevate benissimo che eravamo uomini e vi piaceva pensare che ci facevate morire… Bottana industriale, fammele vedere adesso le zizze! Avanti, scoprire il davanzale! Si vergogna la signora? E com’è che prima non ti vergognavi? Voi femmine di lusso, siete brave a provocare”.
Ma a Gennaro non basta un’avventura fisica. Vuole che lei metta da parte tutte le inibizioni e le sovrastrutture culturali per amarlo con una passione totalizzante. La provoca, la coinvolge, e all’ultimo si tira indietro. Una vendetta: come lui era stato schiavo economico, umiliandosi come mozzo, lei sarebbe dovuta diventare una schiava d’amore.

“Bacia la mano al padrone”: una delle frasi maschiliste di Gennaro.
“E ora ti strappo ‘i mutandi. Ti faccio sentire io cos’è un uomo , perché non l’hai conosciuto mai un uomo vero. Buttana industriale, io ti odio ma mi piaci. Confessa che stai a morire… come si lamenta… Fai sì brutta troia! E invece no! Sono io che ti dico di no! Un brutto cafone nero ignorante come a mia, a uno che gli hai detto di cambiarsi la maglietta sudata, che gli hai detto ‘brutto cafone meridionale’, a uno che è stato sempre di sotto come a mia e che ci hai detto che ti fa schifo, non basta che mi dici di sì. Ti devi innamorare. Innamoratissima devi essere, Schiava già ci sei, ma schiava d’amore devi diventare. Devi strisciare come un verme ai miei piedi. Devi chiedere pietà, ti deve prendere un amore nero che ti torce le budella. Passione disperata, peggio di una malattia. Io ti devo entrare dentro la pelle, dentro la testa, dentro il cuore, dentro la pancia. Il tuo dio devo diventare! Passione o niente! Lo devi ancora conoscere Gennaro Carunchio!”.
Quando alla fine sarà riuscito a conquistarla, la Wertmüller fa dire ai due protagonisti un’importante affermazione sul linguaggio scurrile in amore. In amore tutto è lecito, anche le parolacce.
Gennaro dice a lei, che è già pazza di lui:
“La femmina è un oggetto di piacere, trastullo per il lavoratore, puttana da casino!”
“Perché sempre puttana?”.
“Puttana da una parte è un insulto, ma dall’altra può diventare un complimento”.
Detto da una regista donna, è un bell’atto di coraggio. E di onestà intellettuale.
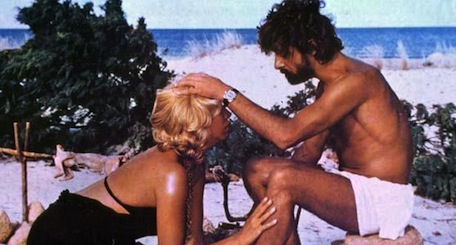
Donna Raffaella, ormai sottomessa e innamorata.
Ma c’è un passaggio ancora più esplicito. Una vera e propria riflessione antropologica sulle parolacce: le scurrilità sono il linguaggio della sincerità, della schiettezza. Chi usa giri di parole e termini forbiti esercita una forma di potere, come i medici quando usano i paroloni scientifici per parlare delle malattie (o gli avvocati quando parlano di leggi).
E’ la celebre scena del “sodomizzami”, che fa da contraltare comico alla scena del “burro” di “Ultimo tango a Parigi”, uscito 2 anni prima.
Raffaella, in preda alla passione, sussurra a Gennaro “Sodomizzami”.
E lui: “Brutta fitusa borghese carognona: ma tu Lo fai apposta per farmi sentire ignorante con queste parole difficili? Ma questa cosa che porcheria è? Io nun te capisco. Che caspita sarebbe?
“Scusa amore”.
“Scusa una cippa di minchia! Che maniera di parlare? Io sono ignorante e me vanto”.
“Scusa amore. Ho detto così perché è una cosa difficile da dire”.
“E poi che è sta cosa? Sodorizzami, sodorazzami, che è?”.
“Sodomizzami… sarebbe… [e si gira]“.
“Chiddu sarebbe? Ma quanto sei complicata. Ma chiama le cose col nome suo!”.
“Ma amore… era una cosa d’amore… non si può … diventa una volgarità”.
“Che volgarità! Nell’amore non c’è volgarità! Ve la siete inventata voi borghesi la volgarità!”.
Riflessione profonda. Le parolacce sono vietate non perché parlino di cose oggettivamente disdicevoli, bensì perché parlano di cose che ci fanno paura: sesso, limiti, malattie, morte. Siamo noi che stabiliamo quello che non si può dire, comportandoci come “borghesi” (benpensanti, mediocri, codardi). La differenza fra parole pulite e volgarità è una scelta arbitraria. Ecco perché ciò che fa scandalo cambia da epoca a epoca, da Paese a Paese. E da persona a persona.

La vita nella natura selvaggia dell’isola.
Come molti film degli anni’70, anche questo ha un finale amaro. La passione fra i due protagonisti, che sembra irrefrenabile, sarà spezzata dal ritorno a una vita convenzionale. L’economia vince sulla vita allo stato naturale.
Gennaro, del resto, aveva dubbi anche quando Raffaella sembrava in preda a un amore inattaccabile:
“Se non facevamo naufragio come stavamo io e te? Io di sotto e tu di sopra. Io poveraccio nero e tu riccaccia bianca. Tu facevi la signora e io una specie di sottoschifo di cameriere. La vorrei proprio vedere la signora Lanzetti passeggiare con questo terrone vicino a Milano”.
E così, dopo aver messo alla prova il loro rapporto tornando nel mondo civile, quando lei – rimangiandosi le promesse d’amore eterno – vola via in elicottero insieme al marito, lui le urla:
“Fitusa traditrice! Buttana! Accidenti a tia, accidenti a quando ti credetti! Lo sapevo che non mi dovevo fidare di una ricca perché i ricchi ti fottono sempre! Buttana industriale che mi lasci solo!”.
Dopo una sbronza colossale, la moglie di Carunchio lo raggiunge al porto, accusandolo di averlo tradito.E i due litigano. Alla fine, l’amara conclusione di Carunchio, sconfitto su tutta la linea: “Ecco, una buttana di sopra (la Lanzetti era fuggita in elicottero), una buttana di sotto e l’amico mare traditore… Ma come cazzo si fa a campare?”
Nel finale, insomma, le volgarità servono a rafforzare l’amarezza e la delusione di Gennaro, sconfitto su tutta la linea. Insomma: finché il rapporto uomo-donna si gioca sul piano della sopravvivenza e della forza fisica, Gennaro è vincente. Ma nella vita moderna, in città, vince chi ha i soldi: può fare il bello e il cattivo tempo, prevalendo anche sulla forza bruta. I ricchi ti fottono sempre.

Nel fotomontaggio, papa Benedetto XIV ritratto da Pierre Subleyras.
Diceva spesso espressioni scurrili. Non solo in privato, ma anche nelle udienze ufficiali. E a chi gli raccomandava di controllarsi, rispondeva che avrebbe concesso l’indulgenza plenaria a chi esclamava “cazzo!” almeno 10 volte al giorno. Fra i 266 papi che hanno guidato la Chiesa, ce n’è stato uno che non aveva peli sulla lingua: Benedetto XIV (1675-1758). Fu uno dei 9 pontefici del 1700, ma non è stato un papa corrotto, rozzo o spregiudicato. Era, semplicemente, un uomo schietto e passionale. E non è stato un papa di cui la Chiesa si vergogna: anzi, è stato uno dei pontefici più stimati della storia, e fu sepolto con tutti gli onori nella Basilica di San Pietro, dove ancora oggi si può vedere il suo maestoso monumento funebre realizzato dallo scultore Pietro Bracci.
In questo articolo vi racconterò la sua storia affascinante e originale. E lancio una proposta: che papa Benedetto – che non fu dichiarato né santo né beato, nonostante una vita esemplare – diventi il patrono del turpiloquio.

Il papa in un francobollo commemorativo (Shutterstock).
Ho scoperto la sua storia straordinaria grazie a un libro, “Vite efferate di papi” (Quodlibet edizioni): uno studio monumentale scritto da un un filologo toscano, Dino Baldi. In oltre 500 pagine, Baldi traccia i ritratti, documentatissimi, di diversi pontefici. Un gruppo nel quale figurano persone di ogni genere: santi e crudeli, ignoranti o raffinati. Del resto, il trono di Pietro è stato per secoli anche una carica di potere, e il potere può corrompere.
Ma Benedetto XIV, in realtà, non era affatto attratto dal potere. Baldi racconta quattro episodi che svelano quali parolacce diceva (li ho evidenziati con il colore marrone): certamente non furono gli unici, ma sono molto significativi. Anche perché in nessuno di questi casi Benedetto XIV insultò qualcuno: usava le volgarità per schiettezza e per sfogarsi, ma non per offendere altre persone. «Non ho notizia di insulti veri e propri» conferma Baldi. «Era una persona amabile, e anche quando si arrabbiava (e capitava abbastanza spesso) se trascendeva recuperava sempre in fretta. La parolaccia, che non era mai greve, gli serviva più per sdrammatizzare o rafforzare un concetto, che non per aggredire».
Faccia bonaria, occhi vivissimi, battute salaci

Un altro ritratto del papa Benedetto XIV di Subleyras.
Benedetto XIV si chiamava Prospero Lorenzo Lambertini, e veniva da una famiglia nobile di Bologna. Corpulento, faccia bonaria, occhi vivissimi, fu eletto papa nel 1740, dopo un conclave durato 6 mesi e 255 scrutini. E accettò l’incarico, disse, non perché avesse desiderato una «tanto eccelsa vanità», quanto per far finire un’adunanza scandalosamente lunga. Durante il conclave che poi lo elesse, pare abbia detto, scherzando: «Se volete un papa santo, scegliete il cardinale Golti, se volete un politico il cardinale Aldrovandi, se volete un minchione, votate per me” (altre fonti dicono: “se volete un asino“).
Baldi racconta che quando si affacciò per la prima volta su piazza San Pietro gremita di folla, il nuovo rimase un attimo a guardare e mormorò fra sé: «Quanta gente… quanta gente…». Poi, rivolto al cardinal Marini che gli stava accanto: «Ma come fa a campare tutta questa gente?». E lui, che conosceva lo spirito del nuovo papa gli disse: «Eh, se lo mettono nel didietro l’uno con l’altro». «Già – disse il papa impartendo la benedizione –, e poi ci siamo noi che lo mettiamo in culo a tutti».
Tanto per far capire che tipo era. Un tipo, in realtà, equilibrato e moderno, oltre che sboccato. Nato nel 1675, dimostrò fin da ragazzino una grande intelligenza, diventando un esperto di diritto canonico apprezzato dalle gerarchie ecclesiastiche.

Moneta commemorativa dedicata a Benedetto XIV.
A 56 anni fu nominato arcivescovo di Bologna per le sue doti diplomatiche: era un brillante ed elegante parlatore. Ma era, soprattutto, un progressista: amava le arti e le scienze, e fece in modo che una delle prime donne laureate della storia, Laura Bassi, potesse insegnare all’università di Bologna. Un atto non da poco, visto che all’epoca il maschilismo, in ambito accademico, era molto più pesante di oggi. Insomma, un approccio egualitario, che mantenne anche quando divenne papa. Durante i 18 anni del suo pontificato rimase infatti un uomo di buon senso e alla mano, allergico ai cerimoniali di corte, e vicino al popolo: spesso camminava nei quartieri popolari di Roma incontrando la gente.
Ma era anche un vero uomo di cultura. Diversamente dai suoi predecessori, riconobbe il valore della scienza: protesse l’Accademia dei Lincei, che promuoveva gli scambi fra gli scienziati, e avviò un rapporto epistolare con Voltaire, l’intellettuale illuminista più celebre (e laico) della sua epoca.
Un papa saggio. E fuori dagli schemi

Il film su Lambertini con Gino Cervi (1954).
Da papa fu più attento alle questioni spirituali che al potere. Ma fece diversi atti rivoluzionari: rimise a posto le finanze pontificie; concesse ai contadini poveri di prendere frutti dai campi pontifici; condannò lo schiavismo nelle Americhe e la massoneria. E cancellò alcune opere di Galileo dall’Indice dei libri proibiti. L’unico, pesante neo del suo pontificato fu che non pose fine alle persecuzioni contro gli ebrei, avviate peraltro dai suoi predecessori.
In ogni caso, è rimasto un papa apprezzato anche a distanza di secoli. Nel 1905 Alfredo Testoni gli dedicò una commedia teatrale, “Il cardinale Lambertini“, che raccontava i suoi anni da cardinale di Bologna. Da quest’opera sono state ricavate due versioni cinematografiche (nel 1934 e nel 1954, con Gino Cervi) e poi uno sceneggiato con Gianrico Tedeschi nel 1983.
Per dire quanto fosse pragmatico e fuori dagli schemi, Baldi ricorda un episodio divertente. Una notte si era precipitato da lui un monsignore. Erano passate le 23 e il papa era a letto da più di un’ora. Ai camerieri che cercavano di trattenerlo disse che doveva comunicare «una cosa gravissima al papa, ne va delle sorti della Chiesa stessa».
Quando svegliarono il papa, il monsignore parlava con frasi spezzate e concitate. Finché, invitato dal papa ad arrivare al dunque, gli disse: «Santità, nel monastero tal dei tali è stata trovata una monaca incinta». «Cazzo! – risposte il papa – Da come la facevate lunga pensavo fosse incinta un frate! Ma dico, voi mi svegliate per questo? Non se ne può parlare domani? Anche se sono il papa non ho mica la virtù di cambiare lo stato di una donna gravida! Lasciate dormire questo povero vecchio, va là». E tornò a letto.
La monaca truffatrice
In esclusiva per parolacce.org, Baldi racconta anche un episodio inedito su Lambertini, prima che diventasse papa.

La tomba di papa Benedetto XIV in San Pietro (Wikipedia).
Quando era ancora un giovane avvocato, si sparse la voce di un miracolo: una monaca romana, già in fama di santità, aveva portato a tale estremo le pratiche del digiuno che non mangiava più, e nonostante questo era in buona salute. Il popolo ci credeva, i medici discutevano del prodigio, e anche nella curia molti propendevano per dare credito alla cosa. Alla fine del 1600, l’allora papa Innocenzo XII ordinò un’inchiesta sulla monaca: ad essa partecipò anche Lambertini, a cui chiese, però, che durante l’interrogatorio della religiosa non aprisse bocca, sapendo quanto gli piacesse scherzare.
Dopo che il monsignore incaricato ebbe rivolto alla vecchia alcune domande rispettosissime, ottenendo risposte che confermavano il miracolo, Lambertini chiese di poter fare un’unica domanda. Una sola, semplicissima: «Reverenda madre» disse con voce umile e dolce «vorrei farle una domanda, solo così, per formalità. Come va lei di corpo?». «Benissimo», rispose la monaca senza pensarci. «Oh un cazzo! Chi non mangia non va di corpo!». E in questo modo si scoprì in effetti che era tutto un trucco architettato dalle monache per dar fama, e quindi denari, al monastero.
L’indulgenza del c…

Ritratto di Giuseppe Maria Crespi: Benedetto XIV nel suo studio.
Diventato papa, Lambertini non rinunciò alla sanguigna passionalità delle espressioni salaci. Si lasciava spesso andare a espressioni scurrili e in particolare non riusciva a liberarsi dell’intercalare «cazzo». Dato che molti gli rimproveravano di essere un po’ troppo sboccato per un pontefice, aveva incaricato il suo affezionatissimo maestro di camera monsignor Boccapaduli di tirargli la tonaca ogni volta che gli fosse sfuggita quella parola di bocca.
Una mattina presto si presentarono i camerieri segreti a riferire come al solito sugli avvenimenti cittadini. C’era stato, dissero, un incendio nel rione Monti. «Cazzo! Ci sono morti?», chiese il papa. Subito Boccapaduli dette una strattonata alla tonaca, e il papa sottovoce: «Avi rason (ha ragione, ndr)…». Continuando il racconto dei fatti di Roma, ogni volta il papa li commentava con un «Cazzo!», e ogni volta il servitore dava uno strappo. Alla fine, stanco di tutto quel tirare, gli urlò contro: «Hai rotto i coglioni Boccapaduli! Cazzo cazzo cazzo! La voglio santificare questa parola! Voglio dare l’indulgenza plenaria a chi la pronunci almeno dieci volte al giorno!». E da allora, nessuno ebbe più da ridire sul suo modo di parlare.
Ma quale impatto ebbe il turpiloquio papale sui suoi contemporanei? «All’interno della corte un po’ di scandalo lo fece, ma nulla di particolarmente grave» risponde Baldi. «Era criticato molto più per i suoi rapporti con gli illuministi francesi o per l’arrendevolezza nei confronti dei principi europei che per le parolacce. Che, anzi, facevano parte del suo “personaggio”, molto amato dal popolo per la sua schiettezza e il senso dell’umorismo». Insomma, questo papa era davvero simpatico, oltre a essere stato una persona aperta e di intelletto fine. Ecco perché lo considero il “patrono” delle parolacce, da festeggiare il 31 marzo, giorno della sua nascita. L’anno prossimo sarà il 345° anniversario.
The post Benedetto XIV, il papa che amava le parolacce first appeared on Parolacce.]]>

Il più celebre autoritratto di Leonardo (1515), con l’aggiunta di un fumetto volgare.
Anche i geni dicono parolacce. Fra loro, come sanno i lettori del mio libro, figurano fra gli altri Dante, Shakespeare e Mozart. E anche Leonardo da Vinci, di cui quest’anno si celebrano i 500 anni della morte (2 maggio 1519).
Ho voluto quindi approfondire il turpiloquio di Leonardo: è un’occasione straordinaria per capire la sua personalità complessa e poliedrica, smontando così un pregiudizio diffuso: ovvero, che dice volgarità solo chi ha un lessico povero, ha poca cultura o pochi contenuti da comunicare (lo ha anche dimostrato una ricerca recente).
Com’è noto, non ci sono rimaste molte testimonianze sulla personalità di Leonardo: le sue biografie sono state scritte tutte dopo la sua morte. Le testimonianze dirette le ha lasciate lui stesso in tutto il corso della sua vita con i quaderni di lavoro, le riflessioni, le copie di lettere, e molto altro materiale.
Fra l’altro, la sua prosa è considerata una delle più alte del Rinascimento: aveva uno stile senza retorica, realista, incisivo, vicino al linguaggio parlato. E le parolacce si sposano bene con il suo approccio diretto e senza fronzoli.
Diari senza filtri

Teste grottesche di Leonardo.
Ma quali sono queste volgarità, e in quali contesti sono usate? Dalla sua sterminata produzione mi sono concentrato sulle sue due opere più intime, quelle che raccolgono le sue riflessioni filosofiche, morali, scientifiche: gli “Aforismi, novelle e profezie” e gli “Scritti letterari”. Sono due zibaldoni che raccolgono materiale molto eterogeneo: pensieri sulla vita morale, osservazioni sui comportamenti degli animali, esperimenti letterari ma anche indovinelli (“profezie”) e barzellette (“facezie”).
Gli “Scritti letterari”, in particolare, furono pubblicati per la prima volta solo nel 1952, e nel 1967 furono ampliati da due manoscritti autografi – quasi 700 pagine – che da secoli giacevano dimenticati nella Biblioteca Nazionale di Madrid. Dunque, a differenza dei suoi progetti tecnici, del trattato della pittura e di un possibile trattato sull’anatomia, questi scritti sono per lo più da considerarsi un diario intimo, probabilmente non destinato alla pubblicazione.
Solo in queste opere ho trovato 10 brani che contengono 13 diverse parolacce, ripetute per un totale di 17 volte. La più usata in questi scritti è “culo”, seguito da “putte” (puttane) e “cazzo”. Ecco l’elenco completo (e in fondo a questo articolo trovate i brani integrali che le contengono):
• putte (puttane), cazzo: 2
• fottere, asino, porci, troie, tette, (s)correggia, coglioni, conno (= fica), potta (= fica), bastardo: 1.
Schietto e ironico

Caricatura di un uomo che ride.
Se queste volgarità sono state scritte in una sorta di diario personale, non sapremo mai se Leonardo le avrebbe inserite in un testo destinato alla pubblicazione; ma il dato è ancor più prezioso perché significa che Leonardo usava le parolacce per esprimersi con se stesso. E probabilmente lo faceva anche quando parlava con altre persone.
Nei suoi testi, i termini scurrili sono usati principalmente per due scopi:
• per esprimere riflessioni amare, argute, disincantate, polemiche, parlando in modo schietto e senza retorica: “pane al pane e vino al vino”.
• per scopi umoristici: fra i brani, infatti, figurano anche alcune barzellette sporche (“facezie”).
Tredici parolacce non sono una quantità esorbitante, ma molto significativa: chi se lo sarebbe mai aspettato dall’autore della “Gioconda”? Non può essere un caso o un incidente: Leonardo conosceva il linguaggio basso e lo praticava, senza pudori. E il fatto non sorprende: le parolacce portano nei suoi scritti una ventata di realismo non imbellettato, lo stesso realismo che mise nelle sue opere di scienziato e di artista. Alla fine, è molto più interessante questo Leonardo, quello vero e multisfaccettato, rispetto a quello dell’inarrivabile maestro venerato dalla cultura di massa.
Gli scritti di Leonardo rivelano un attento osservatore, una persona perennemente curiosa e alla ricerca di risposte sul mondo che lo circonda. Non solo di spiegazioni scientifiche ma anche di soluzioni pratiche. E di saggezza.

Busto di donna deforme.
L’uso del linguaggio basso rivela un tratto importante della sua personalità: amava la sincerità, la schiettezza, il chiamare le cose col loro nome. E non era snob: cercava la verità ovunque fosse, confrontandosi con tutti, e assorbendo quindi anche i termini del linguaggio colloquiale. Se nei dipinti raffigurava ricchi e poveri, potenti e derelitti, belli e brutti, nel suo linguaggio mescolava citazioni dotte e spirito popolaresco. Era curioso del mondo e amava sperimentare e giocare. Ecco perché non aveva tabù, a partire dal linguaggio.
Per esempio, a proposito del pene, trovava assurdo che le persone faticassero a parlarne, anche solo a nominarlo, mentre invece dovrebbe essere mostrato con tutti gli onori, vista la sua importanza nella vita umana. Tanto più che sembra dotato di un intelletto a sè: leggete questo brano eccezionale, che corredo di una “traduzione” in italiano moderno (quella su sfondo azzurro) per chi fatica a comprendere quello del 1400:
| [ la verga ] “conferisce collo intelletto umano, e alcuna volta ha intelletto per sé, e ancora che la volontà dell’omo lo voglia provocare, esso sta ostinato, e fa a suo modo, alcuna volta movendosi da sé, senza licenza o pensieri dell’omo, così dormiente, come desto, fa quello desidera: e spesso l’omo dorme e lui veglia, e molte volte l’uomo veglia e lui dorme; molte volte l’omo lo vole esercitare, e lui non vole; molte volte lui vole, e l’omo gliel vieta. Adunque è pare che questo animale abbia spesso anima e intelletto separato dall’omo, e pare che a torto l’omo si vergogni di nominarlo, non che di mostrarlo, anzi sempre lo copre e lo nasconde, il qual si dovrebbe ornare e mostrare con solennità, come ministro dell’umana spezie”. | il membro virile coopera con l’intelletto umano, e a volte ha un intelletto a sè stante: anche se la volontà dell’uomo lo vuole provocare, lui fa di testa propria in modo ostinato, a volte muovendosi da solo, senza il permesso o la consapevolezza dell’uomo; e sia che dorma o sia sveglio, fa quello che vuole. Spesso l’uomo dorme e lui è sveglio, e molte volte l’uomo è sveglio e lui dorme; molte volte l’uomo lo vuole usare, e lui non vuole; molte volte lui vuole, ma l’uomo glielo vieta. Quindi, sembra che questo animale abbia spesso un’anima e un intelletto separati dall’uomo. E sembra che a torto l’uomo si vergogni di nominarlo, oltre che di mostrarlo, anzi, lo copre e lo nasconde sempre, mentre invece lo si dovrebbe ornare e mostrare con solennità, come alto rappresentante della specie umana. |
Dunque, un osservatore senza falsi pudori, e con uno sguardo ironico sulla realtà. Ma, altrettanto certamente, una persona che non usava il turpiloquio “un tanto al chilo”, cioè tanto per dire. Ne è un esempio eloquente questa barzelletta, tutta giocata su allusioni e doppi sensi che non scadono nel triviale:
| [La lavandaia e il prete]
Una lavava i panni e pel freddo aveva i piedi molto rossi, e, passandole appresso, uno prete domandò con ammirazione donde tale rossezza dirivassi; al quale la femmina subito rispuose che tale effetto accadeva, perché ella aveva sotto il foco. Allora il prete mise mano a quello membro, che lo fece essere più prete che monaca, e, a quella accostatosi, con dolce e sommessiva voce pregò quella che ‘n cortesia li dovessi un poco accendere quella candela. |
Una donna lavava i panni e per il freddo aveva i piedi molto rossi. Passandole vicino, un prete le chiese con ammirazione da dove venisse quel rossore; la donna gli rispose subito che quell’effetto era provocato dal fatto che aveva il fuoco sotto [i piedi]. Allora il prete prese in mano quel membro che lo rendeva più prete che suora, e avvicinatosi alla donne, con voce dolce e sommessa pregò quella donna se per favore gli accendeva un po’ quella candela. |
Dunque, ancora una volta, il turpiloquio rivela la personalità profonda di chi lo usa. Geni compresi. Ecco i brani integrali che contengono le 17 parolacce di Leonardo da Vinci. Buona lettura.
Aforismi, novelle e profezie
| L’omo ha desiderio d’intendere se la femmina è cedibile alla dimandata lussuria, e intendendo di sì e come ell’ha desiderio dell’omo, elli la richiede e mette in opera il suo desiderio, e intender nol pò se non confessa, e confessando fotte. | L’uomo desidera sapere se la donna cederà alla lussuria che le chiede, e capendo che è disponibile, dato che lei desidera l’uomo, lui la richiede e mette in atto il suo desiderio. E non può capire se lei ci sta se non lo confessa (il desiderio) e quindi fotte confessando. |
| Quando si maritano le putte.
Usciranno li omini delle sepulture |
Quando le puttane si sposeranno, gli uomini usciranno dalle tombe |
Scritti letterari
| Chi asino è e cerbio esser si crede… | Chi è un asino e crede d’essere un cervo… |
| Le lingue de’ porci e vitelle nelle budella. O cosa spurca, che si vedrà l’uno animale aver la lingua in culo all’altro. | Le lingue dei porci e delle vitelle nelle salsicce. Che cosa schifosa: si vedrà un animale con la lingua nel culo di un altro
[ Polemica contro chi mangia le salsicce fatte di carni animali: è disgustoso immaginare le lingue dei maiali e dei vitelli nelle budella, cioè nel culo, di altri animali ] |
| Delle sommate* fatte delle troie. A gran parte delle femine latine fia tolto e tagliate lor le tette insieme colla vita. | [A proposito ] delle sommate* fatte con le femmine del maiale. A gran parte delle femmine latine siano tolte e tagliate le mammelle insieme alla loro vita.
*La “sommata” è un salume ricavato dalla mammella dei suini |
| Facezia. Due camminando di notte per dubbiosa via, quello dinanzi fece grande strepido col culo; e disse l’altro compagno: «Or veggo io ch’i son da te amato». «Come?», disse l’altro. Quel rispose: «Tu mi porgi la correggia perch’io non caggia, né mi perda da te». | Barzelletta. Due tizi stavano camminando, di notte, in un tragitto incerto. Il tipo davanti [a un certo punto] fece un gran fracasso col culo; allora l’altro compagno disse: “Ora capisco che mi vuoi bene!”. “In che senso?” disse l’altro. E il primo rispose: “Tu mi porgi la cinghia perché io non cada e non mi perda da te”.
[ la parola “scoreggia” deriva proprio da “coreggia”, cinghia di cuoio; forse perché un peto risuona come uno schiocco di frusta, o forse solo per motivi onomatopeici: la parola ha un suono che ricorda il peto ] |
| Uno andando a Modana ebbe a pagare cinque soldi di gabella della sua persona. Alla qual cosa, cominciato a fare gran cramore e ammirazione, attrasse a sé molti circunstanti, i quali domandando donde veniva tanta maraviglia, ai quali Maso rispose: «O non mi debbo io maravigliare con ciò sia che tutto un omo non paghi altro che cinque soldi, e a Firenze io, solo a metter dentro el cazzo, ebbi a pagare dieci ducati d’oro, e qui metto el cazzo e coglioni e tutto il resto per sì piccol dazio? Dio salvi e mantenga tal città e chi la governa. | Un tizio, andando a Modena, si trovò a dover pagare una tassa per entrare in città. Quando seppe questa cosa, iniziò a protestare in modo rumoroso e stupito: così attirò molti passanti, che gli chiesero perché fosse così meravigliato. Al che il tipo [Maso, Tommaso ] rispose: “Ma come, non dovrei meravigliarmi del fatto che un uomo intero debba pagare 5 soldi, mentre a Firenze, solo per mettere dentro il cazzo, ho dovuto pagare 10 ducati d’oro, mentre qui posso mettere il cazzo, i coglioni e tutto il resto per una tassa così piccola? Dio salvi questa città, e la mantenga in salute insieme a chi la governa. |
| Una putta mostrò il conno d’una capra ‘n iscambio del suo a un prete, e prese un grosso, e così lo beffò. | Una puttana, invece della propria fica, mostrò quella d’una capra a un prete, e guadagnò una bella somma. E così lo beffò.
[ “conno” deriva dal latino cunnus, da cui hanno avuto origine il francese “con”, lo spagnolo “coño” e l’inglese “cunt”, tutti con lo stesso significato di vulva] |
| La femmina nel passare uno tristo passo e fangoso «Tre verità», ella nell’alzarsi colle mani i panni dirieto e dinanzi si tocca la potta e ‘l culo e dice: «Questo è un tristo passo!». | Una donna, mentre attraversa una strada dissestata e fangosa chiamata “Tre verità”, alza con le mani la gonna, sia davanti che dietro, e si tocca la fica e il culo, dicendo: “Questo è un triste passo!”. |
| Uno rimproverò a uno omo da bene che non era legittimo. Al quale esso rispose esser legittimo nelli ordini della spezie umana e nella legge di natura, ma che lui nell’una era bastardo, perch’egli avea più costumi di bestia che d’omo, e nella legge delli omini non avea certezza d’esser ligittimo. | Un tizio contestò a un uomo per bene di essere un figlio illegittimo. L’uomo gli rispose che era legittimo nella sua appartenenza alla specie umana e alla legge di natura, mentre lui, invece, nella prima era bastardo [di origine ibrida], dato che aveva un comportamento più da bestia che da uomo. E che nella legge degli uomini non aveva la certezza di essere legittimo. |
Questo articolo è stato rilanciato dall’agenzia Ansa.
The post Leonardo da Vinci: le parolacce di un genio first appeared on Parolacce.]]>
Fabrizio De Andrè (1940-1999, foto Wikipedia).
È stato uno dei più grandi poeti italiani del ‘900, e le sue canzoni sono state studiate in ogni aspetto. Tranne uno: le parolacce. Ma non sono state marginali nella sua opera: anzi, sono state così rilevanti da aver contribuito al suo successo. Come ricorda Ivano Fossati, «Al liceo ascoltavamo i dischi di Fabrizio De Andrè. Quello che ci piaceva delle sue canzoni è che c’erano le parolacce».
Eppure, le volgarità di De Andrè non sono mai state studiate in dettaglio. Come se fossero un incidente, o un aspetto trascurabile rispetto al lessico, indubbiamente raffinato, dei suoi testi. Ma la scelta di usare il linguaggio basso non è stata un caso. Perché De Andrè metteva una cura maniacale nella scelta di ogni singolo termine, come ricorda Fossati: «Lui sa benissimo che dietro ogni parola c’è una responsabilità, bisogna dire le cose che si condividono realmente. E allora la scelta di un termine, di un sostantivo, di un aggettivo, poteva prendere anche tre giorni». Dunque, se il cantautore genovese ha inserito termini volgari nei suoi testi, l’ha fatto con una scelta mirata e meditata.
D’altra parte, per una persona che amava senza snobismo la cultura popolare, la schiettezza e il realismo, le parolacce hanno rappresentato uno strumento molto efficace, persino in testi raffinati e complessi come i suoi. Insomma, è uno dei pochi artisti che è riuscito a fare poesia alta anche usando il linguaggio basso. Del resto, come egli stesso diceva, “dal letame nascono i fior“.
Per questi motivi ho deciso di fare la prima analisi lessicale sul turpiloquio di De Andrè, studiando tutte le 125 canzoni scritte nella sua carriera. Il risultato è stato sorprendente: ho scoperto che De Andrè ha usato più di 30 diversi termini scurrili, che sono presenti in una canzone su 4. Dunque, le parolacce arricchiscono in modo straordinario la sua tavolozza espressiva, tanto che molte di queste strofe “a tinte forti” sono passate alla storia, come ricorderò più sotto. E rivelano in modo efficace la sua personalità e il suo mondo artistico.
Ho pensato, quindi, che questo studio lessicale fosse un buon modo per ricordare De Andrè, un musicista che ho amato immensamente, nel 20° anniversario della sua scomparsa.
Per questa ricerca ho consultato 3 fonti principali: la voce di Wikipedia su Fabrizio De Andrè, e gli ottimi libri “Falegname di parole” di Luigi Viva (Feltrinelli, 2018) e “Fabrizio De Andrè: il libro del mondo” di Walter Pistarini (Giunti, 2018).
Un ribelle che parlava sporco

De Andrè con Paolo Villaggio (a destra, Wikipedia)
Le parolacce non sono entrate per caso nei dischi di De Andrè. Da giovane, infatti, aveva un linguaggio sboccato, come ha raccontato egli stesso. Ecco come ricorda il suo primo incontro, nel 1948, con Paolo Villaggio (altro mago delle parolacce, come racconto qui): «L’ho incontrato per la prima volta a Pocol, sopra Cortina; io ero un ragazzino incazzato che parlava sporco; gli piacevo perché ero tormentato, inquieto e lui lo era altrettanto, solo che era più controllato, forse perché era più grande di me e allora subito si investì della parte del fratello maggiore e mi diceva: “Guarda, tu le parolacce non le devi dire, tu dici le parolacce per essere al centro dell’attenzione, sei uno stronzo”».
Dunque, De Andrè si definisce «un ragazzo incazzato, che parla sporco e tormentato». E fin da giovane, scriveva canzoni: «Sono sempre stato un inguaribile romantico e insieme un gran polemico, ce l’ho sempre avuta con le ingiustizie della società, con l’ipocrisia; e siccome avevo bisogno di sfogarmi, scrivevo delle storielle che poi mettevo in musica e accompagnavo con la chitarra, togliendomi la gran soddisfazione di dire ciò che pensavo veramente». Per De Andrè, insomma, le canzoni erano un modo di far polemica, di contestare le ingiustizie della società (non a caso, studiò legge all’università). E le parolacce sono proprio il linguaggio della protesta e della polemica, come ci ha mostrato la politica degli ultimi 30 anni in Italia, come raccontavo qui.
Un altro indizio importante è che De Andrè odiava l’ipocrisia: e, da sempre, il turpiloquio è il linguaggio della spontaneità, un modo – rude – di chiamare le cose per quello che sono (come ricordavo qui).
Le statistiche: volgare una canzone su 4
Dunque, nella vita De Andrè parlava sporco. Come si è concretizzato questo aspetto nelle canzoni? Ho fatto un’analisi lessicale della sua produzione: 125 canzoni in 14 album (più 2 singoli. “Una storia sbagliata” e “Titti”) che ha pubblicato in 41 anni di attività. Ho censito solo gli inediti, escludendo i “live”, le raccolte e “I viaggi di Gulliver” (perché i testi non sono suoi). Il risultato è sorprendente: ho censito 33 diversi lemmi volgari, presenti in 62 strofe. Un dizionario ben nutrito, di cui parlerò più avanti. Queste espressioni sono presenti in 29 delle 125 canzoni: il 23,2%, quasi una canzone su 4 contiene volgarità.
E c’è stata un’evoluzione storica: negli anni ‘60 ne ha usate solo 11, che sono salite a 15 negli anni ‘70, ma i picchi si sono registrati nell’ultima parte della sua carriera: 16 parolacce negli anni ‘80, tutte concentrate nell’album in genovese “Crueza de ma”, e 19 negli anni ‘90 in due album.
Per ogni decennio, una media di 15 parolacce, ma con concentrazioni ben diverse: negli anni ‘60 e ‘70 viaggiava a 2-3 parolacce ad album, ma nel ventennio successivo è salito a 8-9,5 parolacce ad album.
Da questa analisi emergono altre curiosità: l’album con più canzoni volgari è del 1971, “Non al denaro non all’amore né al cielo” (5). E la canzone più densa di espressioni scurrili è “A DUMENEGA” (10), in genovese.
I lemmi volgari (di cui più in basso trovate l’elenco completo, strofa per strofa) sono 33 in 62 strofe. E’ una tavolozza molto varia: solo 8 hanno una frequenza di 3 volte o superiore. Sono questi: belìn (cazzo), cù (culo): 6; idiota: 4, bagascia (puttana), carogna, cornuto, porco, puttana: 3. Approfondirò più avanti il significato di questi usi prevalenti.
Ma il dato più interessante di tutti è il tipo di parolacce: la maggior parte (55%) sono insulti, seguiti da termini sessuali (34%). Hanno invece un ruolo marginale i modi di dire (6%), i termini escrementizi (3%) e le maledizioni (2%: il vaffa, per intenderci).

Via del Campo a Genova, con una targa dedicata a De Andrè.
Una delle scurrilità più famose risale ai primi dischi di De Andrè, e si trova nel brano “VIA DEL CAMPO”, del 1967. Il testo descrive uno dei vicoli più malfamati nella Genova degli anni Sessanta, perché rifugio di prostitute, travestiti e gente povera, ossia quegli “ultimi” ai quali il cantautore genovese ha sempre prestato particolare attenzione nei suoi brani. Dopo un inizio molto poetico (“Via del Campo c’è una graziosa, gli occhi grandi color di foglia”), la terza strofa è come un pugno nello stomaco: “Via del Campo c’è una puttana, gli occhi grandi color di foglia, se di amarla ti vien la voglia, basta prenderla per la mano”. Il cambio di registro è sottolineato, musicalmente, da un cambio di tonalità: si sale di un tono e mezzo, passando dal la minore al do minore. In questo modo, la parolaccia raddoppia la sua efficacia, aggiungendo un crudo realismo a una descrizione che rimane garbata. Un risultato non facile da ottenere.
Un’altra strofa a tinte forti che è passata alla storia si trova in “UN GIUDICE” (1971). Il brano racconta di un giudice che si compiace del potere di essere “arbitro in terra del bene e del male” come forma di vendetta per l’emarginazione e il dileggio che ha subìto a causa della sua bassa statura. Il testo a un certo punto dice: “La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, Fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, Perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo”. Anche in questo caso, la parolaccia, inserita al termine di una strofa con uno stacco musicale, ha una grandissima efficacia anche sonora, perché è un improvviso cambio di registro che non passa inosservato.
La canzone, com’è noto, è ispirata all’Antologia di Spoon River (1915) di Edgar Lee Masters,che in Italia fu tradotta da Fernanda Pivano. A lei che gli domanda, nelle note di copertina, come mai abbia usato parole di un linguaggio contemporaneo quasi brutale, De Andrè ha risposto così: «Anche il vocabolario al giorno d’oggi è un po’ cambiato, e io ero spinto soprattutto dallo sforzo di spiegare il vero significato di queste cose. Quanto alla definizione del giudice, questo è un personaggio che diventa una carogna perché la gente carogna lo fa diventare carogna: è un parto della carogneria generale. Questa definizione è una specie di emblema della cattiveria della gente».
Arriviamo poi nel 1984 per ascoltare il brano di De Andrè che ha il numero più alto di parolacce (10) presenti, seppur mitigate dall’uso del genovese: “Ä DUMÉNEGA”. Il brano parla della passeggiata domenicale delle prostitute genovesi, che fino al 1800 erano emarginate, anche se grazie alle loro tasse il Comune riusciva a pagare i lavori del porto. Così la domenica il popolino esce “a guardare le figlie del diavolo, che cazzo di lavoro che cazzo di lavoro”. E le insulta, elencando le loro specialità a seconda delle zone: “a Pianderlino succhia cazzi, alla Foce cosce da schiaccianoci, in Carignano fighe di terza mano, e a Ponticello gli mostrano l’uccello”. Fra quanti le offendono, c’è anche il direttore del porto, il direttore del porto “che ci vede l’oro in quelle chiappe a riposo dal lavoro. Per non fare vedere che è contento, che il molo nuovo ha il finanziamento, si confonde nella confusione con l’occhio pieno di indignazione, e gli grida gli grida dietro: “bagasce siete e ci restate”. Ma a svelare la sua ipocrisia e a rimetterlo al suo posto ci pensa lo stesso De Andrè: “brutto stronzo di un portatore di Cristo, non sei l’unico che se ne è accorto che in mezzo a quelle creature che si guadagnano il pane da nude c’è c’è c’è c’è c’è anche tua moglie”.
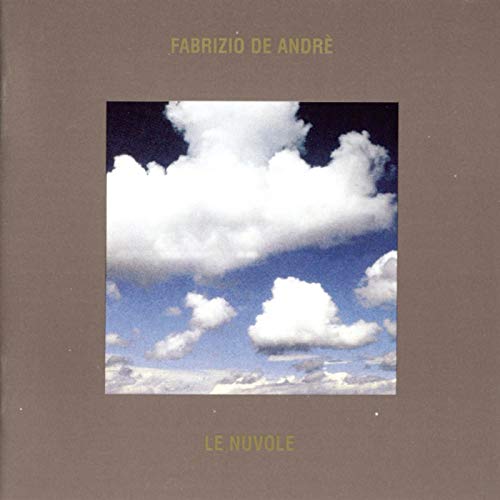
Copertina di “Le nuvole” (1990).
Si stacca, invece, dagli altri brani a sfondo erotico, un’altra canzone storica: “LA DOMENICA DELLE SALME” (1990). E’ un brano politico, onirico e denso di immagini, è una descrizione allusiva del clima dell’Italia di quegli anni. Come racconta il coautore Mauro Pagani: “è la descrizione lucida e appassionata del silenzioso, doloroso e patetico colpo di Stato avvenuto intorno a noi senza che ci accorgessimo di nulla, della vittoria silenziosa e definitiva della stupidità e della mancanza di morale sopra ogni altra cosa. Della sconfitta della ragione e della speranza”. La canzone è sostanzialmente un’invettiva, un urlo di dolore indignato sulla società e la politica. E come Dante Alighieri usò il lessico basso per esprimere un analogo urlo nel “Purgatorio” (“Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave sanza nocchiere in gran tempesta, non donna di province, ma bordello!”) anche De Andrè non si risparmia. Dice dei polacchi che “rifacevano il trucco alle troie di regime”: un riferimento, spiegò, “alla nostra bella società capitalistica; ex comunisti pronti a convertirsi il prima possibile per dimenticare un passato troppo ingombrante (ed esserne così dispensati l’anno dopo)”. Più avanti parla del “ministro dei temporali, in un tripudio di tromboni, auspicava democrazia con la tovaglia sulle mani e le mani sui coglioni”. Durante il colpo di Stato strisciante, i politici che lo hanno in qualche modo appoggiato se non organizzato auspicano, ovviamente, una “loro” democrazia. Per timore che questa venga davvero, fanno il gesto scaramantico di toccarsi i testicoli: un modo per descrivere la volgarità dei loro pensieri, prima ancora che dei loro gesti.
Poi De Andrè canta della “scimmia del quarto Reich che ballava la polka sopra il muro”, un riferimento ai rigurgiti neonazisti in Germania. Aggiungendo che “mentre si arrampicava, le abbiamo visto tutti il culo”, ovvero la sua repellente fragilità. C’è anche un riferimento ai cantanti, che invece di denunciare le storture di questa epoca si sono venduti ai vari potenti di turno, dai comunisti ai leghisti (longobardi): per questo sono stati abbandonati in malo modo dal pubblico (ci guardarono cantare per una mezz’oretta, poi ci mandarono a cagare”). Le loro “voci potenti”, aggiunge con amara autoironia, sarebbero state “adatte per il vaffanculo”. Una specie di profezia del movimento 5 stelle, che ha esordito proprio con un “Vaffa day”.
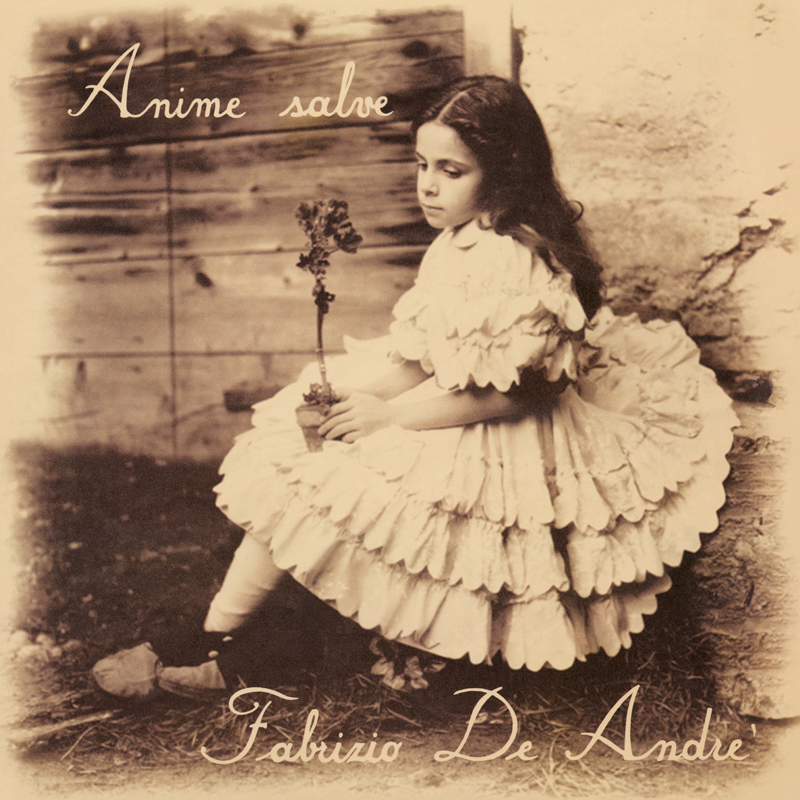
La copertina di “Anime salve” (1996)
L’ultimo, celebre brano scurrile è “PRINÇESA” (1996). E’ la storia di un transessuale realmente esistito, Fernandinho Farias de Albuquerque detto “Prinçesa” perché, nel ristorante dove lavorava, sapeva cucinare il filetto alla parmigiana in modo sublime. De Andrè racconta il suo dramma con termini realisticamente crudi, fin dalla prima strofa: “Sono la pecora sono la vacca, Che agli animali si vuol giocare, Sono la femmina camicia aperta, piccole tette da succhiare”. Quando deve descrivere i suoi rapporti sessuali, tuttavia, De Andrè preferisce prendere le distanze con un linguaggio alto: “Dove tra ingorghi di desideri, alle mie natiche un maschio s’appende, nella mia carne tra le mie labbra, un uomo scivola, l’altro si arrende”. Ma poi torna a descrivere, senza giri di parole, il sogno di Fernandinho di diventare donna: “davanti allo specchio grande Mi paro gli occhi con le dita a immaginarmi tra le gambe una minuscola fica”. Anche in questo caso, la parolaccia, fortissima, giunge inaspettata alla fine della strofa, seguita da un breve intermezzo strumentale come a lasciarla sedimentare (o addolcire) nell’ascoltatore.
[ clicca sul + per aprire il riquadro ]
Gli argomenti: insulti e sesso
Ecco la statistica dettagliata dei termini volgari, suddivisi per tipologia:
| insulti: 18 termini, 34 ricorrenze | idiota: 4 volte
bagascia (puttana), carogna, cornuto, porco, puttana: 3 volte becchino, scemo, troia: 2 volte cialtrone, cretino, galûsciu (stronzo), infame, nèsciu (scemo), loèugu (cesso), pappone, vacca, xàtta (pappone): 1 volta |
| sesso: 8 termini, 21 ricorrenze | belìn (cazzo), cù (culo) : 6 volte
coglioni, mussa (fica), tette: 2 volte fica, öxellu (uccello), scciappe (chiappe): 1 volta |
| enfasi, modi di dire: 4 termini, 4 ricorrenze | bordello, calaba (casino), casin (casino), sputtanare: 1 volta |
| maledizioni: 1 termine, 1 ricorrenza | vaffanculo: 1 volta |
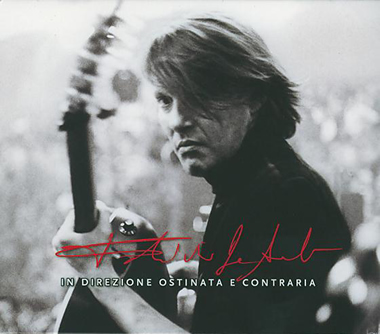
Copertina di “In direzione ostinata e contraria” (2005, antologia)
La maggior parte delle parolacce, quindi sono insulti. E questo non stupisce: nelle sue canzoni, De Andrè prende posizione apertamente, e gli insulti non sono altro che giudizi sommari di condanna verso una persona nella sua totalità. Ma che genere di insulti preferiva De Andrè? Quelli che disprezzano la mancanza di intelligenza (5): idiota, scemo, cialtrone, cretino, nèsciu. Ma ha altrettanto peso il disprezzo per chi si comporta in modo scorretto (4): cialtrone, carogna, galûsciu, infame. Sono tutti insulti che squalificano personaggi tronfi, disonesti, ignoranti.
E poi c’è una serie di insulti sulla morale sessuale: 4 sulle prostitute (puttana, bagascia, vacca, troia), e i corrispettivi maschili che designano i sessuomani (porco) e gli sfruttatori delle prostitute (pappone, xàtta).
Ma attenzione: come molti sanno, De Andrè frequentava le prostitute, e almeno con una si fidanzò («Prima di incontrare mia moglie ho conosciuto e amato, molto amato, una donna di strada. Però sono stato vigliacco e ipocrita: ecco, qui sono rimasto borghese. No, non l’avrei mai sposata»). Quindi di certo non le disprezzava: anzi, di loro diceva che «Sono semplici, spontanee, hanno le loro grandi crisi ma si spaccano come meloni, sono aperte e non piangono mai». Il termine spregiativo “puttana”, in realtà, è usato per incarnare la morale comune (la “morale borghese”, come la chiamava). Ed è anche un modo crudo di descrivere un mestiere crudo.
Ma quale peso hanno, in media, le volgarità scelte da De Andrè? Sappiamo che le parolacce non sono tutte uguali: alcune hanno un impatto più forte di altre, come ho mostrato col volgarometro. Difficile però valutare le scelte lessicali di De Andrè: se si escludono “coglioni”, “vaffanculo”, “puttana” e “idiota”, i termini volgari in genovese – nella sua percezione personale – li considerava meno pesanti. «A Genova, chiunque dica mussa o belìn non provoca alcuno scandalo, ma se lo dici in italiano casca il mondo». Dunque, nella sua ottica, ha usato per lo più scurrilità di intensità media.
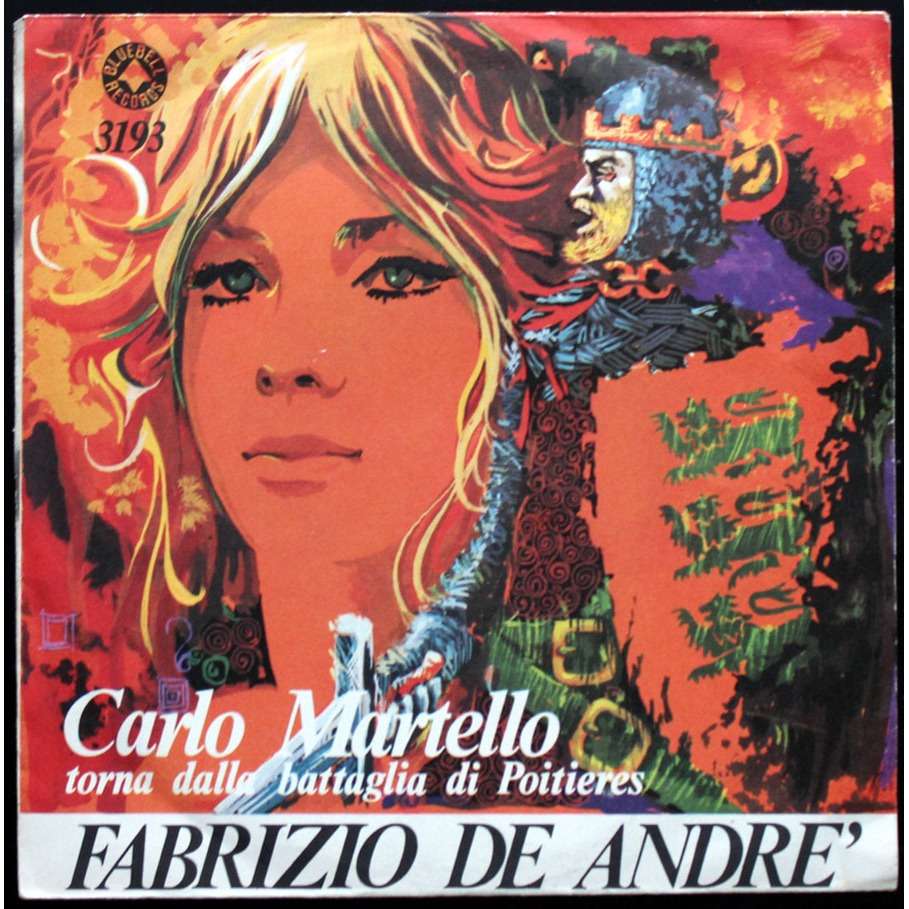
Copertina di “Carlo Martello torna dalla battaglia di Poitiers” (1962).
Inserire parolacce nelle canzoni non è indolore. Soprattutto in passato, quando la sensibilità verso le parole forti era molto più alta rispetto a oggi. E così De Andrè ha avuto qualche grattacapo legale: una delle sue prime canzoni, “CARLO MARTELLO RITORNA DALLA BATTAGLIA DI POITIERS” (1962) è un brano goliardico, che racconta, sotto l’apparente veste di una ballata celebrativa, il ritorno vittorioso dalle gloriose gesta belliche contro i Mori. Ma il re dei franchi quando vede una pastorella, la vuole concupire, scoprendo poi che è una prostituta. Al che Martello sbotta in un «È mai possibile, o porco di un cane, che le avventure in codesto reame debban risolversi tutte con grandi puttane». Il verso fu denunciato per oscenità, ma nel 1968 De Andrè fu assolto “perché il fatto non sussiste”. Il commento di De Andrè è illuminante sul suo uso delle parolacce come forma di sincerità: “Definire pornografica una pagina come Carlo Martello è inammissibile. A meno che per pornografia non si intenda chiamare le cose col loro vero nome, rifiutando l’ipocrisia dei doppi sensi e delle metafore. Con questa canzone ho voluto demitizzare quel certo alone che siamo abituati a porre intorno ai personaggi storici. Tendiamo a divinizzarli, dimenticando che furono uomini come noi, con voglie e difetti umani. La mia, dunque, non è oscenità ma lotta alla retorica”. La testimonianza svela in modo inequivocabile il rapporto di De Andrè con le parolacce: servono a chiamare le cose col loro nome. In quella stessa canzone, tra l’altro, il testo originale aveva anche un altro verso volgare, che però fu corretto prima di incidere il disco: il verso «frustando il cavallo come un mulo, quella gran faccia da culo» fu trasformato in: «frustando il cavallo come un ciuco, tra il glicine e il sambuco».
In “BOCCA DI ROSA” (1967), dedicata a una donna controcorrente, a cui piaceva il sesso e non lo nascondeva, era previsto un verso che diceva: “spesso gli sbirri e i Carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l’accompagnarono al primo treno”. Ma lo spregiativo “sbirri” non piacque all’Arma, che chiese a De Andrè di correggere il testo. Che diventò: “Il cuore tenero non è una dote di cui sian colmi i Carabinieri, ma quella volta a prendere il treno l’accompagnarono malvolentieri”.
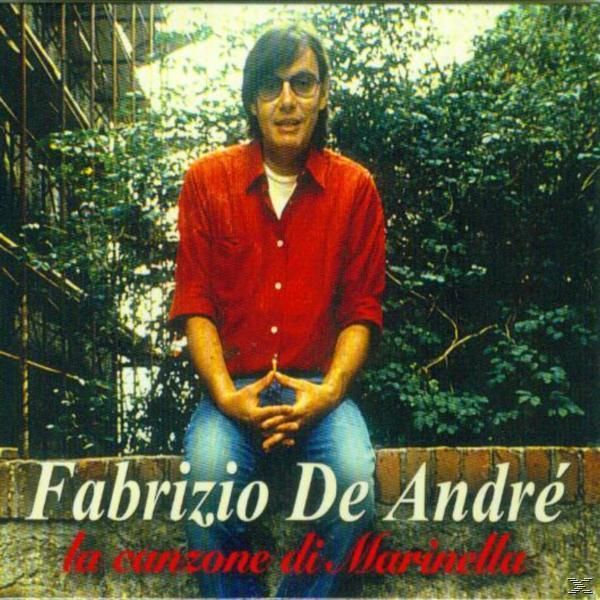
Il singolo della “Canzone di Marinella”.
Anche “LA CANZONE DI MARINELLA” (1968) – dedicata a una prostituta di 33 anni, Maria Boccuzzi, trovata uccisa in un fiume alla periferia di Milano – era nata in origine come canzone “quasi pornografica, molto spinta”, raccontò De Andrè. “Poi una persona che allora mi era particolarmente vicina mi ha fatto capire che quella canzone poteva diventare un grosso successo, e ne è venuta fuori una canzone a cui ci si poteva avvicinare tranquillamente, senza il pericolo di offendere la morale o il buon costume”.
Nella “CITTÀ VECCHIA” (1974), una canzone dedicata ai bassifondi di Genova, popolati da donnacce, ladri e ubriachi, c’era in origine un verso pesante: “quella che di giorno chiami con disprezzo specie di troia”. Fu corretto in “quella che di giorno chiami con disprezzo pubblica moglie”. E in un verso c’è la versione addolcita di un volgare modo di dire: “per dimenticare d’esser stati presi per il sedere” (invece che “per il culo”).
Sesso allusivo e sesso esplicito
Molti brani di De Andrè parlano di sesso. Descrivono le onde della passione, i rapporti amorosi, e a volte persino gli amplessi. Ma lo fanno, in genere, puntando su termini allusivi ed evocativi: “ANDREA” (1978) parla di un amore omosessuale, ma senza alcuna indulgenza (“Andrea aveva un amore, riccioli neri”). Nel “GORILLA” (1968) canta “con poco senso del pudore, le comari di quel rione, contemplavano lo scimmione, non dico dove non dico come” (gli guardavano il sesso). Nel “GIUDICE” (1971) allude alla diceria secondo cui le persone basse siano superdotate: “la curiosità di una ragazza irriverente, che li avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani: che siano i più forniti della virtù meno apparente, fra tutte le virtù la più indecente”.
Per quanto riguarda strettamente gli atti sessuali, nelle sue canzoni sono presenti diversi rimandi allusivi ma molto efficaci. In “AMICO FRAGILE” (1975) descrive l’eccitazione senza termini osceni: “Potevo stuzzicare i pantaloni della sconosciuta fino a vederle spalancarsi la bocca”. E così in “DOLCENERA” (1996) “il lenzuolo si gonfia sul cavo dell’onda, e la lotta si fa scivolosa e profonda”.
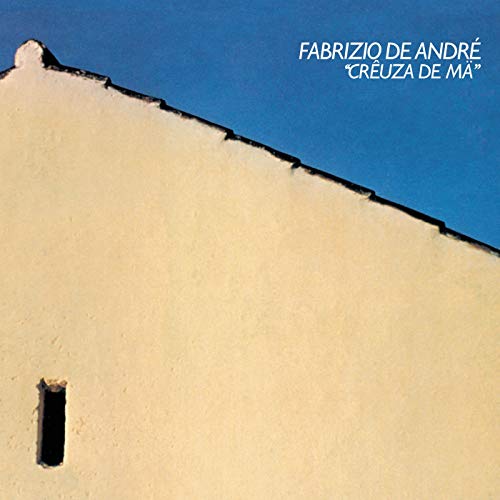
La copertina di ” Crêuza de mä ” (1984)
Ma la canzone più emblematica è “JAMIN-A” (1984), un brano fortemente erotico: parla dell’amplesso con una donna algerina dalla sensualità senza freni. De Andrè ha parlato di questa canzone in termini crudi e provocatori: «In Jamin-a descrivo una scopata che mi sono fatto. C’è qualcosa di erotico a un livello un po’ più alto che non “Ti spacco il culo brutta troiaccia”». La canzone, infatti, inizia con una descrizione allusiva (che qui traduco dal genovese): “Lingua infuocata Jamin-a, lupa di pelle scura, con la bocca spalancata, morso di carne soda, stella nera che brilla, mi voglio divertire, nell’umido dolce del miele del tuo alveare”. Poi il testo diventa decisamente diretto, contraddicendo – almeno in apparenza – il proposito dell’autore di “volare alto”: “Fatti guardare Jamina, getto di fica sazia, e la faccia nel sudore, sugo di sale di cosce, dove c’è pelo c’è amore, sultana delle troie” ( “Fatt’ammiâ Jamin-a, Roggiu de mussa pin-a. E u muru ‘ntu sûù, Sûgu de sä de cheusce, Duve gh’è pei gh’è amù, Sultan-a de e bagasce”).
Ecco come De Andrè spiega questa apparente contraddizione: «Mi sono nascosto dietro il dialetto genovese perché certe parole, che in italiano hanno un significato fortemente volgare, in genovese perdono questa connotazione. A Genova belìn, che individua l’organo genitale maschile, è un lubrificante del linguaggio, del tutto privo di valenza negativa. La stessa cosa per mussa, che invece indica l’organo genitale femminile e, per traslato, vuol dire balla».
Se vi è piaciuto questo articolo, su questo sito trovate le analisi delle canzoni di:
Elio e le storie tese (e videointervista a Rocco Tanica)
E anche:
Le canzoni più volgari d’Italia
Parolacce nelle canzoni: il primo censimento
Quelli che mettono parolacce nelle canzoni
Le “cazzate dorate” del Festival di Sanremo
Di questo post hanno parlato AdnKronos, l’Unione Sarda, il Corriere quotidiano.
Dedico questa ricerca alla memoria del mio amato zio Enzo Tartamella,
che al telefono, dalla Sicilia, ha guidato con frasi brevi e fulminanti
i miei primi passi nel giornalismo.
Mi mancheranno le nostre chiacchierate su tutto.
E le canzoni di De André da cantare insieme d’estate.
Mi sento molto più solo senza di te. RIP
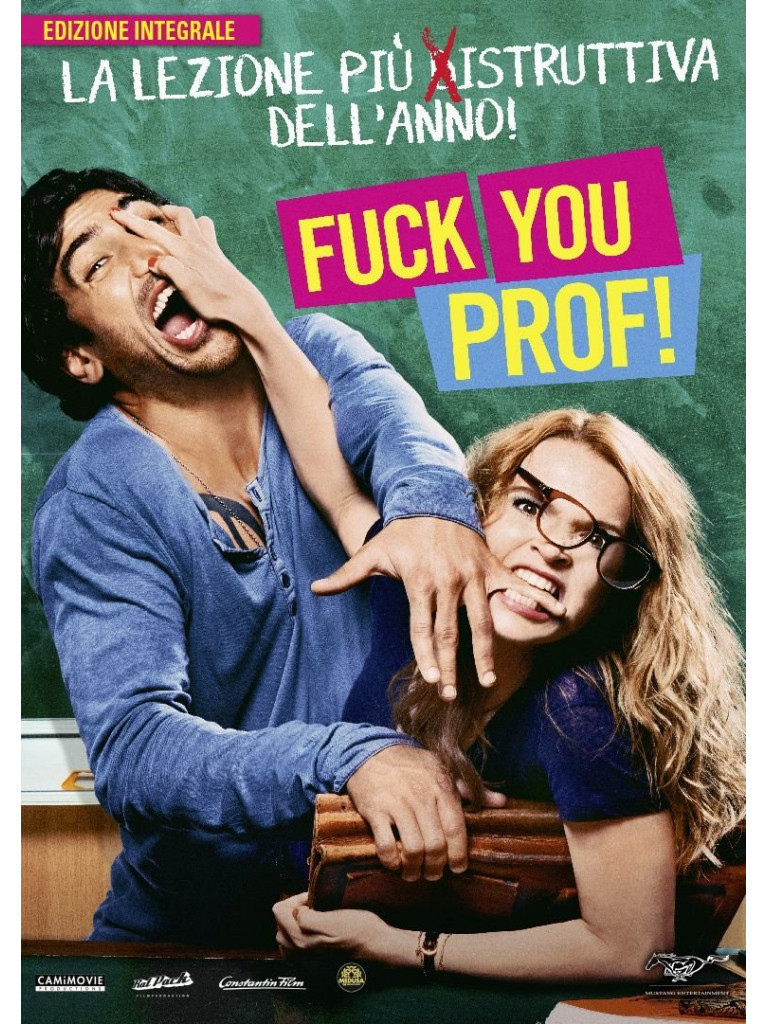
Locandina di “Fuck you prof”, film tedesco del 2013.
Lui lo definisce “una tecnica avanzata d’insegnamento”. E, in effetti, ha successo fra gli studenti. Non è l’ultimo modello di lavagna interattiva multimediale, ma il turpiloquio: secondo questo professore, dire parolacce crea un clima divertente e più confidenziale in classe. Permettendo così di lavorare sodo.
Parola di Jordan Schneider, docente d’inglese in un’università di New York, il Queensborough Community College. Forse non è l’unico insegnante a fare lezione con un linguaggio sboccato, ma è il primo a teorizzarlo (e farlo) apertamente. «Alcuni pensano che dire parolacce sia un trucchetto a buon mercato, una stampella per sostenere chi non ha forza linguistica» spiega. «A volte è così, ma è altrettanto grave chi usa un linguaggio oscuro, affettato o troppo complicato. Almeno con le parolacce gli studenti capiscono esattamente cosa voglio dire».
Dunque, non è un “cattivo maestro”, un docente in cerca di scorciatoie e facile notorietà: le sue riflessioni, che racconto in questo articolo, raccontano un modo vivace di fare didattica. Schneider, insomma, somiglia agli sboccati protagonisti dei film “Fuck you prof” o di “School of rock”, che però non erano veri insegnanti anche se si spacciavano come tali. Lui invece è un docente vero (esercita dal 2001) e ha successo: sul sito “rate my professor” ha raccolto giudizi lusinghieri (un rating di 4,5 su 5) da parte degli studenti. Che dicono di lui: “E’ il migliore. Ho imparato un sacco e mi sono divertito”.
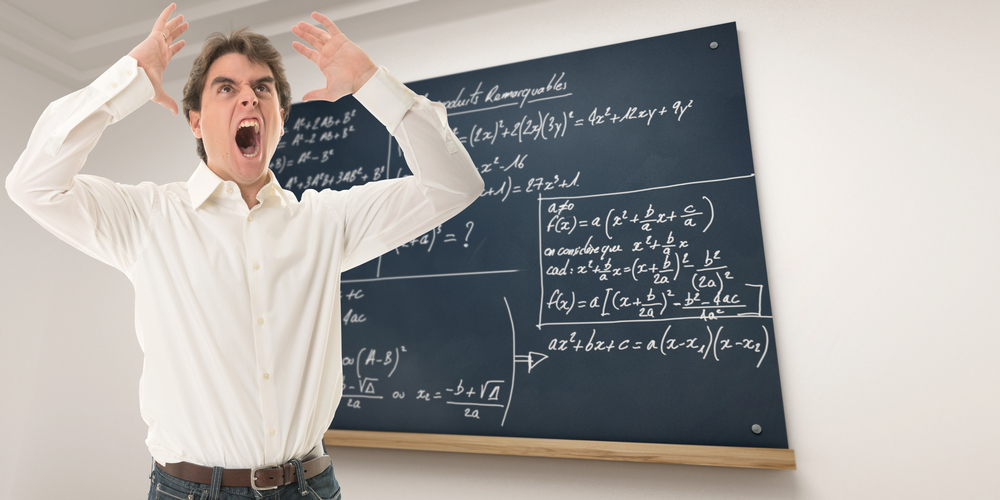
Un docente impreca in aula (foto Shutterstock).
Ha ragione? Il tema è d’attualità: sta iniziando un nuovo anno scolastico, e anche in Italia gli insegnanti stanno facendo i conti con le parolacce. Non tanto perché le dicono, quanto perché le ricevono: sono insultati apertamente dagli studenti. Uno scenario che, solo 10 anni fa, sarebbe stato impensabile.
Che cosa dovrebbero fare per difendersi? Insultare a loro volta? Denunciare? Far finta di nulla? E, in generale: come devono regolarsi i docenti col turpiloquio?
In questo articolo troverete le risposte, documentate con le ultime ricerche scientifiche sull’argomento. Ma non troverete una soluzione univoca: non è possibile solo l’alternativa manichea fra “non dire parolacce” o “dirle liberamente”.
Le parolacce sono un’enorme famiglia di termini. E si possono usare per gli scopi più diversi, per ferire ma anche per divertire, per emarginare come per coinvolgere, per prevaricare o anche per stabilire un rapporto alla pari. Dunque, alla domanda “Si possono dire volgarità in classe?”, la risposta è “dipende”. In questo articolo vi dirò da cosa.
Ma prima, una domanda nasce spontanea: come siamo arrivati a questo punto?
[ clicca sul + per aprire il riquadro ]
[ clicca sul + per aprire il riquadro ]
[ clicca sul + per aprire il riquadro ]
[ clicca sul + per aprire il riquadro ]
Questo articolo è stato rilanciato dal blog per studenti “Facce caso“.
The post I prof possono dire parolacce in classe? first appeared on Parolacce.]]>